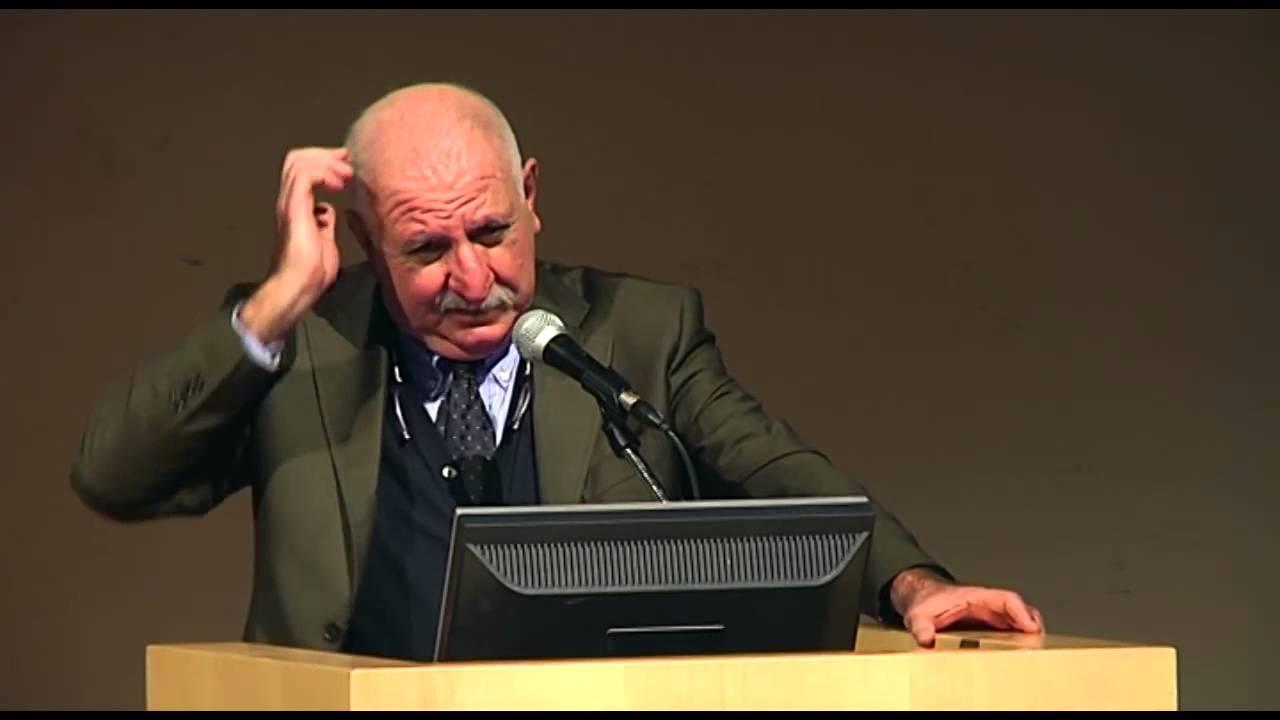A più di dieci anni, la grande crisi economica del 2008 lascia in dote la sensazione di essere entrati in una stagnazione secolare che rappresenta un vero e proprio salto di paradigma. Economia e democrazia non vanno più a braccetto, anzi la liberal-democrazia non favorisce più il successo economico. Come agire in questo cambiamento? Ne parliamo con Sebastiano Maffettone ,ordinario di filosofia politica alla LUISS, tra i massimi studiosi italiani di giustizia sociale. Il professore sarà ospite del prossimo workshop sull’impresa sociale di Riva del Garda (12 e 13 settembre).
Abbiamo da poco superato il decimo anniversario della grande crisi del 2008. Ci lascia in dote il dubbio di essere entrati in quella che alcuni chiamano “stagnazione secolare”, la certezza di un’Europa al bivio e alla ricerca di una sua ridefinizione, lo spaesamento di fronte ad una globalizzazione inceppata e ambivalente. È così?
È così. Anche se, in termini di stagnazione, farei una distinzione geografica. Si tratta di un fenomeno che investe soprattutto i Paesi occidentali, mentre in Oriente il clima è diverso. Nei Paesi orientali, nei contesti che ho occasione di frequentare per lavoro – università, istituti di ricerca, giornali, arene politiche – non prevale l’idea di una stagnazione quanto piuttosto una prospettiva di speranza nella crescita. Anche a livello europeo sono doverose delle distinzioni: penso alla situazione in Svezia – dove regna un ottimismo che consente di mettere al mondo più figli, alimentare il mercato del lavoro etc. – piuttosto che in Italia, dove a predominare è un forte pessimismo.
In effetti in molti Paesi occidentali, la stagnazione post crisi ha rappresentato un vero salto di paradigma. Quali sono le caratteristiche di questo cambio di schema dentro il quale siamo chiamati a intervenire?
Credo che il cambio di paradigma sia reso evidente dal fatto che la crisi economia e la crisi politica vadano a braccetto. Oltre alla stagnazione economica, infatti, è il modello politico occidentale dominante, ossia la democrazia, ad essere in crisi. Senza scomodare Karl Marx – che sosteneva che il sistema politico è una sovrastruttura di quello economico – il rapporto tra crisi economica e politica è evidente. Il salto di paradigma risiede nel fatto che, per la prima volta nella storia, a mio avviso, la liberaldemocrazia non favorisce più il successo economico. Non si tratta di un cambiamento di poco conto, molta letteratura si è spesa nel sostenere che la democrazia migliora l'economia. Lo stesso Amartya Sen – nel suo famoso libro sulle carestie – sosteneva che la responsabilità principale delle carestie non è la crisi economica ma la mancanza di democrazia.
Quali sono le conseguenze di questo cambiamento?
Sfiducia nei sistemi politici, mancanza di credibilità della politica, difficoltà a fidarsi degli altri. Si tratta poi di un cambiamento che comporta risultati teorici non banali. La grande crisi ha contributo ad incrementare una revisione sostanziale – iniziata in realtà molto prima – di quei fondamenti dell’economia basati sull’assunto che gli individui siano massimizzatori razionali. Secondo un pensiero generalmente attribuito ad Adam Smith (anche se trattasi di una’attribuzione discutibile), nel libero mercato la ricerca egoistica del proprio interesse gioverebbe – attraverso una mano invisibile – all'interesse dell'intera società e mirerebbe a trasformare quelli che costituiscono "vizi privati" in "pubbliche virtù" portando all'equilibrio economico generale. Questo modello classico di economia come scienza sta andando in frantumi. Nessuno è più convinto che il singolo, perseguendo i propri interessi personali, porti ad un risultato collettivamente vantaggioso.
Anche la teoria dell’impresa sta cambiando?
La teoria dell'impresa era notoriamente un'eccezione al sistema. Assumendo in termini molto generali che negli ultimi anni siamo vissuti in un sistema che potremmo chiamare capitalismo democratico, esso è sostenuto da due meccanismi fondamentali, il mercato ed il voto, che, per quanto diversi, hanno entrambi un funzionamento bottom-up: a partire da un equilibrio puntiforme a livello basso – attraverso una serie di preferenze micro nelle persone – si genera un equilibrio ad un livello più alto (ad esempio, la scelta del miglior Governo è il risultato della somma delle scelte individuali). In questo sistema, che – seppur con le dovute diversità – era più o meno isomorfo in economia e politica, l'eccezione era la teoria dell'impresa come meccanismo top-down (gli azionisti ed i manager comandano l’impresa secondo uno schema gerarchico). Da trent'anni a questa parte non è più così. Esiste una derivazione della teoria dell'impresa basata sulla cosiddetta stakeholder analysis, secondo la quale tutti devono avere voce in capitolo nella gestione dell'impresa. Questa è stata una rivoluzione non banale, che ha liberato spazio d’azione alla responsabilità sociale di impresa, all’impresa sociale, al social investment etc.
Lei è un grande studioso dell’opera di Rawls, secondo il quale una società giusta deve perseguire il maggior benessere possibile per il maggior numero di persone. Nella teoria di Rawls si legge anche le disuguaglianze di reddito sono giuste, perché legate ai meriti di ogni singolo individuo. Ci può spiegare meglio questo punto?
Rawls ha messo fortemente in discussione il merito, ritenendolo non un principio assoluto, ma dipendente dalle istituzioni sociali. Se Maradona fosse nato nel ‘500 non sarebbe stato Maradona. Supponiamo di essere nel 1950 e che due gemelli cinesi – Ching e Chang, e perdonatemi la scarsa originalità dei nomi – grandi chef e geni della cucina, vivano rispettivamente a San Francisco e a Shangai; quello di Shangai sarà probabilmente povero, mentre quello di San Francisco sarà ricco. Il merito dipende quindi dal fatto che esso possa pienamente esprimersi nel contesto in sui si vive. La teoria di Rawls si basa su due concetti di giustizia. Mentre sul primo sono tendenzialmente tutti concordi (ogni individuo ha un uguale diritto alla più estesa libertà fondamentale, compatibilmente con una simile libertà per gli altri), sul secondo c’è controversia, anche se personalmente ritengo sia un approccio interessante. Rawls, pur essendo un egualitarista, sottolinea come l’egualitarismo favorisca un levelling down (livellamento verso il basso), con una conseguente torta sociale più piccola da dividere in parti uguali per tutti. Infatti in un sistema puramente egualitario non ci sono gli incentivi, ma senza incentivi l’individuo è motivato a lavorare meno. Gli incentivi diventano quindi necessari per stimolare i talenti e per rendere la torta sociale più ampia. Il secondo principio di giustizia è concepito in modo che le disuguaglianze di reddito siano consentite – per poter assegnare gli incentivi – a patto che nel lungo periodo ne avvantaggino tutti, a cominciare da chi sta peggio (supponiamo ad esempio che un individuo guadagni più di altri, che però crei una grande impresa che dà lavoro a molti disoccupati; tutto sommato, se non gestisce l’azienda in modo terribile, porterà un migliorato benessere a molte persone, a partire dai più svantaggiati). Io sono abbastanza convinto che Rawls abbia ragione.
Se fino agli anni Settanta l’azione dello Stato per ridurre le disuguaglianze era molto più ampia (attraverso politiche sulla distribuzione del reddito, correzione degli esiti di mercato, presa in carico totale dei servizi di interesse generale), dagli anni Ottanta gran parte di queste azioni si sono ricollocate in contesti di mercato. Quale può essere oggi il ruolo delle imprese sociali – che agiscono proprio (ma non solo) nei servizi di welfare (sicurezza sociale, sanità, tutela dell’ambiente, istruzione etc.)? Hanno solo una funzione “riparativa” o possono essere tra i (principali) attori in grado di modificare i meccanismi che determinano ex ante la formazione e distribuzione della ricchezza?
Gradualmente stiamo andando dal welfare state alla welfare society. Lo Stato ha molte pressioni per aumentare i servizi di welfare (in quanto risulta sempre una carta vincente in fase di promesse elettorali), ma questo porta inevitabilmente ad un indebitamento eccessivo dello Stato, con conseguente crisi fiscale. La welfare society è la risposta: lo Stato fornisce le autorizzazioni necessarie, i cittadini si organizzano per creare nuove strutture di welfare, che dovranno garantire degli standard di efficienza (per coprire i costi) e di equità (per garantire uguaglianza di trattamento per tutti). Questi cittadini si assumono la responsabilità – attraverso l'associazionismo, l'impresa sociale (in senso ampio) etc. – di far funzionare le cose. Lo Stato, da mero gestore di tutti i servizi di welfare, evolve a regolatore di un sistema più ampio, che si adopera per favorire l’allargamento della presa in carica del welfare ad una platea di player del privato e privato sociale, concentrandosi sull’erogazione delle prestazioni veramente essenziali. Questo è un modello che si sta diffondendo moltissimo in tutto il mondo, in forme diverse in ogni paese. E si tratta di un cambiamento, a livello globale, molto importante, perché apre uno spazio enorme all’operare dell’impresa sociale.