Cultura
Come i social hanno ucciso la comunicazione (e perché)
Un tempo era di moda dire che il mezzo è il messaggio, intendendo così che la forma si mangiava allegramente il contenuto. Ma i social, oltre che il contenuto, si sono mangiati anche la forma. Rigettandoci indietro un flusso continuo di hashtag, slogan, massime urlate. Questa è ancora comunicazione? Probabilmente no, come raccontano i saggi raccolti da Guido Bosticco e Giovanni Battista Magnoli Bocchi nel loro ultimo libro
di Marco Dotti
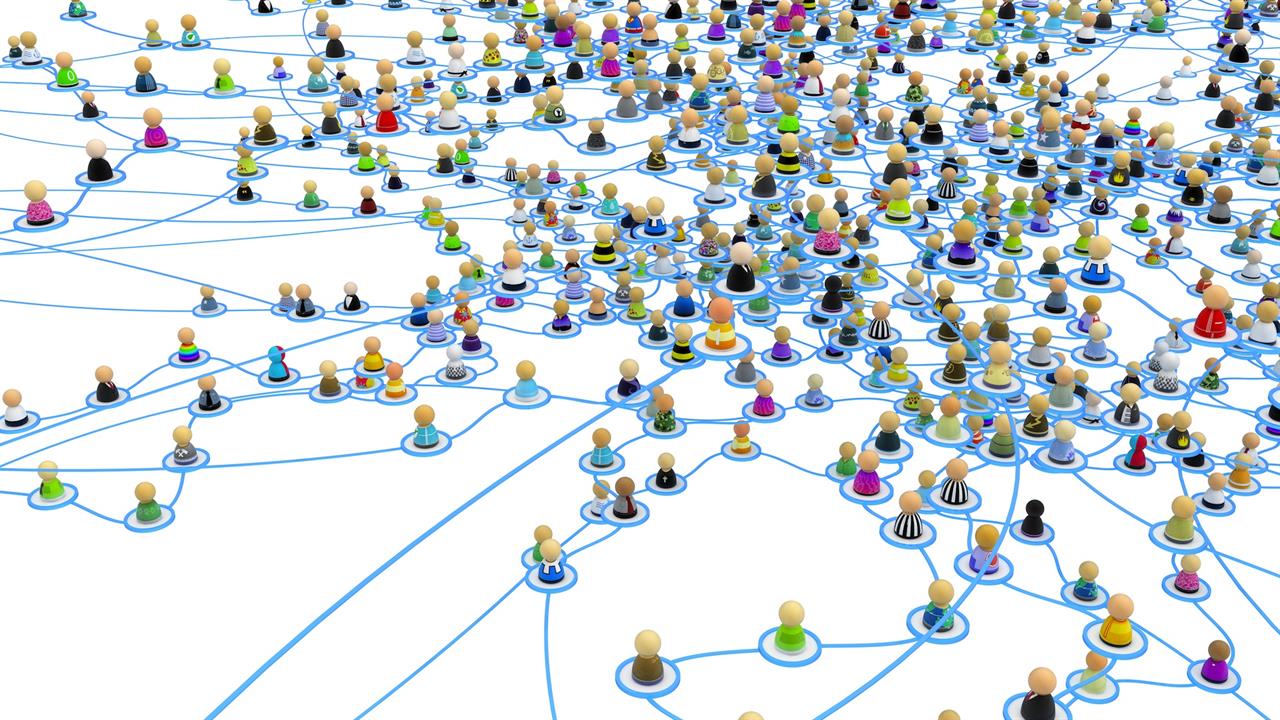
È un fatto di certo singolare, ma indicativo che il social network per antonomasia, Facebook, abbia inscritto nel nome proprio ciò che gli manca: il volto. Quest'assenza di volti, in tempi che sembrano appartenere a ere geologiche lontane (gli anni Novanta), era considerata all'origine di un fenomeno di cui molto si è discusso ma di cui nessuno, oggi, dibatte più: il flame.
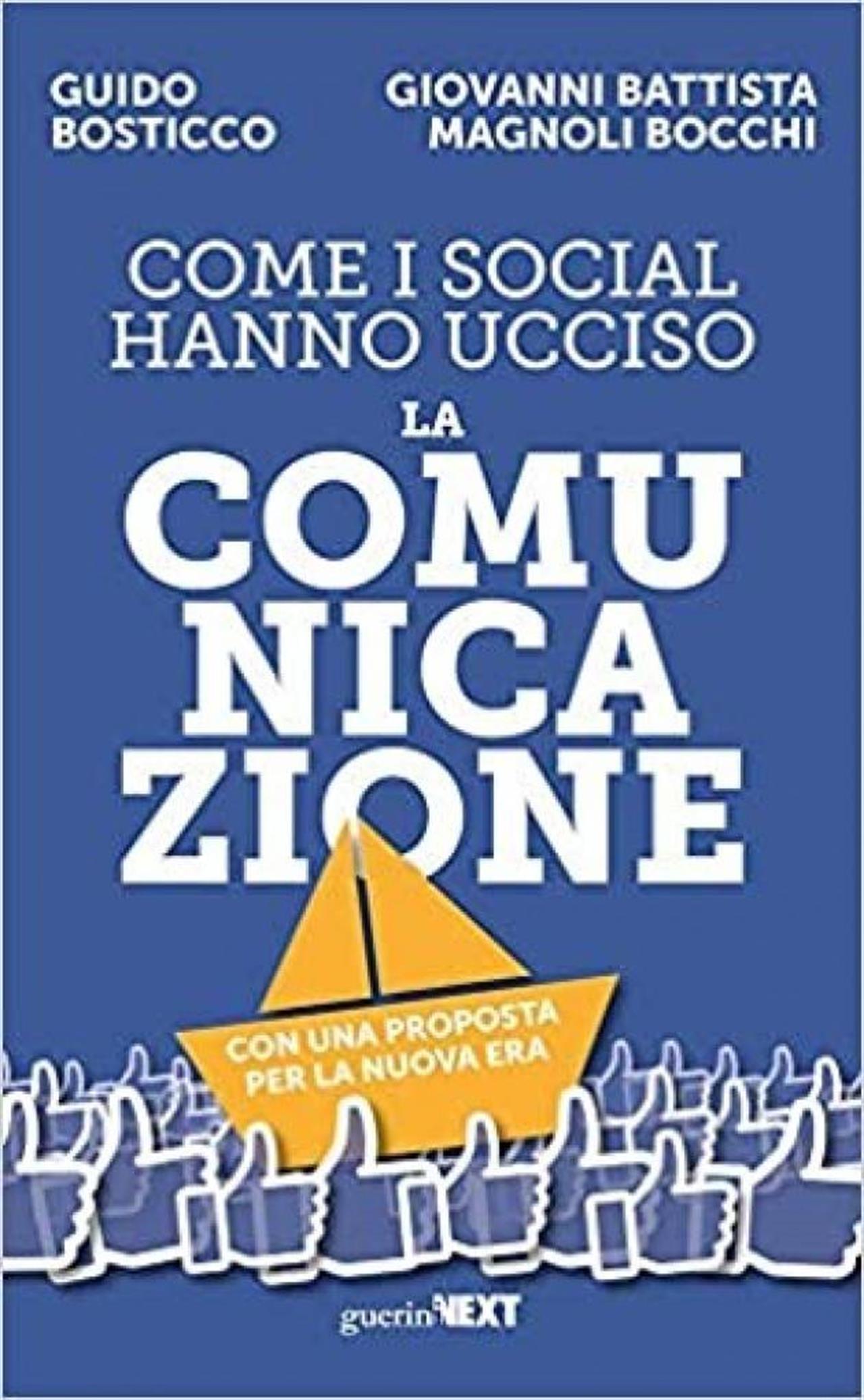
Letteralmente flame significa "fiammata" e indica una discussione molto accesa, al limite dell'aggressione. Inizialmente – erano i tempi delle mailing list e dei newsgroup – il fenomeno, benché molto noto, era abbastanza circoscritto. Ma se ne parlava e si creava un certo dibattito critico.
Scavando nell'archeologia della rete è facile imbattersi in un caso, forse il primo, che già negli anni Settanta vide scatenarsi un flame epocale. La miccia fu una discussione su come intestare i messaggi di posta elettronica. Roba da ingegneri, non da fuori di testa. Eppure… Il tutto avvenne in un gruppo ristretto, un gruppo tecnico, ma la violenza fu tale che il creatore del gruppo, Ken Harrenstein, arrivò a descrivere i propri colleghi come «un branco di belve integraliste intente ad accanirsi sulla carcassa di un cavallo».
Ma con l'avvento dei social network la categoria del flame, dopo aver prodotto fiumi di letteratura "psy", è stata in gran parte "sussunta" in quella dell'hating e dell'hate speech e, più in generale, dell''odio in rete. Altra storia, altra letteratura, altri dibattiti. Per lo più a vuoto.
Quella dell'odio in rete, in sintesi, è una categoria che attacca l'identità online, rovesciandosi su quella offline – alla prima inevitabilmente interconnessa – del soggetto. Ma il volto, anche in questo caso, non c'è. Non essendoci un volto (a dispetto del social network che vi si richiama), non c'è l'altro. C'è (forse) solo un'espansione infinita del sé.
Leggendo i saggi raccolti nel nuovo libro di Guido Bosticco e Giovanni Battista Magnoli Bocchi, Come i social hanno ucciso la comunicazione (Guerini Next, pagine 176, euro 15), si potrebbe avanzare un'ipotesi: che sia proprio la presenza di un volto che non è un volto, un volto statico e mai empatico, come l'immaginetta sul profilo, a favorire questa dinamica? C'è chi ha visto in questa logica una dimensione tipica di simulacri e idola (Baudrillard, Perniola) dove il sé, anche quello più profondo, diventa quantified self: insieme di dati estrapolati che ricodifica la vita stessa di un soggetto comunque consegnato a una realtà che non è più tale per "eccesso di realtà". E c'è chi, in tutto questo, vede un piano gnostico di cadute senza fine. Troppo complicato.
Resta un fatto: se anche il "sé" diventa un mero effetto del sistema di like e rating nel mercato globale dei social (il cosiddetto: I-Commodity Market: ognuno di noi è un fascio di dati e questi dati hanno un loro borsino merci), che dire della comunicazione? Né mezzo, né messaggio, ma mero flusso indistinto. I comunicatori? «Sono come i conduttori elettrici, angeli vuoti senza nessun messaggio da portare», ironizzava anni fa il sempre caustico Peter Sloterdijk.
Ecco perché i saggi raccolti nel libro di Bosticco e Magnoli Bocchi – saggi firmati, oltre che dai curatori, da Arianna Girard, Elia Belli, Guido Mariani, Roberta Franceschetti – , ancorché di piacevolissima lettura, colpiscono il cuore il problema affrontandolo da molte angolazioni.
- In primo luogo operano smontando e decifrando i meccanismi di una comunicazione che non è più comunicazione, ma saturazione a mezzo hashtag, slogan, claim….
- In secondo luogo, si attivano decostruendo in forma divertita (ma non troppo) i "miti" che si sono creati attorno alla "rivoluzione" social: "nuova" democrazia, inclusione, roussovismo 2.0 e via discorrendo.
- In terzo luogo, elaborando una proposta. Una via d'uscita, non di fuga.
Torniamo al tema dei volti, perché ci sembra che la via d'uscita sia lì. Martin Buber, citando il rabbino di Kock. racconta che vi è idolatria «quando un volto si rivolge riverente a un volto che non è un volto». Che volto "siamo", dunque, quando ci rispecchiamo nei social? Che cosa comunichiamo, quando "comunichiamo" consegnandoci dalla testa ai piedi ai loro algoritmi? Siamo più o siamo meno di noi? Siamo ancora volti? Ci esprimiamo ancora? O siamo fermi, statici, come certe maschere che non possono più cadere, perché dietro c'è il nulla?
Nel suo saggio finale, Bosticco richiama una bella riflessione del filosofo Giorgio Colli che, a proposito di espressione scriveva: «ciò che è spremuto è più ricco della spremitura». Esprimere è spremere, mettendo a fuoco le diversità che ci abitano. Comunicare è espiremere, ma non è tutto. Eppure in quel "non è tutto" c'è tutto. C'è il volto.
A ben vedere, se volessimo condensarlo in una "spremitura", a questo bel libro si adatterebbe quanto Alberto Arbasino sciveva nel suo Super-Eliogabalo: «Senza pietre di paragone/ né pretese di perfezione/ se ragiono/ a tono/ funziono/ a una condizione/ diventare ciò che sono/ non chi impersono».
Ma i libri conviene leggerli perché, si sa, anche per loro vale la regola che ciò che è spremuto è più ricco della spremitura. Piccolo consiglio per le vacanze, dunque.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.
