Innovazione e impatto
Amministrazione condivisa: formare gli attori del cambiamento sociale
In una società sempre più fragile, attraversata da bisogni crescenti, la governance collaborativa è una risorsa strategica. L’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Sussidiarietà lanciano un corso di Executive Education rivolto ai professionisti della Pubblica amministrazione e del Terzo settore, per ripensare le relazioni reciproche. L’obiettivo è fornire competenze avanzate e strategie innovative capaci di incidere concretamente sulla struttura sociale dei territori

Governance e strategie per l’amministrazione condivisa. È la nuova proposta di formazione messa in campo da Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Sussidiarietà. Un corso di Executive Education che si rivolge ai professionisti del mondo della Pubblica amministrazione e del Terzo settore per ripensare le relazioni reciproche secondo logiche collaborative e rispondere efficacemente al bisogno di innovazione nella Pubblica amministrazione e di erogazione di servizi a valenza sociale.
Gli strumenti di una governance collaborativa richiedono una manutenzione costante per poter essere innovativi in tutta la filiera, fino all’utente finale
Lorenza Violini, docente di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato all’Università degli Studi di Milano
In cattedra, i massimi esperti italiani su questi temi per una proposta che vede Anci Lombardia, Secondo Welfare e Fondazione Terzius nel ruolo di partner. Nove moduli complessivi di cui sette online, il venerdì, da dicembre ad aprile. La direzione scientifica è affidata a Barbara Boschetti, docente di Diritto amministrativo presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Lorenza Violini, docente di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato all’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza. Le abbiamo intervistate.
Superare una visione gerarchica e burocratica
«L’idea di questo Corso Executive nasce da una storia di relazioni con i funzionari della Pubblica amministrazione in vari comuni italiani, primo fra tutti il Comune di Milano, che stanno usando questi strumenti da tempo per riorganizzare al meglio, in rapporto con i soggetti sociali, l’erogazione dei servizi tramite gli strumenti innovativi previsti dal Codice del Terzo settore», spiega la professoressa Violini. «In realtà, la storia dell’amministrazione condivisa è più risalente e così lo sono gli altri strumenti utili a creare partnership pubblico-privato, visto che una visione gerarchica e burocratica, in cui gli enti del Terzo settore sono strettamente funzionali alle strategie del pubblico, ha mostrato alcuni limiti che la cultura dell’amministrazione condivisa si propone di superare».

La proposta formativa si rivolge a tutti coloro che sono coinvolti sia con la Pubblica amministrazione sia con gli enti del Terzo settore: «L’obiettivo è renderli capaci di attivare tutti gli strumenti oggi a disposizione; di tali nuovi strumenti è importante anche capire e approfondire la sottostante visione culturale e giuridica che ha come punto di riferimento – non solo ideale – il principio costituzionale di sussidiarietà», aggiunge Violini.
Rispondere ai bisogni in modo innovativo
In una società sempre più fragile, attraversata da bisogni crescenti, l’amministrazione condivisa è una risorsa strategica. «Offre due risposte», spiega la professoressa Boschetti: «la prima riguarda il metodo e la seconda ha a che fare con il risultato. L’amministrazione condivisa, come dice la parola stessa, richiede la creazione di sinergie comunitarie che vadano oltre la distinzione tra pubblico e privato, profit e non profit, e che sappiano collegare l’intera comunità, valorizzando l’apporto di ogni soggetto coinvolto, compresa l’utenza. È condivisa nel metodo, ma è anche in grado di offrire soluzioni condivise per superare le attuali tensioni: è uno straordinario strumento per la progettazione di risposte innovative ai bisogni della società contemporanea».
L’amministrazione condivisa è una grandissima sfida alla mentalità e agli approcci dominanti. Il baricentro non è più sul chi fa che cosa ma sul design e sulla progettazione delle politiche pubbliche
Barbara Boschetti, docente di Diritto amministrativo all’Università Cattolica del Sacro Cuore
Mettere a terra il principio di sussidiarietà
La Pubblica amministrazione e il Terzo settore oggi possono incidere sulla struttura sociale dei territori. «La chiave è una conoscenza approfondita del senso del principio di sussidiarietà, un principio che ha subìto varie evoluzioni nel tempo e che oggi significa soprattutto che non si può più pensare per compartimenti stagni ma occorre ragionale e agire in termini sussidiari. Significa, in estrema sintesi, progettare, attivare, rispondere ai bisogni e mettere a terra progettualità insieme», spiega Violini. Il nuovo corso pensato da Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondazione Sussidiarietà si propone di rendere concreto il significato di questa parola: insieme. «Lo faremo tramite percorsi partecipati, tramite lo sviluppo di azioni e il loro miglioramento costante per un cambiamento nella struttura delle risposte ai bisogni. Saper utilizzare strumenti tradizionali come tavoli, commissioni e gruppi di lavoro con metodologie aperte all’apporto di tutti, compresi gli utenti, oggi è oltremodo cruciale».
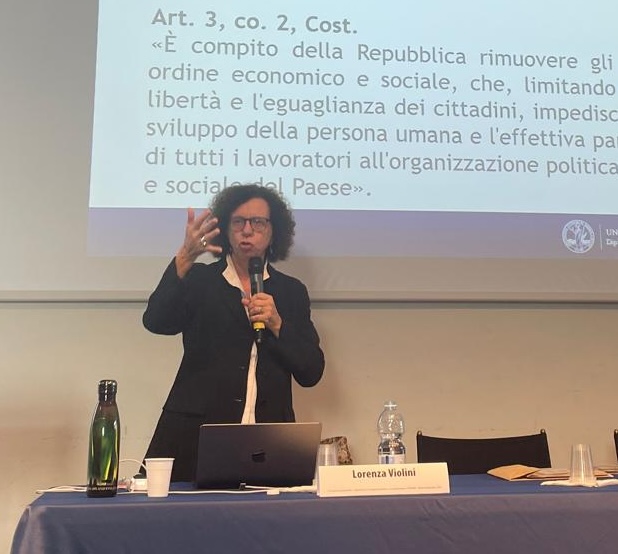
Boschetti riflette su un altro tema fondamentale, quello delle competenze: «Questo saper usare e mettere a terra il principio di sussidiarietà richiede competenze diverse dal passato tanto in chi lavora nella Pubblica amministrazione quanto nei soggetti del mondo non profit. Non basta conoscere le regole; bisogna saperle far atterrare. Servono skills relazionali e di gestione delle sinergie, oltre a quelle di progettazione e coordinamento tra strumenti di carattere giuridico e non». L’amministrazione condivisa, continua la professoressa, «richiede una mente aperta, perché le prime barriere alla condivisione sono di carattere mentale e culturale. Il Corso Executive in Governance e strategie per l’amministrazione condivisa è strutturato per fornire ai suoi partecipanti competenze innovative e di carattere trasversale per essere all’altezza delle sfide dell’amministrazione condivisa».
Un punto di partenza, non di arrivo
Quale tipo di politiche pubbliche potranno nascere da questo percorso formativo? «L’amministrazione condivisa è una grandissima sfida alla mentalità e agli approcci dominanti», risponde Boschetti. «Il baricentro non è più sul chi fa che cosa ma sul design e sulla progettazione delle politiche pubbliche. Oggi non si pianifica soltanto un servizio ma un intero mercato». Una sfida, aggiunge Violini, che «è già stata vinta in alcuni ambienti istituzionali. La Corte costituzionale, ad esempio, più di una volta ha sottolineato la necessità di un nuovo rapporto tra pubblico e privato in dialogo con i bisogni della società civile. E, tuttavia, gli strumenti di una governance collaborativa richiedono anche altro, ovvero una manutenzione costante per poter essere innovativi in tutta la filiera, fino all’utente finale». Per questo, conclude Boschetti, «l’amministrazione condivisa non è mai un punto d’arrivo ma un punto di partenza sempre aperto a revisioni, valutazioni, monitoraggi e miglioramenti».
Tutte le informazioni sull’Executive Programme a questo link. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 dicembre. Per chi sceglie di iscriversi entro il 30 ottobre, è prevista una tariffa agevolata.
In apertura, fotografia The Climate Reality Project su Unsplash. Le immagini nel testo, sono state fornite dalle intervistate
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
