Filosofo, storico della psichiatria e della medicina, per molti anni docente all'Università di Padova, Mario Galzigna è scomparso ieri all'età di 76 anni. Autore di libri e studi importanti come La malattia morale. Alle origini della psichiatria moderna (Marsilio, 1988), curatore di molte opere di Foucault, di Robert Castel e Biswanger, Galzigna ha svolto un ruolo importante per la comprensione dello stigma e l'analisi dei processi culturali legati alle pratiche di cura. Riproponiamo un'intervista che avevamo realizzato con lui nell'autunno del 2009.
* * *
«In fondo, per me la questione non era tanto quella di conoscere che cosa passa nella testa dei pazienti, quanto di che cosa passa nell'interazione fra i medici e i pazienti».
Sono parole di Michel Foucault, abbandonate per strada al termine della sua esperienza come psicologo alla clinica Saint-Anne di Parigi. Una clinica dove a Foucault veniva in parte negata “cittadinanza”: non era medico, non era psichiatra, non sapeva sedare o contenere i pazienti, né fare loro un'iniezione. Un operatore altro, rispetto alla professione medica tradizionale era considerato se non di troppo, quanto meno inutile, come un attore fuori campo.

Fuori campo: clinica e critica
Lei si trova in una posizione in qualche modi simile a quella del filosofo francese, non è uno psichiatra né uno psicoterapeuta, ma da alcuni anni sta conducendo un esperimento di epistemologia clinica nei dipartimenti dî Salute mentale, a fianco di medici e pazienti. Un'esperienza raccontata e tematizzata nel Mondo nella mente (Marsilio, Padova 2007). Un libro che affronta le questioni della cura e del disagio psichico partendo da una considerazione della mente come «un microcosmo abitato dal mondo».
Lei, quindi – destino affatto singolare per uno studioso di Foucault – si trova in una posizione in qualche modo simile a quella del filosofo o francese. Ci può spiegare in che cosa consiste questa sua esperienza e soprattutto che cosa ci) a un epistemologo in un luogo di cura?
Non sono uno “studioso” di Foucault. Sono, più semplicemente e più modestamente, uno che lo utilizza per le sue ricerche: uno che ha utilizzato la “scatola di attrezzi” di Foucault.
Foucault stesso usò a più riprese questa espressione “scatola degli attrezzi”…
La usò per elaborare e portare avanti, tra le altre cose, anche un'epistemologia clinica: un'epistemologia della psichiatria elaborata nel cuore stesso del dispositivo psichiatrico. Al centro del mio lavoro c'è sempre una pratica: anche nel lavoro relativo all’epistemologia della cura. Voglio essere chiaro e, almeno in questo, voglio essere fedele ad uno stile di pensiero specificamente “foucaultiano”: non mi interessa produrre teorie astratte, ma lavorare sulle pratiche. Lavorarci come filosofo, visto che la mia formazione è filosofica. Se c'è una cosa che caratterizza in modo continuativo e pregnante l’opera di Foucault, è proprio questa tensione dinamica tra pratica e teoria: una non può vivere separata dall'altra. Si tratta di una tensione ineliminabile, soprattutto se si affronta un tema come quello della cura.
Per me la cura è la cifra ontologica della presenza; è una dimensione “carica di mondo” e non può essere confinata negli ambiti angusti e asettici di un approccio intellettualistico.
Mario Galzigna
La cura non viene da me concepita come cifra ontologica della presenza; è una dimensione “carica di mondo” e non può essere confinata negli ambiti angusti e asettici di un approccio intellettualistico. Il mio lavoro sull'epistemologia della cura nasce all'interno di una certa cornice istituzionale (quella dei Dipartimenti di Salute Mentale), dove sono stato più volte chiamato per creare sinergie, interazioni significative e produttive tra differenti approcci al malato psichiatrico. Proprio all'interno del Dipartimento di Salute Mentale, proprio all’interno dei servizi psichiatrici, ho praticato (e non “teorizzato”) l'epistemologia clinica.
Un'epistemologia del dialogo e della connessione: la cura
Veniamo al punto e rispondiamo: che cosa ci fa un epistemologo all'interno di un Dipartimento di Salute Mentale?
Un gruppo di curanti all'interno di un servizio psichiatrico è sempre un insieme eterogeneo, che viene assemblato per i motivi più disparati: motivi di tipo geografico, motivi inerenti le carriere individuali, le vicissitudini, le vicende personali determinate da trasferimenti professionali o da ragioni private: non esiste, in generale, un dipartimento strutturato attorno ad una scelta qualitativa razionale e motivata dei collaboratori.
L'équipe, lo ripeto, è l'esito di un assemblaggio fortemente condizionato da fattori contingenti o addirittura casuali. Questa dimensione istituzionale complessa, che non è quasi mai il frutto di una progettazione coerente e centralizzata, comporta non poche difficoltà, non pochi svantaggi. Potremmo anche dire: far funzionare i curanti come gruppo all'interno dell'istituzione psichiatrica è una sfida. Per andare al sodo, adottando un'ottica realistica, occorre ammettere che nella maggior parte dei casi il gruppo non funziona, perlomeno nelle prime fasi della sua attività, secondo criteri di omogeneità e di coerenza interna.
L'epistemologia della cura può anche essere definita un'epistemologia del dialogo e della connessione
Mario Galzigna
Quale è, dunque, in questa situazione, la funzione di un epistemologo? Che cos’è l'epistemologia della cura? L'epistemologia della cura è una pratica di interconnessione e l'epistemologo deve mostrare le connessioni tra i vari paradigmi che sono “nella testa” dei singoli operatori della cura. Questo avviene nel migliore dei casi, perché un operatore che segue un paradigma è comunque qualcuno che ha studiato o studia, che si informa o si aggiorna, qualcuno che comunque delle domande se le pone. Spesso, però, le cose non sono così nobili o elevate e, più che di paradigmi e di conseguenti pratiche della cura, potremmo parlare di “praticacce”.
Il compito di un epistemologo, in questo contesto, e verificare la presenza, sul campo, di una certa varietà di approcci favorendone l'interazione e l'integrazione. L'epistemologia della cura, in questa prospettiva, può anche essere definita un'epistemologia del dialogo e della connessione.
È una questione cruciale, non solo per l'efficacia della cura…
Infatti. Ne va della credibilità del servizio stesso: l'efficacia della cura sarà una variabile dipendente della interazione/integrazione che si riesce a produrre, in loco, tra i vari paradigmi e tra i diversi momenti della terapia. Chi cura il paziente a livello ambulatoriale e a livello di SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura) nei casi gravi dopo un trattamento sanitario obbligatorio e usa neurolettici di prima e di seconda generazione, non deve mettere in campo una presa in carico del malato che sia radicalmente altra da quella, ad esempio, dello psicologo clinico che di pomeriggio, nel Day-Hospital, segue gli stessi pazienti che al mattino stavano in SPDC e li gestisce con una psicoterapia di gruppo (a orientamento psicodinamico, sistemico, cognitivo-comportamentale, eccetera). Sarebbe un disastro se tra i due momenti della cura, necessariamente diversi ed eterogenei, non venisse garantito nessun livello di continuità, di coerenza, di armonizzazione. Ho fornito, nel mio libro, argomenti concreti a favore di questa necessaria continuità.
Chiedendosi che cosa significhi amare qualcuno, Gilles Deleuze e Félix Guattari si davano questa risposta che mi pare significativa: amare qualcuno significa coglierlo in una massa, estrarlo da un gruppo, anche ristretto, a cui partecipa (…) e poi cercare le sue proprie mute, le molteplicità che racchiude in se stesso e farle penetrare nelle mie e nelle sue
Mario Galzigna
Questa continuità, tuttavia, è spesso carente: un semi vuoto che lascia segni profondi non solo sui pazienti, ma anche sul lato per così dire interno della cura. È un problema che percepiamo poco nella sua dimensione complessa, abituati dai media a giudicare in base alla dicotomia “servizio-disservizio”?
Sì, e spesso succede che i registri di presa in carico siano talmente diversi che, avendo a che fare con malati psichiatrici gravi ad esempio psicotici devastati da scissioni e da frammentazioni non si fa altro che aumentare, che aggravare il peso di queste scissioni, di queste frammentazioni.
Le frammentazioni già presenti nel paziente vengono moltiplicate dalle frammentazioni e dalle disarmonie presenti nel gruppo dei curanti. Come può non venirne compromessa la cura? La causa di tutto ciò è la disunione tra i membri del gruppo dei curanti, l'assenza di una interconnessione (anche epistemologica) tra di loro; è un problema di fondo, ma quasi mai reso esplicito. Non se ne parla, talvolta perché è preferibile alimentare la retorica del “fare gruppo”, talaltra perché anche in assoluta buona fede questa frammentazione, questa disunione non viene percepita come tale se non diventa aperto conflitto.

Questo aspetto del problema viene troppo spesso trascurato anche nei trattati teorici di “gruppo-analisi”, proiettati più al dover-essere del gruppo che ai motivi concreti (anche istituzionali, pratici) del suo cattivo o imperfetto funzionamento. Molto spesso, la mancata integrazione o interazione tra operatori (e conseguentemente anche tra paradigmi) trova le sue ragioni in una certa rigidità delle funzioni e delle stratificazioni gerarchiche necessariamente presenti in un Dipartimento di Salute Mentale. Un esempio: i bei lavori di Antonello Correale sull'importanza del gruppo nel lavoro terapeutico (penso soprattutto al suo saggio sul campo istituzionale) sono più proiettati sul dover essere del gruppo che sulle ragioni pratico-istituzionali del suo cattivo funzionamento e delle sue crisi.
Connettere il disperso
In questo campo, l'analisi teorica non può quindi prescindere da una valutazione e da una valorizzazione delle pratiche.
È proprio così. La teoria si muove sempre su piani astratti, la pratica è una “teoria” che si è sporcata le mani. Fare epistemologia clinica significa favorire l'interazione tra parti diverse, settori diversi e persone diverse. Creare sinergia è un problema epistemologico, ma diventa anche una questione etica e personale, perché l’epistemologo ha a che fare con temperamenti, caratteri, storie e chiusure diverse e si trova a doversi mettere in gioco in prima persona. È successo anche a me, quando ho iniziato a occuparmi da dentro della questione, vivendo e lavorando a stretto contatto con un'équipe medica e con i “suoi” pazienti.
C'è qualcosa di Michel Foucault anche in questo…
Io ho seguito, se vuole, l'indicazione foucaultiana: «Dai saperi alle pratiche». La teoria deve procedere, deve trasformarsi in pratica altrimenti è inefficace flatus vocis. Questo si vede nel mio libro I/ mondo nella mente’ che è ha avuto esattamente tale matrice: è un campo discorsivo che nasce da delle pratiche cliniche di interazione tra i paradigmi, problema squisitamente epistemologico, o di interazione tra le persone, problema umano tout court.
Partendo da un Dipartimento di Salute mentale, bisogna però considerare che ai paradigmi che lo animano o lo agitano “da dentro” vanno poi aggiunti quello che lo impattano ‘da fuori”. Il mondo del lavoro è cambiato in questi anni, il postfordismo e la crisi del wel are state hanno precarizzato anche la dimensione delle professioni della cura…
La globalizzazione ha i suoi costi e i suoi effetti. Però, nell'era del lavoro immateriale, dei mondi virtuali, del decentramento dell'io, della multiculturalità e delle ibridazioni identitarie, produrre una dialettica tra l’alterità interna e l’altro significa usare positivamente (o almeno sforzarsi di farlo) l'orizzonte della globalizzazione. Per questo è importante conosce l’alterità, da quella che vive in noi a quella che sta fuori di noi. Nell'ambito delle scienze psichiche, il rinnovamento dell'orizzonte terapeutico passa anche attraverso la capacità del curante di riportare questa dialettica tra l'alterità interna e l’altro, l’altro in carne e ossa, dentro la quotidianità della clinica. C'è interazione, e qui torniamo a una matrice foucaultiana, tra cura di sé e cura dell’altro, tra lo sguardo su di sé e lo sguardo sull'altro.
Nel momento in cui prendi in carico qualcuno, prendi in carico te stesso. Nel momento in cui ti prendi realmente cura di te non rinserrandoti nel cinismo o nell’egoismo (che è anche egoismo della teoria, se mi si passa il termine) ti prendi cura dell'altro. Per svolgere la mia funzione di epistemologo clinico, ad esempio, ho dovuto prendermi cura di me, praticare una serie di percorsi autoformativi, dialogare, condividere momenti di vita con i pazienti: tutte cose che, in qualche modo, mi hanno modificato.
Oggi prevale un atteggiamento riduzionista, però, soprattutto nelle professioni della cura…
Per questo dobbiamo lavorare sulle crepe dell’atteggiamento riduzionista e lasciare intravedere la complessità. Il riduzionismo può anche funzionare talvolta, in casi semplici, ma nella maggior parte dei casi è una pluralità di fattori diversi e spesso stratificati che crea la sofferenza. Ruotiamo sempre attorno alla stessa questione, la cura di sé è la cura dell’altro: capire l’altro, capire se stessi, conoscersi attraverso la conoscenza dell'altro fuori di me. D'altronde se, mentre guardi in te stesso, non getti contemporaneamente lo sguardo sugli altri, non affronterai mai a fondo neppure la questione della cura di te. Questa interdipendenza tra cura di sé e cura dell’altro è dato anche da una certa persistenza dell’empatia clinica.
Coinvolgimento e distacco, insomma… Ma non c’è troppa empatia in giro?
Uso infatti il termine empatia in senso non romantico. Ma, d'altronde, proprio tornando ai saperi che si devono fare pratiche, vorrei anche aggiungere che a termini come “empatia” e “cura” va tolta la patina vagamente metafisica che spesso si attribuisce loro. La cura, qui, andrebbe intesa è alla Foucault, non alla Heidegger. La cura è un gui e ora, un sapere che si scontra, si confronta, che diventa pratica. Ripetiamolo fino all’ossessione, ma ripetiamolo.
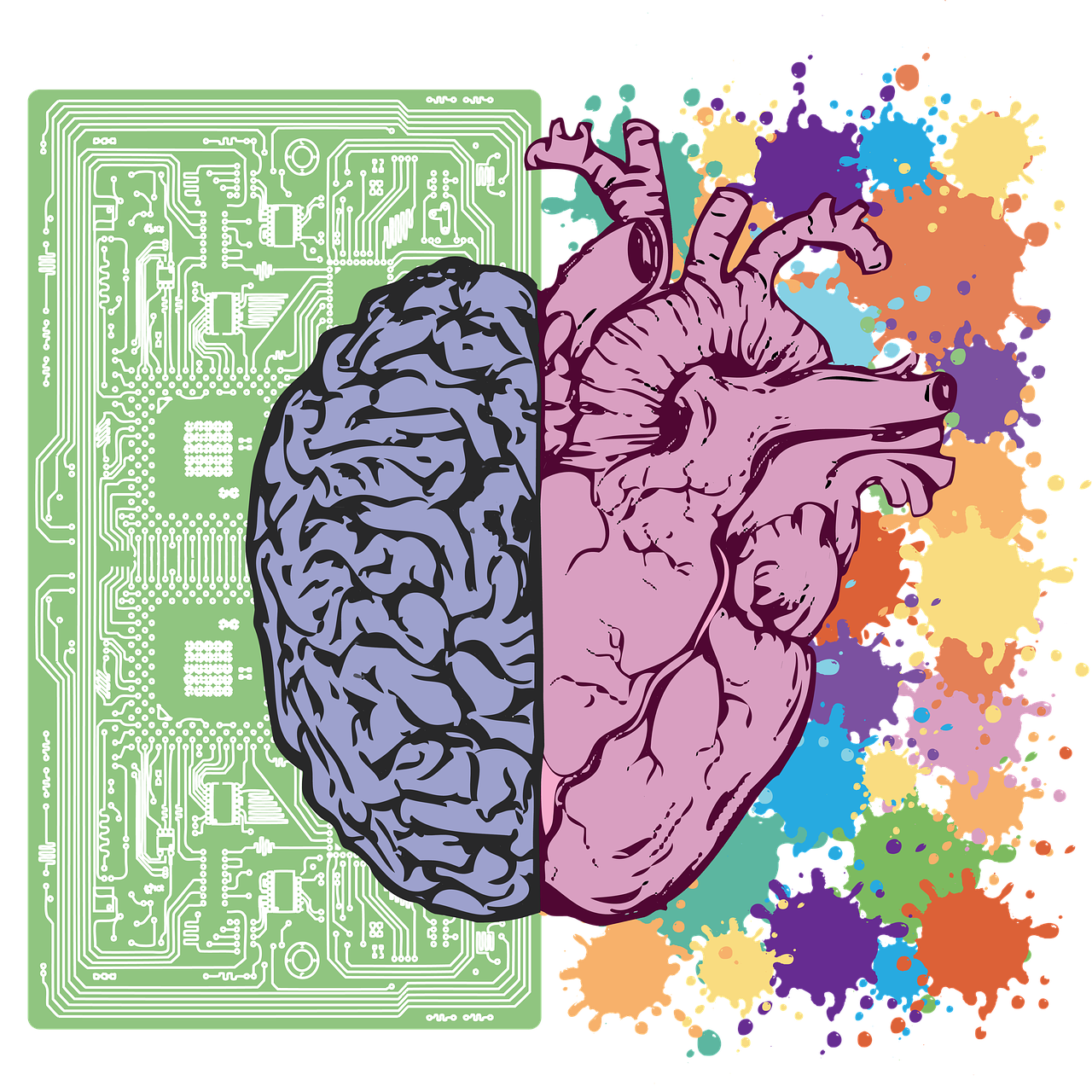
Mi dissocio completamente da una considerazione a-storica e meta-categoriale della cura, è la pratica di cura, la pratica di relazione ciò che ci dovrebbe interessare. La cura determinata da questi e da questi altri componenti, non la “cura” presa in sé, senza che si sporchi col fango mondo
Mario Galzigna
Mi dissocio completamente da una considerazione a-storica e meta-categoriale della cura, è la pratica di cura, la pratica di relazione ciò che ci dovrebbe interessare. La cura determinata da questi e da questi altri componenti, non la “cura” presa in sé, senza che si sporchi col fango mondo. Chiedendosi che cosa significhi amare qualcuno, Gilles Deleuze e Félix Guattari si davano questa risposta che mi pare significativa: «Significa coglierlo in una massa, estrarlo da un gruppo, anche ristretto, a cui partecipa (…) e poi cercare le sue proprie mute, le molteplicità che racchiude in se stesso e farle penetrare nelle mie e nelle sue».
Diamo tempo al mondo
Parliamo dunque del mondo nella mente, mentre di solito si tende a scrivere di mondo della mente...
Siamo pieni di mondo e di storia, le nostre sono coscienze-mondo, in barba a tutti i riduzionisti. Proust diceva che ogni uomo è al tempo stesso tanti uomini, cogliere questa molteplicità è la nostra sfida. La caduta della barriera tra io e modo, che definisce una condizione psicotica ma, al tempo stesso, è la condizione del poeta, la condizione del compositore, del musicista. Anche qui, senza eccedere in romanticismi, cerchiamo di vedere la complessità di tale condizione e di questa osmosi io-mondo.
L’io è principalmente «un avverbio di luogo». Anche quando si muove per sentieri impervi o interrotti e si sofferma in zone di frontiera. E d'altronde già Elvio Fachinelli,parlava di queste aree di frontiera accennando a territori della «mente estatica». Si tratta forse di lavorare su concetti minuti, di produrre micro fratture cognitive…
Individuare le soglie e le faglie e in quei margini produrre critica. Fachinelli, d’altronde, aveva lavorato su queste faglie, specialmente in Claustrofilia, sulle sfasature temporali. Il tema dell'estasi, ripreso da Fachinelli, ha un preciso riferimento al «sentimento oceanico» di Freud. Il luogo in cui l'inconscio “dovrebbe” emergere è la seduta scandita dall’orologio per parlare chiaramente di fronte di fenomeni che hanno come caratteristica strutturale l'extra temporalità.
Fachinelli ha riflettuto, con assoluta lucidità, sul fatto che esista una difficile convivenza tra il riconoscimento ai processi inconsci di una unità extratemporale e il problema della temporalità cronometrica della seduta, il cosiddetto setting. Il punto è che, nell’analisi così profonda di Elvio Fachinelli, tremano le fondamenta stesse e tutto l'impianto del setting. O il setting è modulabile che diventa una immateriale camicia di forza. Diamo tempo al mondo, ma diamo anche tempo agli uomini. A tutti gli uomini.
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.

