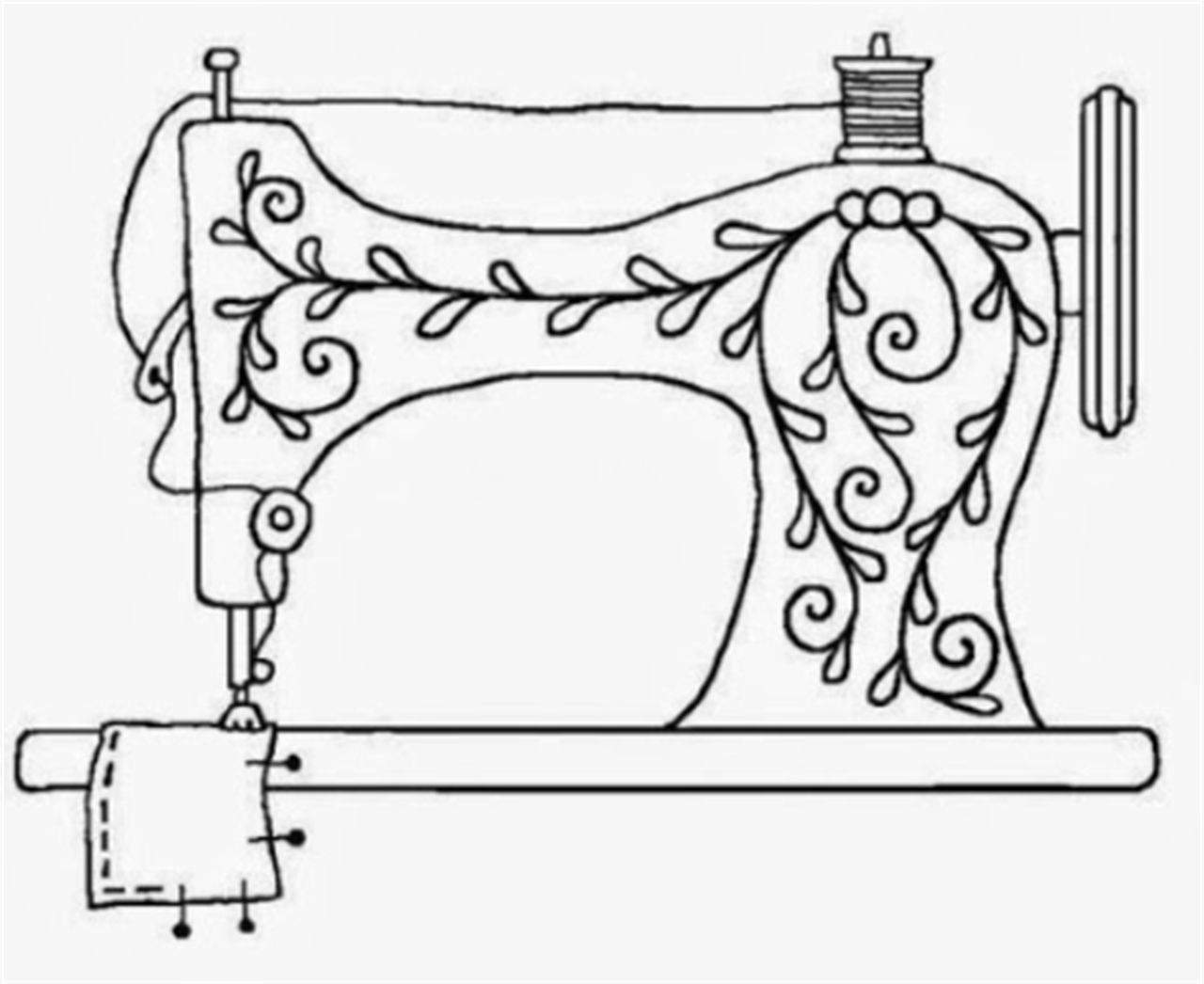
Sono imprese sociali, cooperative e onlus, grandi e piccole realtà, che promuovono l’integrazione e l’inclusione in tutta Italia al ritmo della macchina da cucire. E raccontano di quanto, oggi più che mai, per essere sostenibili, anche sul mercato, sia importante avere un business plan, agire per un bene comune e riprogettarsi come un sistema.
Confezionano capi di altissima qualità artigianale, recuperano tessuti e smontano lo stereotipo che un abito socialmente equo non possa essere esteticamente bello. Il loro modello? Restituire la dignità attraverso un lavoro equamente retribuito, un investimento che fa bene a tutti: alle persone, ai territori e al business Made in Italy. All’interno delle sartorie sociali si progetta, si rinforzano le competenze e si sviluppa il design thinking, che da pratica collaborativa, diventa un sistema per generare innovazione e benessere collettivo. C’è la sartoria che nasce per favorire il cambiamento della percezione dei migranti in Italia, chi per accelerare i processi di integrazione sociale e lavorativa delle donne in carcere e chi insegna a trasformare il sapere in impresa. Perché l’integrazione, se ben progettata, può creare cambiamento e bellezza a più livelli.
I rotoli di tessuto sono riposti sotto un grande tavolo da lavoro, sbordano dal ripiano come lunghi anelli colorati e, nella quiete, attendono di passare nella stanza accanto per essere affidati a mani sapienti e trasformarsi in meravigliose creazioni. Lì, il rumore ritmato delle macchine da cucire, le chiacchiere e le risate delle sarte accompagnano la musica in sottofondo e riempiono gli spazi di leggerezza. Sono appena arrivata nel laboratorio esterno della Cooperativa Alice, tra le vie del quartiere cinese di Milano e la mia attenzione viene rapita dai lunghi appendiabiti a bastone che scandiscono tutto il perimetro della stanza, con abiti e cartamodelli. I miei occhi seguono il loro percorso, poi si soffermano sulla parete in fondo, in cui vedo una fila di tuniche nere. Mi chiedo cosa siano.

«Sono le toghe per i magistrati e gli avvocati, le confezioniamo qui», mi racconta Caterina Micolano, che da tre anni è presidente della cooperativa, «parte della lavorazione è eseguita a mano con l’antica arte della plissettatura a cannoncino». La cooperativa ha laboratori artigianali nelle sezioni femminili delle carceri lombarde di San Vittore, Bollate, Monza e una sartoria esterna, dove mi trovo, aperta a chi esce da percorsi di violenza e difficoltà. Attraverso un lavoro equamente retribuito ha permesso a centinaia di donne di raggiungere l’indipendenza economica, sotto la guida di designer e leader nell’industria della moda e nel 2020 ha ottenuto un totale ricavi di oltre 350 mila euro. «Siamo un network che unisce territori, ruoli e persone, associazioni no profit, aziende e professionisti. Non viviamo di donazioni, ma di contratti, perché è il lavoro che ti fa arrivare gli assegni e ti fa sentire di nuovo accolto nel sistema economico».
Un’impresa sociale, per Micolano, deve essere prima di tutto impresa con la “I” maiuscola. Not charity, just work come si legge nel sito web della cooperativa. «Sociale è solo un aggettivo», dice, «la fragilità di una struttura che continua a drogarsi di fondi pubblici per stare in piedi è un modo malsano di nutrire un modello economico. Le cooperative di inclusione devono vivere del fatturato di ciò che vendono. La domanda da farsi è: cosa deve fare un’impresa sociale per essere davvero socialmente utile? Mai come oggi quello che scrivi sul cartellino è importante, e invece c’è chi mette ancora slogan del tipo “per dare una seconda chance ai tessuti e alle persone che altrimenti andrebbero buttati”. Ma come ti permetti di paragonare la vita di una persona a un tessuto che non serve più? Chi nella vita fa questo dovrebbe indignarsi di fronte a questi tipi di definizione. Questo è assistenzialismo, che è fondamentale in un sistema di welfare, ma in un sistema di mercato sono l’approccio progettuale e di business che funzionano. Un capo deve meritare di essere comprato».
L’Italia del saper fare
Nei laboratori della cooperativa, non solo le donne riconquistano l’indipendenza, ma stanno diventando parte di una tradizione più ampia, quella delle tecniche artigianali italiane. «Siamo orientate alla moda per cercare di fare cultura in quel mondo, per portare avanti il discorso di una sostenibilità non solo ambientale, ma anche etica», prosegue Micolano. La loro sfida è quella di rompere gli stigma. Non è detto che se una produzione è fatta da una cooperativa sociale o da una filiera etica debba essere di bassa qualità. «Anzi», prosegue, «se le aziende ci aiutassero a costruire e a raccontare questo sistema, che riparte dalla manifattura e dall’artigianato, potremmo creare più impatto. Il lavoro fa scattare una serie di meccanismi emotivi, ma dipende sempre dalla persona. Chi si è salvato, si è sempre salvato da solo, grazie a delle opportunità».

Alice è la prima realtà manifatturiera italiana certificata Fairtrade e sta creando un distretto di supplier da offrire ai brand, per aumentare le capacità produttive e per promuovere la cultura del Made in Italy a filosofia di vita. L’ultima sfida? Una pochette che la cooperativa sta confezionando per un marchio dell’alta moda, che sancisce l’apertura dell’estremo lusso al commercio equo. Un modello economico fatto di estrema qualità, uno strumento giuridico ma anche una vocazione, un posto nel mondo. Tra le sartorie sociali con cui hanno stretto partnership ci sono piccole realtà che fanno lavori artigianali di altissimo livello, come le serigrafie e i ricami di Extra Liberi, che mette al lavoro i detenuti e le detenute del carcere Lorusso e Cutugno di Torino; o la cooperativa sociale Manusa di Pistoia, che lavora con i rifugiati e produce ricami che sono opere d’arte.
«Con la World Fair Trade Organization stiamo cercando di creare un Made in Italy certificato. Le certificazioni nelle aziende sono una pratica normale, nel sociale è tutto lecito, non lo dico per malafede. Io sono fiduciosa perché gli spazi ci sono e nel profit si stanno creando molta competenza e motivazione sulla sostenibilità. Non vuol dire che nelle aziende ci siano i santi, ma ci sono persone che fanno la differenza. Soprattutto per noi che arriviamo da questa formazione, devi crederlo. Noi abbiamo la storia, ma le aziende hanno gli strumenti, i designer e i creativi. Se crei un sistema i benefici arrivano a chi lo esercita, a chi ne fruisce in termini di prodotto e a chi l’ha generato. È una sfida culturale e abbiamo le competenze per affrontarla».

Una nuova centrale di moda equa e solidale l’ha creata l’impresa sociale AltroMercato con il nuovo brand On Earth, che ha messo insieme diverse realtà italiane di moda etica per realizzare un prodotto che rispetti le stagioni, le persone e il pianeta. La loro prima linea si chiama Cooperative Collection ed è stata interamente prodotta durante l’emergenza Covid. E nonostante la pandemia tutta la filiera, in ogni singola parte, ha fatto fronte al lockdown confermando gli ordini effettuati, evitando così gravi conseguenze per i produttori. In aprile il marchio lancerà una nuova collezione circolare, in cui i capi invenduti della precedente saranno destrutturati e rivisitati da realtà sartoriali in tutta Italia.
«Nessuno è utile, tutti sono indispensabili»
Al benessere sociale concorrono tutti, nessuno escluso. Lo dice il designer attivista e art director Fabrizio Urettini, ribaltando il classico assunto secondo cui: “Tutti sono utili, nessuno è indispensabile”. Nel 2016, a Treviso, ha fondato Talking Hands – con le mani mi racconto, partito come un workshop multidisciplinare di moda e arredo per ridare dignità a rifugiati e richiedenti asilo attraverso il lavoro, poi diventato un laboratorio di progettazione organica, che coinvolge professionisti con competenze diverse: designer, modellisti e stilisti volontari, che lavorano insieme ai ragazzi.

«Abbiamo l’ambizione, forse la follia, di provare a formare dei designer che non abbiano solo competenze di tipo pratico, ma che acquisiscano un approccio e una metodologia di progetto», racconta Urettini. «Talking Hands è nato durante l’emergenza umanitaria, quando a Treviso sono arrivati duemila richiedenti asilo. Erano parcheggiati negli hub, una serie di caserme ereditate dalla Guerra Fredda, poi trasformate in centri accoglienza», prosegue Urettini, «dovevano essere soluzioni temporanee, ma sono diventate sistemiche e hanno creato situazioni di marginalità. Un giorno abbiamo indetto un’assemblea per capire cosa sapessero fare i ragazzi e, con grande sorpresa, è emersa una pluralità di competenze nelle arti applicate, nella sartoria e nel ricamo. Così abbiamo iniziato il percorso per sottrarli a una situazione di stallo emotivo e stimolare la loro voglia di mettersi in gioco».

Il design thinking è diventato uno strumento per la costruzione di reti di solidarietà a supporto del progetto, non solo servizi assistenziali, ma una serie di partnership con aziende attente al territorio e con un approccio etico alla filiera che forniscono materiali tessili in esubero e campionature. «Adesso stiamo collaborando con il Lanificio Paoletti, attivo fin dal Settecento, che lavora con l’alta moda e impiega la lana delle pecore dell’Alpago, per molto tempo considerata uno scarto per via della sua fibra grossolana, oggi recuperata senza l’uso di coloranti chimici, e anche con Tessitura Luigi Bevilacqua, di Venezia, che utilizza telai del Quattrocento».

Le collezioni di Talking Hands escono dall’immaginario stereotipato di memoria coloniale dell’artigianato e della moda etnica e trasformano le abilità artigiane in un sentire contemporaneo. Si trovano nella boutique online, su shopify e da WaxUpAfrica a Ginevra. Oggi sono al centro di una campagna di comunicazione che promuove l’imprenditoria migrante in Italia. «Nel nostro piccolo abbiamo creato un tessuto sociale e abbiamo sempre cercato di documentarlo, anche visivamente, per creare un modello riproducibile di start up sociale», dice Urettini. Entro il 2021 punta a cambiare status giuridico e da associazione di promozione diventare un’impresa sociale a tutti gli effetti.
Smontare gli stereotipi, puntando sulle relazioni

«Se vuole la foto di una delle ragazze per scrivere di fianco che è scappata dalla tratta e sbatterla su una rivista me lo dica subito. Mi chiamano giornalisti ogni giorno per avere una storia strappacuore da raccontare», esordisce così Olesea Ionita, sarta originaria di Straseni, nella Repubblica della Moldavia, che con Reborn In Italy, il suo atelier all’interno della sartoria sociale di Chieri, dà lavoro a mamme con un passato complesso, ma di certo non cede al pietismo.
Le sue “sarte invisibili”, come le chiama lei stessa, sono tutte contrattualizzate e danno vita a creazioni di altissima fattura.

«Qui si lavora seriamente, se no chiudiamo», dice, «ogni giorno, insieme, superiamo un limite, una difficoltà, lavorando su modelli molto complessi, per imparare la coerenza, la precisione, la manualità e ottenere un capo impeccabile». Ionita definisce la sua una scuola di volo per mamme sopravvissute alla guerra, all’esodo e alla vita di strada, che imparano, da sole, a usare le proprie ali.
«C’è chi non aveva nemmeno i soldi per comprare il biglietto dell’autobus e raggiungere la sartoria e ora, grazie alla determinazione e allo studio, ha imparato a cucire e confezionare abiti meravigliosi. Più creiamo legami tra di noi più la forza dell’artigianato socialmente impegnato, del lavoro che include le differenze e le trasforma in energia può fare la differenza”. Ionita, oltre a guidare una sartoria che funziona e che, in un anno difficile come il 2020, ha triplicato il fatturato del 2019, ha già un nuovo obiettivo, creare un’associazione per i diritti delle donne migranti insieme ad altre protagoniste coraggiose provenienti da Ucraina, Moldavia, Russia, Romania, Armenia, Nigeria e Ghan»”.
Il network, una via possibile
C’è chi, invece, ha messo in piedi una rete di una decina di sartorie sociali a cui affidare diverse fasi del processo di creazione. È il caso di Mafric, marchio nato al Giambellino, nella periferia milanese, dalla cooperativa sociale SunnCoop. Un network territoriale che unisce una valida produttività alla sostenibilità sociale e impiega uomini e donne migranti, provenienti da Gambia, Ghana e Nigeria senza possibilità di lavoro sul territorio. «Il nodo, oltre a essere un elemento comune delle nostre creazioni, ne simboleggia il valore intrinseco: creare sinergie tra microrealtà che agiscono in contesti di vulnerabilità ed essere il luogo di incontro tra più culture», racconta Giovanni Lucchesi, il fondatore, «ogni capo si pone l’obiettivo di essere il risultato finale di una filiera produttiva sostenibile, in grado di generare valore e avere un forte impatto sociale».

Dopo la laurea in Relazioni Internazionali e anni di volontariato, Lucchesi fa il servizio civile in Zambia, a Livingstone, in un centro di aggregazione per ragazzi svantaggiati della ong Celim. «Proprio lì c’era una sartoria sociale, si producevano capi da vendere ai turisti in vacanza a Livingstone. Quindi, mi sono chiesto, perché non farlo anche in Italia?», prosegue Lucchesi, «e così è nata l’idea. Ora il nostro mercato sta crescendo, prima vendevamo solo nei negozi equosolidali, in dieci regioni, ora stiamo iniziando anche nei negozi classici. Siamo partiti con il brand nel 2020, subito prima del lockdown, da una collaborazione con tre cooperative che gestiscono negozi equosolidali e a fine anno, considerando la situazione delicata, siamo arrivati a 35». Per il 2021 Lucchesi conta di raddoppiare le collaborazioni e avviarne di nuove con negozi indipendenti, che oggi sono tre. A breve, invece, inaugurerà l’e-commerce e in marzo aprirà una sartoria sociale propria, al Giambellino. «La nostra prima collezione, quella della primavera-estate 2020 è andata persa, a causa della pandemia, ma le premesse di fine anno sono ottime, solo tra ottobre e novembre abbiamo fatturato 35 mila euro, nei prossimi mesi punto a superare i 100 mila e a raddoppiare la produzione entro l’inverno, considerando che i volumi aumenteranno molto con il lancio dell’e-commerce e aumenteremo le collaborazioni con le sartorie sociali. Adesso, oltre che con SunnCoop lavoriamo con Spazio 3R, Sartoria Arché e inizieremo con Coulture Migrante a Como, Il Gelso, La Cruna dell’Arco, Cascina Monluè e Manigolde. Nella sartoria assumeremo quattro persone per iniziare, poi si andrà a crescere, i beneficiari saranno sempre donne e uomini migranti, anche per la parte logistica, che aumentando i volumi andrà rinforzata».
L’impresa sociale non è carità esibita ma valore nuovo
A creare un circolo virtuoso tra mercato e sociale è Progetto Quid, in cui creatività e bellezza si fondono con il recupero di tessuti di qualità inutilizzati. Quid offre opportunità di un lavoro sicuro a persone vulnerabili, coinvolgendole nella produzione di moda etica e attraverso collaborazioni con una trentina di brand. Valori e realtà tenuti insieme sotto l’iconico logo, una molletta. Nel 2012 era un’associazione e oggi ha 125 dipendenti che provengono da 16 Paesi, di cui l’85% sono donne e ha anche un laboratorio con otto lavoratrici all’interno del carcere di Montorio a Verona, oltre a un e-commerce, dieci negozi diretti e una rete di 70 multibrand. Ogni anno produce centinaia di migliaia di capi e accessori e, nel 2019, ha fatturato tre milioni di euro, con una crescita del 100% rispetto al 2015.

Anna Fiscale, alla guida del brand, il 29 dicembre dello scorso anno è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italia da Sergio Mattarella. «La ricetta Quid è, prima di tutto, comprendere le attitudini e le peculiarità delle persone e cercare di inserirle in un contesto lavorativo che le aiuti a fiorire, intessendo relazioni umane che sappiano aiutare e dando vita a una moda più significativa sia per chi la indossa, sia per chi la crea», dice Fiscale.

Con il motto Cuciamo tessili e relazioni la sartoria Vicini d’Istanti di Bologna fa cultura sull’inclusione e workshop di formazione gratuiti. Nata in una stanza di un centro d’accoglienza richiedenti asilo, oggi opera all’interno del centro culturale artistico Secondo Piano, si è trasformata in un atelier di moda, cercando di tessere la vocazione al sociale con la bellezza. È nata nel marzo del 2017 da sei fondatori, all’inizio soci e collaboratori erano tutti volontari, oggi hanno quattro dipendenti e un gruppo di apprendisti e dai tremila euro di fatturato del 2017 sono arrivati a più di 20mila nel 2020. Insieme lavorano per creare occasioni di incontro tra persone diverse per provenienza, religione, lingua, cultura e visioni, e per co-creare un nuovo modo in cui vivere.

A guidarli sono Maddalena Papini, socia fondatrice di Vicini d’Istanti insieme al sarto ivoriano Mamadou Camara e al giovane direttore creativo ghanese Victor Reginald Bob Abbey-Hart. I loro vestiti e chi li fa si raccontano nelle NarraSfilate, performance artistiche scandite dal dialogo tra un rifugiato, che racconta le tappe del proprio viaggio per raggiungere l’Italia, e un uomo italiano, che riporta il suo personale vissuto di europeo. Nel 2021 inaugureranno un nuovo punto vendita.
Sempre a Bologna la sartoria SocialChic design della cooperativa MondoDonna Onlus è un punto di riferimento che offre accoglienza, riparo e sostegno a donne, uomini e minori vittime di violenza di genere, di stalking, di tratta e di grave sfruttamento, in condizioni di marginalità socio-economica. Il laboratorio fa convergere il valore sociale con l’alta qualità dei prodotti, promuovendo l’empowerment. Lo scorso anno hanno aperto l’ecommerce e nel 2021 è previsto un ampliamento dell’organico.
«Tra i nostri nuovi progetti c’è anche la redazione di un vademecum dedicato a chi vuole aprire una sartoria sociale, a cui stanno lavorando con una rete di altre realtà in Spagna, Portogallo e Grecia», racconta Michael Tondini, product designer, responsabile dell’ufficio stile, «una guida ai passi fondamentali per crearla, dall’importanza del design alle maestranze da cercare, ai consigli su come procedere nell’iter burocratico e fiscale».

Dall’abito all’abitare
Sull’importanza del design come strumento e delle collaborazioni con stilisti affermati punta anche Coloriage, nata a Roma come progetto dell’Associazione Terià, che fa formazione finalizzata alla valorizzazione di arti e mestieri e ha fondato la prima Scuola di Moda Gratuita, Solidale e Multiculturale d'Italia, uno spazio in cui artigiani, designer, e maestranze di ogni provenienza possano trasmettere le loro conoscenze e le loro storie. Coloriage, nel 2021, è diventata cooperativa di produzione lavoro e impresa sociale sotto la guida di Valeria Kone e Sandrine Flament.
«Abbiamo preso in carico gli aspetti produttivi e commerciali», racconta Kone, «mentre l'Associazione Terià, che finora è stato il quadro giuridico, continua a gestire il progetto no profit della scuola di moda. Come impresa potremmo gestire l'aspetto commerciale molto più agevolmente». All’interno dell’atelier di sartoria e pelletteria nascono pezzi unici e originali, si creano vestiti e accessori, si trasformano abiti, complementi d’arredo e mobili. Hanno collaborazioni con designer e formatori stranieri, a breve partirà quella con la nota stilista Stella Jean. «La sartoria è partita aggiudicandosi il bando Impatto + di Banca Etica, ma ora non abbiamo nessun tipo di finanziamento, tutto quello che facciamo dipende dalle vendite, siamo nati e cresciuti grazie ai proventi delle collezioni e nel 2020 abbiamo fatturato circa 160 mila euro», racconta Kone, «non mi sarei mai aspettata che in meno di due anni facessimo lavorare una squadra di dieci persone».L’impegno sociale e la presenza sul territorio per promuovere la legalità sono le sfide della cooperativa di transizione Al Revés di Palermo, che punta sul valore positivo della diversità nel totale rifiuto di qualsiasi discriminazione e ha il supporto di Fondazione con il Sud e Fondazione Vismara. La sartoria sociale vende in sede e online ed è nata all’interno di un magazzino confiscato alla mafia. Si basa sul riciclo tessile e mette al lavoro migranti, donne vittime di violenza, persone sottoposte a provvedimenti giudiziari e ha un laboratorio all’interno della casa circondariale Pagliarelli-Lorusso. Inoltre, portano avanti laboratori di educazione all’ambiente, al riciclo e all’economia circolare all’interno delle scuole e anche interventi sulla legalità e la trasparenza. «Al Revès significa al contrario, al rovescio, vuol dire che una storia si può ribaltare, basta volerlo, basta cambiare il punto di vista sulla realtà. Noi accogliamo le persone, le formiamo e cerchiamo di rimotivarle al lavoro», dice Rosalba Romani, tra i fondatori della cooperativa.

Il suo motto? Siamo tutti ex di qualcosa. «Ciascuno di noi, nella sua vita pseudo-normale ha avuto dei momenti di crisi, ci sono persone che non avrebbero mai pensato di avere un guaio con la giustizia, può capitare a tutti», continua Romano. Che nell’ultimo anno ha attivato un progetto e condivide clienti con la sartoria Soleinsieme, a Reggio Calabria, ed è presente nella rete Italia is One, che riunisce tutti i laboratori che lavorano nelle carceri di tutta Italia. «Il network è nato durante la prima quarantena per fare fronte alla massiccia richiesta di mascherine, siamo riusciti a uscire dalla logica concorrenziale, abbiamo collaborato, tenendoci forte, perché se non c’è una dimensione del bene comune, non si può crescere».
La sartoria AL Revès è partita nel 2013 con due impiegati e ora ha cinque dipendenti a contratto, dieci collaboratori a partita Iva, cinque tirocini formativi e un gruppo di volontari che fa formazione. «Il fatturato è cresciuto, nonostante il Covid», dice Rosalba Romano, «e ora grazie a Fondazione con il Sud, abbiamo comprato una moto ape per raggiungere il territorio in modo capillare».
Le realtà invisibili
C’è chi sta provando a fare una mappatura delle realtà attive in tutta Italia. Giada Li Calzi, direttore della Fondazione Progetto Legalità di Palermo, ha condotto una ricerca sulle sartorie sociali insieme a Claudia Coco e Morena Trovato, nell'ambito di un lavoro promosso con la cattedra di Geografia Visuale dell’Università di Catania. L’obiettivo? Delineare un sistema, altrimenti invisibile. Da una prima ricognizione è nata la necessità di comprendere quali fossero i punti di forza da valorizzare, quindi, insieme a Fondazione Legalità, Li Calzi ha portato avanti un’azione di program management, volta a individuare i problemi e a suggerire un percorso alle istituzioni che finanziano le sartorie sociali. « È un’opportunità che, a seguito dell'impatto della pandemia e alla maggiore attenzione riservata al green deal e all’economia circolare, si rende più che mai attuale», dice Li Calzi, «dobbiamo lavorare su azioni di sistema, di co-progettazione per sostenere un associazionismo tra le sartorie e altri attori della filiera. Ma bisogna prima di tutto formare all’imprenditorialità, di sartorie sociali con un business plan ce ne sono poche e il rischio è che restino monadi che dialogano solo nel proprio ambito di intervento, con sforzi enormi. Servirebbe un’azione concertata di secondo livello, una sartoria delle sartorie, un finanziamento di azioni di sistema che consenta di mettere insieme conoscenze e pratiche, per fare rete e sviluppare dei servizi comuni, divisi per settori, in cui gli obiettivi e i bisogni siano scritti da tutti. La mappa è un primo strumento, ma il resto è da fare. E ci piace pensarci dalla parte dei costruttori. Poi, come diceva il magistrato Giovanni Falcone, le nostre idee cammineranno sulle gambe di altri».
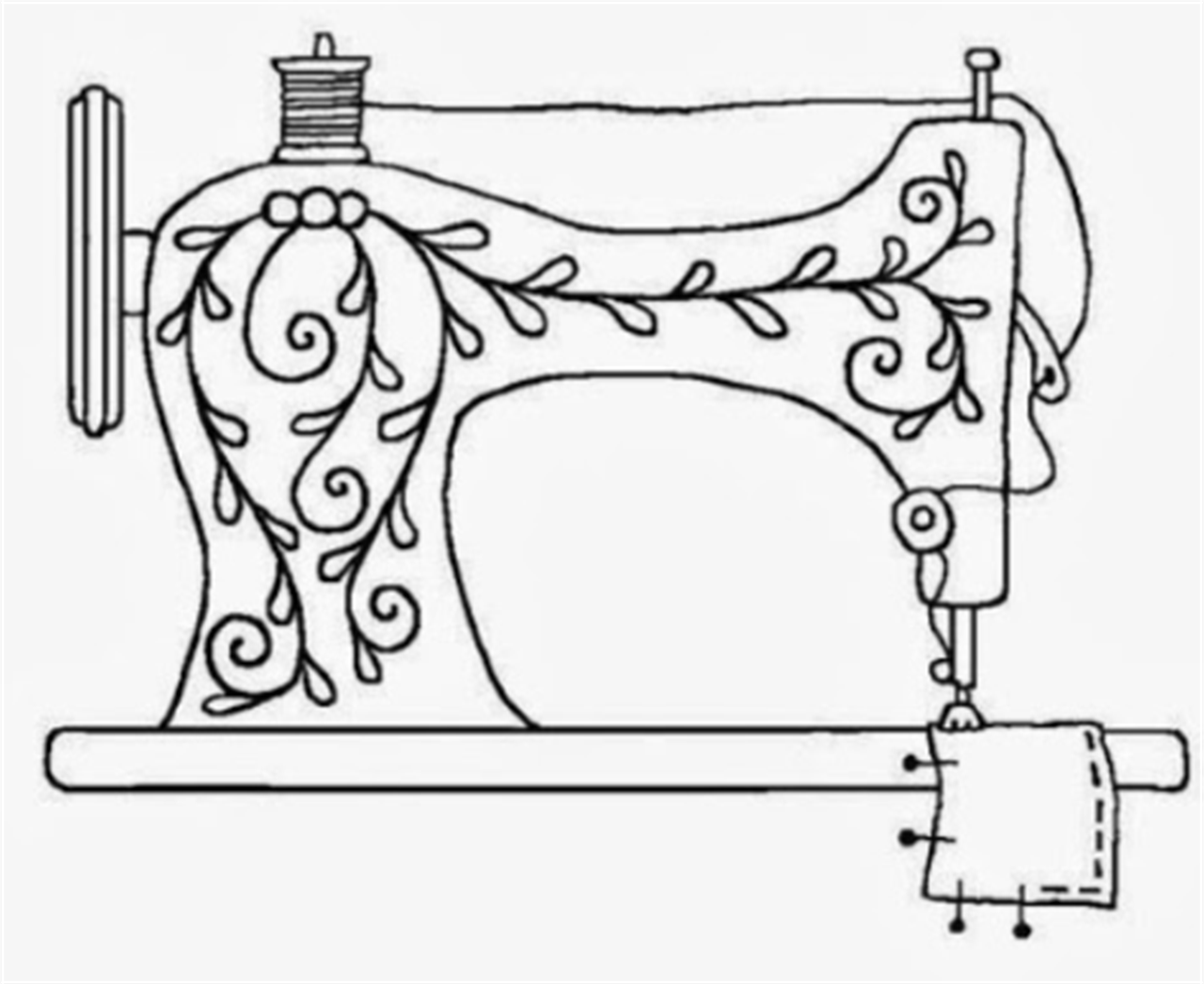
Nell'immagine di copertina una foto di Najat Boussekssou, modella di origini berbere, in uno scatto dell'ultima collezione di Talking Hands. © Lorenzo Marzi
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it



