Welfare
Chi cancella la Gozzininon trova sicurezza
carcere J'accuse di un operatore in prima linea: il ddl Berselli è un boomerang
di Redazione
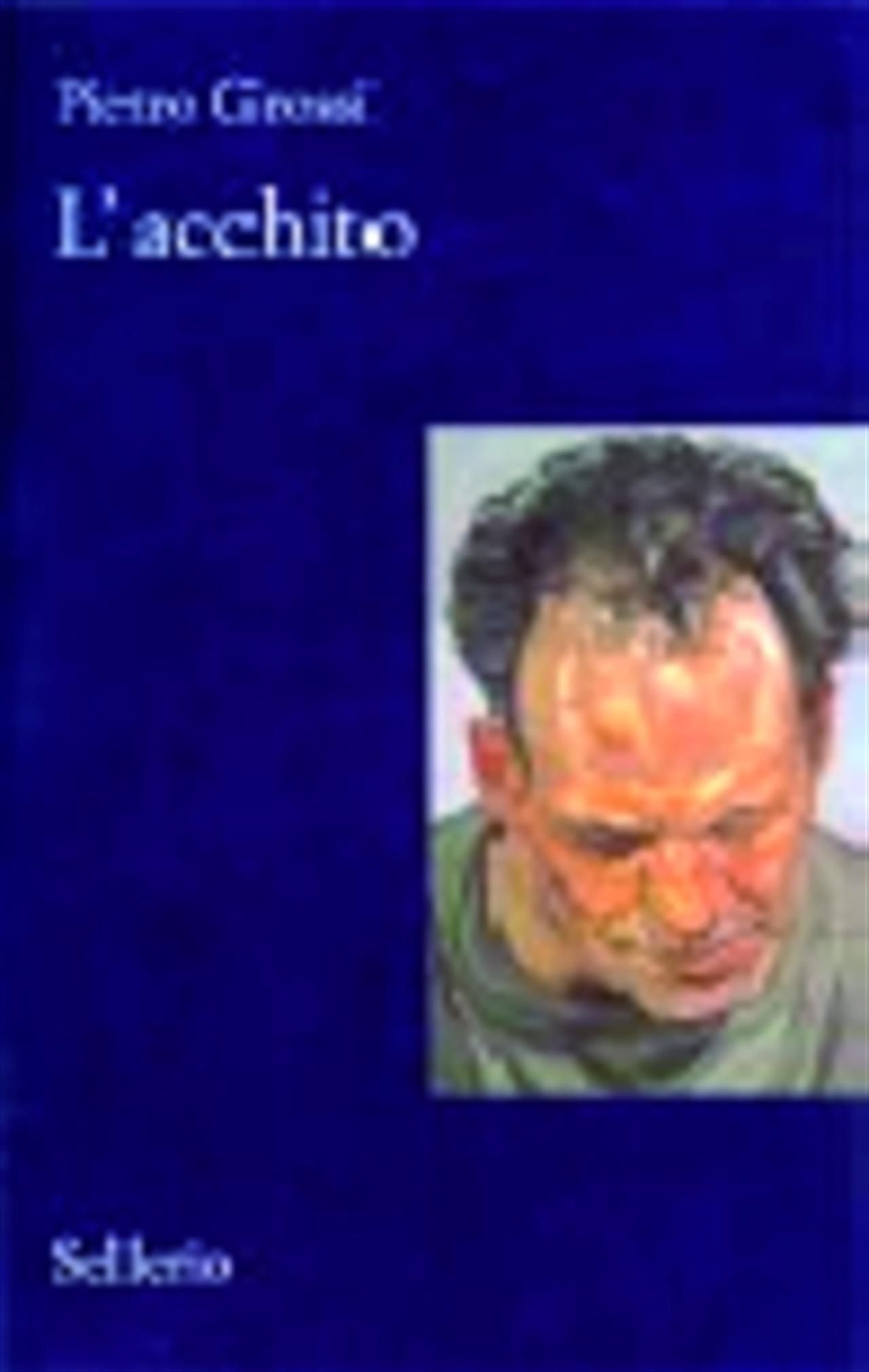
Analizzando il disegno di legge Berselli/Balbone sembra ormai prevalsa l’idea che i benefici introdotti dalla legge Gozzini siano nella realtà misure alternative alla pena e che un condannato, tra permessi, sconti e altri vantaggi, finisca per non scontare la propria colpa. Invece la legge numero 663 del 1986 ha riformato l’ordinamento penitenziario cercando di renderlo più vicino ai principi contenuti nella Costituzione e all’art. 27, terzo comma, dove si dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
L’obiettivo deve essere il recupero del condannato e non la sua cancellazione dalla società civile. È dimostrato: un condannato recuperato e reinserito pienamente e produttivamente nel tessuto sociale non delinque più e torna a una vita normale, cessando di costituire un pericolo per la sicurezza e un costo da sopportare per la collettività (oltre 100mila euro l’anno, 300 euro al giorno, oltre 1 miliardo di euro l’anno ogni 10mila detenuti!). Da questo punto di vista il recupero è in funzione, e non in alternativa, alla sicurezza, con cui anzi coincide pienamente.
Perciò le misure alternative e i permessi, se correttamente applicati, vanno visti come una possibilità di rieducazione e reinserimento, essendo peraltro in alcuni casi più punitivi della stessa pena detentiva poiché contengono aspetti anche umilianti (il ritorno in carcere tutti i giorni, le ispezioni notturne delle forze dell’ordine, le firme in questura ecc.).
Il detenuto deve essere avviato al lavoro non tanto per essere sottratto all’ozio avvilente, quanto perché il lavoro è un dovere sociale, è un diritto costituzionale nonché un essenziale strumento di rieducazione e di reinserimento, con notevoli vantaggi anche di ordine psicologico e sociale, oltre che economico. Per porre rimedio alla carenza di opportunità di lavoro, l’amministrazione penitenziaria è chiamata ad agevolare con sempre maggior impegno le iniziative che provengono dalla società libera, nello spirito del principio di sussidiarietà oggi sancito dalla Costituzione, attivando strategie più adeguate e più proficui collegamenti con l’esterno, direttamente con il mondo del lavoro e con le istituzioni.
Purtroppo da oltre un ventennio poco o niente è stato fatto in questo senso, ma anzi grazie alla disinformazione sistematica oggi è tutto molto più difficile, il sistema è “incancrenito” e non sarà facile trovare una soluzione a breve termine. Sicuramente va valorizzata la figura del Magistrato di sorveglianza, ruolo di ardua complessità e di estrema delicatezza che la legge ha istituito con il compito di recuperare persone che hanno sbagliato e per il quale il cuore di qualsiasi persona che si dica tale desidera che riesca nello scopo nella maniera più efficace.
Riteniamo perciò che per un corretto approccio al problema della sicurezza, che esiste ed è urgente (anche se il dato percepito è sicuramente superiore al dato reale), un moderno Stato di diritto non possa prescindere dall’affrontare in modo sistematico il tema del lavoro con i detenuti, nelle due ipotesi del lavoro all’interno e all’esterno del carcere.
Non è il momento né il caso di fare confusione tra sicurezza sociale, certezza della pena e funzione del carcere. Solo perché in questi decenni nessuna istituzione ha saputo affrontare il problema in modo efficace, allora si scarica tutto sul sistema carcerario.
È ovvio per tutti che chi sbaglia deve pagare. Lo diceva tanti anni fa un certo Sant’Agostino: «?lasciare impunito il colpevole è una crudeltà, perché toglie a chi ha sbagliato la possibilità di correggersi». Ma, proseguiva Sant’Agostino, «?la pena non deve avere il carattere di una vendetta, né di un’incontrollata scarica emotiva, ma di un atto di ragione commisurato al duplice fine: della conservazione della società e della correzione del colpevole. Nella proporzionalità sta la giustizia della pena?».
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.
