I miti della filantropia
Il tarlo della scarsità ovvero se il fondo viene prima della fondazione
La "mentalità delle risorse scarse" sta mettendo un freno alla filantropia, dice la direttrice della comunicazione di Kataly Foundation, istituzione che ha strutturato i propri finanziamenti partendo da una visione opposta e ha deciso di farlo in un tempo dato, scegliendo di persino di avere una durata
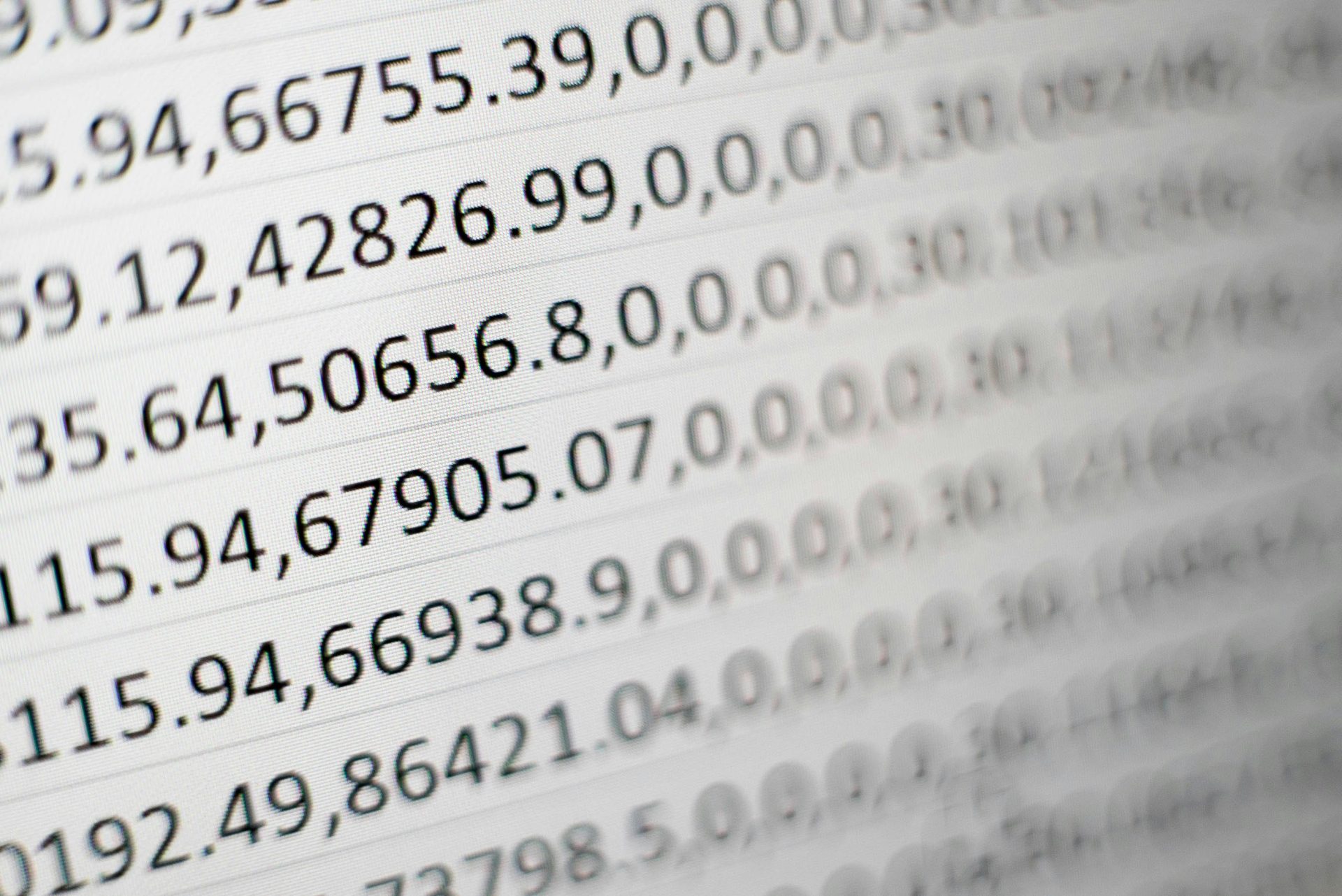
“I miti delle filantropia” è la serie curata dalla comunità di pratica filantropica Elemental, animata da Chiara K. Cattaneo e Mandy Van Deven. Interventi che rappresentano uno spaccato della filantropia internazionale e analizzano alcuni dei “miti“ più comuni che determinano il modo in cui operano le realtà donative. Interventi che, chiedondosi “e se?”, offrono approcci, interventi e nuove visioni di come si potrebbe agire per un mondo più giusto. La serie viene pubblicata anche dal Centre for Effective Philanthropy e dall’Association of Charitable Foundations, oltre che da VITA.
«Le risorse sono scarse – devono essere protette e salvaguardate, anche a costo della realizzazione della mission. Per preservare risorse scarse per ipotetici bisogni futuri, negli Stati Uniti le fondazioni adottano il cinque per cento di distribuzione annuale della dotazione finanziaria come tetto, e non come base di partenza. Quando le risorse sono scarse devono essere distribuite con estrema prudenza e discernimento».
Questa logica suona, almeno in parte, familiare? Una delle narrative più diffuse – e dannose – che condiziona la filantropia progressista odierna è l’idea, fondamentalmente falsa, che le risorse siano scarse. Molte delle prassi adottate dai finanziatori sono spesso radicate in questa mentalità di scarsità.
Dai cda all’operatività, un pensiero dominante
Quando cerchiamo tracce di queste logiche nel modo in cui la maggior parte delle fondazioni è strutturata, è facile trovare l’influenza della “mentalità della scarsità” ovunque, dalla composizione del consiglio di amministrazione alle modalità di investimento, dai criteri di assegnazione dei finanziamenti alle modalità di rendicontazione. Un esempio lampante è il fatto che nelle fondazioni le decisioni sui finanziamenti sono spesso inquadrate come scelte mutuamente esclusive: se scegliamo di finanziare questa organizzazione, stiamo anche scegliendo di non finanziare quella organizzazione. Se aumentiamo il finanziamento per questa causa, dobbiamo diminuire il finanziamento per un’altra causa. Il risultato è che le organizzazioni si ritrovano a competere per l’attenzione dei finanziatori, devono continuamente dimostrare di essere degne del loro sostegno, senza potersi mai permettere di fallire.

Questo, non solo crea una situazione insostenibile per le organizzazioni non profit che competono per finanziamenti scarsi, ma determina anche l’impossibilità che nessuna fondazione raggiunga mai la propria mission, perché l’ecosistema del cambiamento – di qualsiasi settore, località o sistema si tratti – non viene finanziato come un insieme, un’entità collaborativa capace di avere un impatto collettivo. Rafforza anche un altro mito comune su come avviene il cambiamento, ossia che un unico finanziatore ha la capacità di risolvere un problema complesso in maniera indipendente.
Queste logiche, basate sulla scarsità vengono impiegate così spesso nella filantropia che molte persone le accettano senza fare domande. Naturalmente, mentre la disuguaglianza nella ricchezza cresce a livelli mai visti dai tempi dell’Età dell’oro e le dotazioni finanziarie delle fondazioni negli Stati Uniti superano ora 1,6 trilioni di dollari, diventa più difficile ignorare le ovvie contraddizioni. La narrativa della scarsità fa sorgere molte domande: chi trae beneficio dal mito della scarsità nella filantropia? Cosa si perde quando fare soldi, e non distribuire soldi, è la priorità? Si può parlare di filantropia, in quel caso?
In qualsiasi modo si voglia rispondere a queste domande, la narrativa della scarsità impedisce alla filantropia più progressista di arrivare al cambiamento che desideriamo vedere; un modo in cui i finanziatori possono intervenire significativamente è scegliendo, invece, di strutturare il proprio modus operandi con una mentalità di abbondanza.
Alla Kataly Foundation, una delle conseguenze ironiche del nostro aver adottato una mentalità di abbondanza è che abbiamo deciso di essere una fondazione a durata limitata; mentre si avvicina la data della nostra chiusura, ci vediamo costretti a dire di no a numerose richieste. La viviamo, tuttavia, come una sfida ben accetta anziché come una limitazione. La Kataly Foundation è stata fondata nel 2018 con l’obiettivo dichiarato di ridistribuire la nostra dotazione finanziaria nell’arco di 10 – 15 anni. Vi starete forse chiedendo quindi cosa significhi operare con una logica di abbondanza in questo contesto.
Come contrastare questo approccio
Per contrastare attivamente la mentalità della scarsità nel nostro lavoro, abbiamo strutturato l’approccio in modo tale da erogare finanziamenti consistenti, e di farlo fin dall’inizio della relazione con gli enti beneficiari. Nella filantropia, uno dei modi in cui la scarsità si manifesta è attraverso l’erogazione iniziale di finanziamenti limitati, come un ballon d’essai per verificare la performance di un’organizzazione, mettendole a disposizione una piccola somma di denaro. Se l’impatto generato viene giudicato significativo a fronte di un piccolo investimento, allora l’organizzazione ha dimostrato di essere degna di un maggiore livello di investimento.
Il problema di questo approccio è che i finanziamenti piccoli non consentono strategie di lungo termine o sperimentazioni coraggiose. Inoltre l’impatto che i finanziatori si aspettano da investimenti ridotti e di breve termine è spesso irragionevole e irrealistico, soprattutto quando si tratta di finanziare aspetti di trasformazione politica, sociale ed economica.
Riconoscendo la fallacia di questa logica, e con l’intenzione di costituire un esempio di pensiero dell’abbondanza, la Kataly Foundation ha avviato investimenti catalitici più consistenti in organizzazioni che speravamo potessero consentire ai nostri partner di fare progressi in maniera esponenziale. Questi finanziamenti sono stati erogati senza aspettative definite o risultati predeterminati che definissero quale dovesse essere il risultato dell’investimento; questa voleva essere una intenzionale dimostrazione di fede e fiducia nelle capacità e nelle abilità dell’organizzazione sostenuta.
Conseguenze di una mentalità: punture su poche iniziative a scapito della dimensione collettiva

Un altro svantaggio nell’applicare una mentalità di scarsità alla filantropia è che anziché sostenere un ecosistema robusto, che operi con un’infrastruttura fiorente, i finanziatori, convinti che le risorse siano scarse e sporadiche, tendono piuttosto a concentrarsi su strategie erogative che permettono a singoli gruppi di eccellere e crescere, senza tenere conto di come questo possa indebolire la dimensione collettiva.
Costruire e mantenere movimenti forti e resilienti richiede che ci si prenda cura dell’ecosistema nel suo complesso e che si riconosca il ruolo prezioso che ciascuna delle parti ricopre nel garantire che l’insieme continui ad operare in maniera efficace.
È per questo che chiediamo sempre ai nostri beneficiari chi dovremmo finanziare affinché il loro lavoro possa avere successo. È una domanda importante e illuminante, perché ci restituisce un quadro complessivo dell’ecosistema all’interno del quale operano i nostri beneficiari, e ci permette di rafforzare il lavoro dei nostri partner attraverso il finanziamento a gruppi che aggiungono valore e con cui collaborano.
Così è come si finanziano i movimenti quando si vuole che vincano. Per poter fiorire e per realizzare i cambiamenti desiderati, le organizzazioni hanno bisogno che anche i loro partner siano forti, strategici e floridi.
Partire sempre con un sì
Un altro nostro modus operandi è quello di partire da una posizione di “sì”. Ciò significa che ci sforziamo di soddisfare le richieste dei nostri partner, prendiamo in considerazione e spieghiamo con chiarezza i motivi che possono portare a un “no”, e ci chiediamo cosa servirebbe se dicessimo “sì”, prima di arrivare a dire “no”. Farlo ci ha aiutati a concepire le risorse in maniera diversa, e a riflettere sul nostro valore, che va oltre i finanziamenti che eroghiamo. Ciò non significa che accogliamo qualsiasi richiesta, ma che affrontando una conversazione in maniera affermativa, manteniamo aperta una linea per domande e comunicazioni. Questo approccio ci spinge anche a esplorare creatività e possibilità. Se non possiamo fare le cose in un certo modo, quale potrebbe essere un’altra strada per arrivarci?
Fondamentalmente la narrativa della scarsità che continua a essere prevalente nella filantropia è la conseguenza di un’incessante ricerca di rilevanza e longevità. Erogando le risorse col contagocce, i finanziatori possono vivere per sempre. Alcuni cercano di giustificarla facendo notare le innumerevoli ingiustizie che esistono nella società e ponendo questa domanda: se le fondazioni distribuiscono tutte le loro risorse ora, chi sosterrà le battaglie che ci aspettano in futuro?
La soluzione non è che tutte le fondazioni spendano tutte le loro dotazioni nell’immediato, ma la filantropia ha bisogno di una rivoluzione nel modo in cui concepiamo lo scopo e il processo di ridistribuzione della ricchezza. Se finanziassimo i movimenti sociali partner in maniera espansiva, senza restrizioni, in che modo questo permetterebbe alle organizzazioni di costruire su quelle risorse e continuare a rigenerare una ricchezza che possa rimanere nelle loro comunità a lungo termine?
Un futuro davvero liberatorio è un futuro in cui i movimenti sociali non sono perennemente dipendenti dalla filantropia per poter raggiungere i loro obiettivi. Una visione di abbondanza per la filantropia non dovrebbe essere definita dallo sforzo di vivere per sempre in una relazione di supplica, ma piuttosto dalla creazione delle condizioni per cui la filantropia non è più necessaria, perché viviamo in un mondo di prosperità condivisa.
La foto in apertura è di Foto di Mika Baumeister su Unsplash
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.
