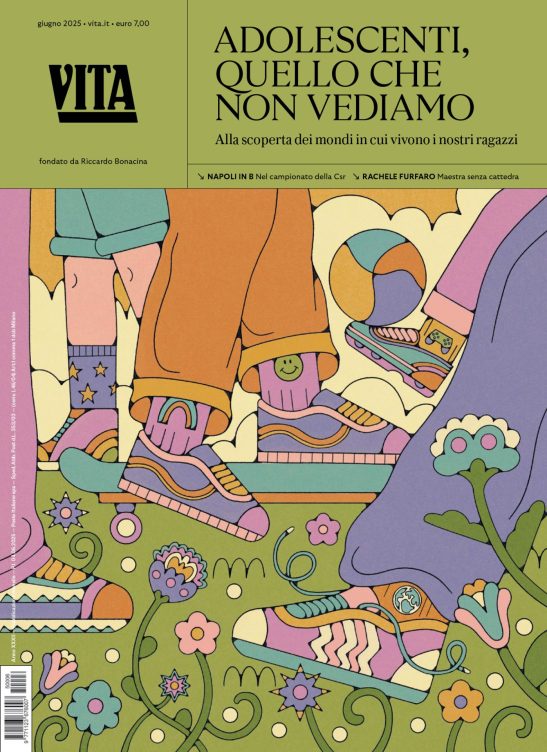“Niente sarà più come prima”: non c’è conference call, webinar o aperitivo su zoom in queste settimane di distanza sociale durante i quali uno dei partecipanti a un certo punto, quasi arrendendosi, non scivoli in questa formula. Sono “parole-rifugio”, suonano complici tra amici, strategiche per colleghi impegnati nella previsione dei nuovi trend, e utili per chi imposta l’apertura di pagina di giornali in tutte le lingue.
“Nothing will be the same after coronavirus”, proclama Fortune per gli anglofoni; “Rien ne sera plus comme avant” si legge su PressAfrik, ma anche su Charlie Hebdo e su Le Temps Tunisie; “Wird nichts so sein, wie es vorher war?”, si interroga la Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Che questo adagio si ripeta alla lettera in parti diverse del globo suggerisce almeno due dati: sa riflettere la cronaca internazionale e tradisce qualcosa di chi lo pronuncia. Di noi adesso, tendenzialmente protesi verso un futuro non chiaro (“nulla sarà più”), con il collo ritorto all’indietro (“come prima”). Ma le promesse per il dopo e i rimpianti del prima non hanno le gambe abbastanza robuste. Non si fa strada, mentre si rischia di perdere il qui e ora, il presente, che invece è l’unico tempo sul quale possiamo esercitare un potere creativo.
Qui non si intende fare la morale, misurare il valore dei contenuti dell’attesa, o quanto e perché ci manchi la cosiddetta “normalità” che ci lasciamo alle spalle. Né si provano a impastare gli ingredienti rimasti in dispensa per arrivare a un “ne usciremo tutti migliori” o il contrario.
Solo si vuol stare al gioco che lancia quel fiato “niente-sarà-più-come-prima”. Perché lascia emergere quasi la dimenticanza di quel che abbiamo ora per le mani, per farci rimbalzare indietro o in avanti. Indietro, a un passato ghiacciato, reimmaginato a nostra misura (come si viveva prima dell’ergersi dei confini tra case, regioni, persone? Prima della mascherina che cancella i tratti singolari del nostro viso?). In avanti, ad appesantire il carico di ansia che ci portiamo addosso. Perché certezze sul domani non ce le regala nessuno. E in questa altalena, crescono disappunto e impazienza, quindi solitudine.
Volgere la mente al futuro sa infiammare con il timore, anche la speranza, è vero. Ma il pericolo di pensare a cose irreali è forte. Pochi lo hanno saputo descrivere come C.S. Lewis, che riconosce una delle tentazioni più grandi della razza umana nel “perseguire perpetuamente la fine dell'arcobaleno”, senza fermarsi a guardarlo, con gratitudine.
Vince il presente su tutto: “Il dovere di stabilire i piani del lavoro di domani – ancora Lewis – è un dovere di oggi; benché il suo materiale sia preso a prestito dal futuro, il dovere, come ogni dovere, è nel presente”.
Alla prova dei fatti, la formula detta è un condensato di nostalgia a due facce. Potenzialmente uno strumento di distrazione di massa. A meno che non assuma i tratti di una nostalgia “rivoluzionaria” (saccheggio il qualificativo da Walter Benjamin), perché in grado di estrarre da ieri e domani solo ciò che serve a lavorare sul presente. A goderne, direbbero i latini. Che per altro è, dei mestieri, il più avventuroso.
Il dovere di stabilire i piani del lavoro di domani è un dovere di oggi; benché il suo materiale sia preso a prestito dal futuro, il dovere, come ogni dovere, è nel presente
C.S. Lewis
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.