Una trasformazione sottile sta cambiando tanto lo spazio pubblico, quanto quello intimo e privato. Una parola racchiude il senso di questo cambiamento: oikos, in greco “casa”. Una casa come luogo di economia ed ecologia (entrambe le parole derivano da oikos), ma anche di condivisione e giustizia. La casa, ci spiega Chandra Livia Candiani , in questa intervista apparsa sul numero di ottobre di Vita, è una questione di legami, non di muri e porte sbarrate.
C’è una parola che vorrei introdurre, per iniziare questa nostra conversazione: oikos. La traduzione è semplice: “casa”, ma non per questo meno carica di molte sfumature. Soprattutto ora. Da un lato, la casa è stata il luogo della paura, dall’altra è anche una possibilità di apertura.
Casa è una parola carica di ambiguità per me o meglio di ambivalenze. Nell’infanzia è stata il luogo del pericolo, della minaccia e mi ha salvato un giardino, la presenza degli alberi e dei gatti, l’aperto. Poi sono stata spesso una fuori luogo e lo sono tutt’ora, così, ‘casa’, praticando la meditazione, è diventato il mio corpo. Casa precaria, mutevole, fragile, ma con un senso di ritorno, perché è il luogo dove si respira, e il respiro va e torna, torna e va, finché andrà senza ritorno.
Durante la pandemia, ho lasciato la mia casa a Milano, inconsapevole che sarebbe stato per sempre. Ora sono ospite ancora per almeno un anno, nella cascina del mio compagno, sono in transito, aspettando che sia pronta una nostra casa nei boschi. E il bosco è il luogo in cui mi poso, respiro, sono viva senza paura o per mano allo spavento di quello che non conosco.
Un giorno sarà l’infinito la mia casa e pensare alla smisuratezza fa timore. A me piace fare tana ovunque mi trovi e se non posso, vuol dire che non è posto per me.

Le donne di Kabul non hanno casa, ma nascondigli. In India i bambini escono dai ripari di fortuna sotto i temporali con piatti di ferro a raccogliere la grandine: il loro gelato. Nella città ricca in cui ho vissuto, di notte ho visto preparare giacigli improvvisati e dormire per terra sotto le luci dei negozi, perché le luci fanno caldo. Spessissimo quando vado a dormire penso a chi dorme senza casa, a come il sonno non sia un diritto per tutti, a come si possa dormire senza protezione alcuna, nel pericolo.
Così, stare in casa per non diffondere un virus letale non mi sembra sia stato per la maggior parte di noi del primo mondo chissà che terribile sacrificio. Avevamo comunque un luogo riparato in cui stare, per quanto piccolo fosse.
Ma quel che più fa male è che in così pochi consideriamo casa il pianeta in cui viviamo, casa viva, casa da proteggere e custodire.
Nel suo libro Il silenzio è cosa viva lei ricorda che quando la paura bussa, è buona cosa farla entrare. Possiamo iniziare da qui, da quello che è successo e da ciò che, volenti o meno, abbiamo attraversato e, forse, scoperto?
Mi sembra ci sai una grande rimozione intorno alla pandemia e a quello che ci ha segnato dentro e alle comprensioni che speravo si diffondessero di più tra noi. Non sono un profeta di sventura, ma non si può non legare la pandemia alla situazione globale del pianeta e quest’ultima ai nostri comportamenti incuranti e folli, come se il pianeta fosse un fondo da cui attingere infinitamente e senza riguardo, per dargli in cambio veleni, stermini, invasioni, economie predatorie.
Accorgersi di quello che sta succedendo, sentire che tutto è legato e interconnesso, può spaventare, certo, ma anche risvegliare, far fare scelte diverse, comprendere che il patriarcato sta crollando e che si muore, si viene uccisi, perseguitati, si scappa per necessità e si viene trattati come invasori e banditi, tutto questo è collegato. Niente è fuori cornice. E la cornice è la nostra consapevolezza. È la nostra mente che è chiusa in casa, che non vede l’insieme, le interrelazioni. E soprattutto non vediamo che moriamo, non lo sappiamo nelle ossa, nel cuore, fingiamo di niente. Fare scelte alla luce della morte cambia ogni cosa.
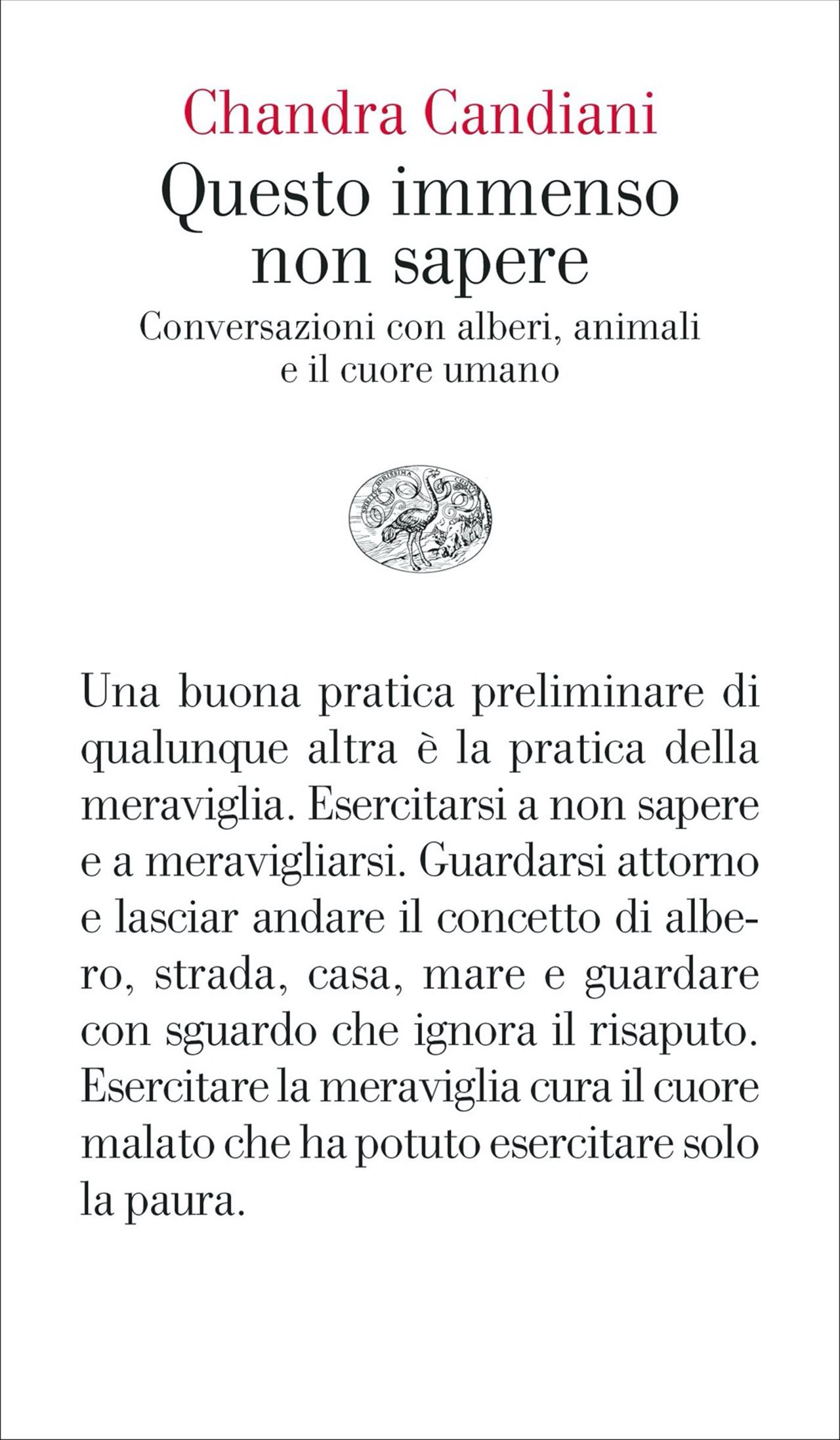
La morte non riguarda solo gli altri, non è un accidente sfortunato, è ovunque e ci chiama in prima persona. Anziché temere che ci paralizzi, sarebbe tempo di sentirlo, di assaporare la nostra finitezza, di percorrere una via del risveglio alla verità dell’essere.
Eppure – penso a come si apre il suo ultimo libro Questo immenso non sapere – nelle case ci sono molte presenze, non solo molte cose. Forse… chiusi nelle nostre case abbiamo avuto paura del mondo, ma forse abbiamo anche scoperto il mondo? (mi ha colpito molto la sua riflessione sulla “meraviglia che cura il cuore malato” e anche la sua riflessione sul cuore come dimora che non ha muri).
Per tanto tempo, ho avuto bisogno di essere una persona da interni, per paura, per goffaggine. Ma in casa ho letto tanti libri che mi hanno accordato il cuore con tante persone diverse, antiche e nuove, in casa ho insegnato meditazione gratuitamente per 25 anni due sere a settimana. In casa ho letto e ricopiato a computer migliaia di poesie di bambine e bambini provenienti da tutto il mondo con cui avevo fatto seminari di parola poetica. Ma la meraviglia è fuori, la meraviglia che risveglia il senso di essere un insieme, un’orchestra, è nei boschi, tra le montagne, nei campi, al mare. La meraviglia si esercita entrando in contatto con il vivente non umano, imparando i suoi linguaggi stranieri, tutto parla, soprattutto chi non ha voce. Uscire e imparare ad ascoltare, a guardare, farsi periferici, studiare il mondo, cantarlo, curarlo e farsi curare: la natura è una Maestra rimasta sola, con pochissimi scolari, che spreco, che occasione mancata. Non solo, che grande pericolo!
L’esperienza che abbiamo vissuto (mi riferisco alla pandemia) ha in qualche modo ridensificato ciò che lei scriveva già nel libro del 2018, soprattutto sulla necessità di lasciar spazio e di aprire un varco oltre il quotidiano… Eppure tardiamo ancora – cito – a cogliere il nesso tra “la paura diffusa, sfondo costante della nostra epoca, di fine del futuro” e “il concetto irresponsabile di crescita e di progresso”…
Siamo spaventatissimi dal cambiamento, dal lasciare le zone sicure, non solo quelle della nostra vita esterna, ma quelle della coscienza. Avventurarci nel non so, nell’errare, nel provare, nel perdere, sbagliare, ripetere. Se non sentiamo il pericolo, come possiamo fare una svolta, una rivoluzione della coscienza? Non si può, senza attraversare la paura. Attaccarci al benessere ci rende ciechi e folli, senza il tremito dell’essere vivi per un po’ e non per sempre, non si costruisce ‘casa’, casa affidabile dentro di sé, casa generosa e ospitale fuori di sé. Scriveva Holderlin: “Là dove c'è il pericolo, cresce anche ciò che salva." Ma se fingiamo che il pericolo non ci sia e continuiamo a vivere in modo irresponsabile, sempre rivolti a un’idea di progresso e di crescita che ha sterminato le foreste, estinto specie e specie di animali, avvelenato corsi d’acqua, svuotato di pesci i mari, inquinato l’aria, insomma distrutto il pianeta, come possiamo non sentire che non ci sarà futuro? Sentendolo, sentendolo nel petto, lasciandoci squassare, forse ci sveglieremo, forse cambieremo vita e atteggiamento verso la vita, forse saremo vivi in un pianeta vivo. A me non sembra che siamo vivi ora, a me sembra che siamo dei sonnambuli sognanti
Una seconda parola che mi viene in mente è “accoglienza”. Accoglienza del mistero, dell’altro, della parola stessa…
Sì accoglienza è una parola vasta. Ma occorre partire dal lato ombra, dalla parete nord. Se non accogliamo la nostra paura, se non scaviamo in cerca dell’ossatura di terrore che ci chiude al mondo e agli altri perché ci chiude a noi stessi, se non ci apriamo alla nostra finitezza e alla mancanza assoluta di fiducia nel mistero di tale finitezza, anche accoglienza diventa solo un sogno, una bella parola per un personaggio virtuoso che recita la sua parte. La parola … la parola è altro da noi, è dono, è un bussare inascoltato, la parola ci visita. L’altro? Noi siamo l’altro, non ci conosciamo affatto, non ci ascoltiamo, ci lasciamo soli e abbandonati a una recita in cui non crediamo più. Se gli alberi sono legname, se gli animali sono carne, uova e latte, se non vediamo più il vivente ovunque, è necessario partire da qui, dalla paura della vita, dall’enormità del mistero del volto dell’altro, perché è l’unico specchio dove poter vedere il nostro.
Una poesia di Pasternak dice:
Ho paura
ho paura
ho paura di dire di cosa ho paura.
“A me puoi dirlo, a me puoi dire di cosa hai paura”. è questo che dovremmo dire a noi stessi nel silenzio della casa interiore e aspettare fremendo la risposta.
Per continuare a leggere clicca qui
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it

