Adolescenza
“Potevamo ancora essere tutto” e noi abbiamo avuto il coraggio di crederci
Un gruppo di adolescenti della periferia sud-ovest di Milano si è incontrato per sei anni ogni settimana al Cde Creta, gestito dalla cooperativa sociale Azione Solidale. Le loro storie (25) sono diventate un romanzo di formazione collettivo pubblicato da Fondazione Feltrinelli. La scrittrice Nicoletta Bortolotti ha raccolto i loro vissuti: «È nella presenza totale e costante di un adulto che dice “io ci sono, sono qui con te” che risiede l’approccio educativo del centro. Un modello da esportare»

Ilaria è diventata puntuale. Oggi ha 23 anni, è una mamma e una studentessa e se deve scegliere a chi dedicare la propria storia risponde con il nome di suo figlio. Vittoria ricorda ogni giorno Aaron Lowi, un uomo morto in un campo di concentramento. Del suo Viaggio della memoria scrive che «forse tutti vanno ad Auschwitz per poter piangere». Oggi è un’educatrice di scuola dell’infanzia, ma ha fatto il test per entrare all’Accademia di Belle Arti. È stata ammessa. E poi c’è Fayssal, consulente informatico di 24 anni. «Se non fossi andato al Cde, avrei smesso con la scuola», dice. «La legge della strada è rude, contempla lo scavalcamento di altre persone, il dover dimostrare sempre di essere il migliore, il più forte. Per quello che mi riguarda, ho deciso di fidarmi perché loro si fidavano di me».
Benvenuti a Milano, periferia sud-ovest, quartieri di Giambellino e Baggio, in parte anche San Siro. È cresciuto in questa fetta di città un gruppo di giovani e adolescenti dai 15 ai 22 anni che dal 2015 al 2021 si è incontrato ogni settimana, anche più volte a settimana, al Cde Creta, un servizio educativo della cooperativa sociale Azione Solidale. Visto da fuori è una luce accesa in tre vetrine di via della Capinera 5: letto in un libro, è un’occasione unica per conoscere il punto di vista, le aspettative, persino la furia di una generazione che il mondo adulto analizza minuziosamente ma a cui non chiede mai (o quasi) che cosa pensa.
Nato grazie al progetto “Storie di Comunità”, presentato da Officina della Produzione in partnership con Azione Solidale e sostenuto da Fondazione Cariplo, il libro è un sogno coltivato da anni dagli educatori che aprono ogni giorno il centro. Il risultato è un romanzo di formazione collettivo pubblicato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli nella collana Scenari, a cui hanno contribuito in prima persona, con i propri vissuti e le proprie parole, le ragazze e i ragazzi del Gruppo Giovani del Cde Creta. La postfazione a cura di Barbara Di Tommaso, Dario Anzani, Stefano Laffi e Jacopo Lareno Faccini aiuta il lettore a stimolare la riflessione e illumina il valore comunitario di tutto il progetto.
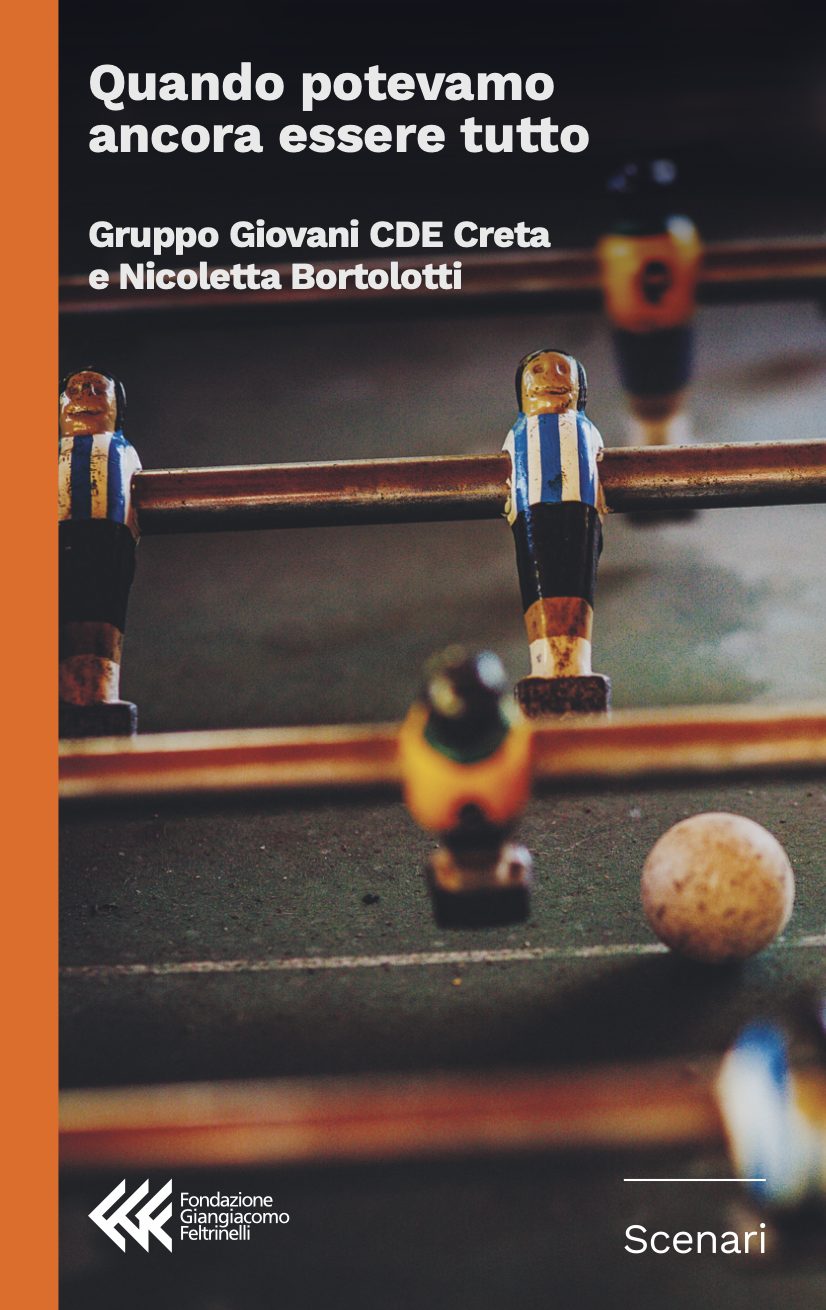
La scrittrice Nicoletta Bortolotti con delicatezza ha saputo entrare in ognuna di queste storie, le ha accompagnate e raccolte, riuscendo ad accordare la propria voce a quella dei protagonisti. L’abbiamo intervistata.
Il titolo Quando potevamo ancora essere tutto è un riferimento dichiarato a una delle frasi più amate di Michela Murgia: «Gli amici che ti fai dai sedici ai vent’anni hanno una specialità che nella vita sarà poi irripetibile. Avrai altre amicizie, anche molto qualificate, ma qualcuno che ti fosse testimone quando potevi ancora essere tutto… Quello non si ripete». Che cosa e chi potevano essere i protagonisti di questo libro e chi sono diventati, se è già possibile vederlo?
Il titolo allude alla potenzialità massima dell’adolescenza, un momento in cui per i ragazzi sono aperte tutte le scelte, le possibilità e le definizioni. Quel poter essere, nel caso del libro, si esplica nell’intercettare un incontro: molti di questi ragazzi e ragazze vengono da situazioni anche difficili, ma con l’incontro giusto (che in questo caso è stato il Cde) la potenzialità si è potuta esplicare nella realtà. Quello che colpisce, ed è un aspetto che ha sorpreso anche me, è che tutte queste storie sono a lieto fine: la prova dell’efficacia di un metodo di lavoro. Attraverso il racconto delle difficoltà e dei dolori che hanno attraversato, le vite di questi giovani raccontano una speranza. Alcuni provengono da contesti anche terribili, eppure la maggior parte oggi lavora, si è laureato o si sta pagano l’università per non essere di peso alla famiglia. Danno una lezione importante sulla capacità di costruirsi una strada fatta a mano, con le loro mani, al di là degli stereotipi o dei percorsi già tracciati.
Ogni capitolo è un attraversamento di quella frontiera affascinante e pericolosa insieme che è l’adolescenza: per ogni ragazza e ogni ragazzo (in totale 25) ci sono una parola in apertura con la sua etimologia, la dedica a qualcuno o a qualcosa, e una canzone. Perché?
Mi sono trovata di fronte a un magma di materiale vivo: non era soltanto la loro voce, c’erano il loro racconto, la loro fiducia, il loro legame nei confronti del Cde. In un’ora e mezza di colloquio a porte chiuse questi ragazzi si sono affidati, consegnandomi episodi molto intimi e personali, consapevoli che forse sarebbero finiti in un libro. Nella prima parte delle interviste emergevano le informazioni più esterne rispetto agli studi compiuti e al lavoro, nell’ultima parte incominciavano a emergere le emozioni, le storie familiari, i buchi neri. A questo materiale multiforme bisognava dare un filo rosso, una struttura: nel definirla, mi è venuta in soccorso la mia esperienza editoriale nei libri per ragazzi. Ho trovato un modello nei Sillabari di Goffredo Parise, una raccolta di racconti costruita alfabeticamente sulle emozioni: per ogni giovane ho colto un’emozione centrale e mi sono accorta che nell’etimologia della parola si evincevano somiglianze incredibili con la singola storia. La dedica è venuta da sé, abbinata ai nomi dei protagonisti. È loro l’idea di una sorta di colonna sonora che potesse accompagnare la lettura.
Volevo far emergere le voci, mantenere il linguaggio molto colloquiale, “di strada”, dei ragazzi, ma facendone emergere la poesia profonda
Nicoletta Bortolotti, scrittrice
Come si lavora a un libro collettivo, scrivendo insieme a chi si sta raccontando?
Anche in questo caso mi sono lasciata guidare da un libro, Preghiera per Černobyl di Svetlana Aleksievic, che cola sulla pagina una raccolta di interviste a persone che hanno vissuto la tragedia nucleare, aggiungendo come unico filtro la poesia. Volevo far emergere le voci che ho raccolto in registrazione, mantenere il linguaggio molto colloquiale, “di strada”, dei ragazzi, ma facendone emergere la poesia profonda. Un impasto stilistico fatto di un linguaggio basso con qualche accensione di linguaggio più alto.
Ci sono due figure dentro ogni capitolo, sono nelle parole e nei pensieri dei ragazzi. Sono gli educatori del Centro Giovani, Luca e Judie. Nella prefazione descrivono il loro mestiere «un lavoro che sa spesso di asfalto, sangue e merda. […] Ma sa anche di rivincita e di possibilità di prendere in mano la propria vita, di sapere che qualcuno è lì per loro, ad aspettarli». La loro presenza, a volte intuita, altre volte preponderante, restituisce il peso di una professione incompresa e sottovalutata.
Avevo conosciuto Luca e Judie anni fa per un libro precedente, ma prima di sentire i ragazzi non avevo compreso a pieno la profondità del loro lavoro e soprattutto la forza della loro presenza nella relazione. Credo sia questa la ragione del successo del Cde e di queste vite, se per successo intendiamo la realizzazione del proprio sé. Molti intervistati riportano che Luca c’è sempre, anche di notte: le maggiori rivelazioni nelle vicende raccontate sono notturne, come spesso succede con gli adolescenti. È in questa presenza totale e costante di un adulto che dice “io ci sono, io sono qui con te” che risiede l’approccio educativo del Centro: lo stare. E poi c’è un concetto, su cui i due educatori insistono: la ricombinazione sociale. Al Cde approdano ragazzi che vivono in quartieri complicati ma anche ragazze e ragazzi di provenienze sociali diverse, che non sapevano bene che cosa fare della loro vita e, a partire da un doposcuola, si sono trovati coinvolti in un percorso di crescita. È così che si mescolano mondi e situazioni, in un laboratorio sociale in cui i “tamarri” (le parole sono dei ragazzi) e i “marconiani” (quelli del Liceo Marconi) si incontrano, fanno amicizia, si innamorano. La domanda è: fuori potrebbe accadere che un marconiano offre un aperitivo a un tamarro? È possibile costruire legami veri, profondi, nonostante le differenze sociali ed economiche? Il quesito rimane aperto. Il cammino di scoperta, introspezione e capacità di analisi compiuto al Cde conta: è una forma di educazione alla diversità e alla tolleranza delle differenze, un modello che sarebbe da esportare.

Che cosa ha capito sull’adolescenza?
Fare questo lavoro mi ha molto coinvolta, a volte persino troppo. È stato un percorso forte a livello emotivo, anche come genitore. Da un lato, mi ha fatto ritornare alla mia adolescenza, alla sensazione di difficoltà nello stare in un gruppo nuovo, al disorientamento del non sapere chi si è, alla fatica di cercare il proprio blocco di marmo. Mi ha fatto anche pensare che, se all’epoca avessi trovato un Cde, mi sarebbe stato molto utile. Da madre, mi ha turbato e al tempo stesso mi ha regalato una consapevolezza nuova, perché mi sono vista nei racconti di questi giovani sui loro genitori.
Un ragazzo ha dedicato la sua storia «ai parchi dove ci si bacia e ci si lascia», un altro «alle città libere». Lei a chi dedica questo volume?
A 25 giovani che ce l’hanno fatta, ai miei figli e alla me adolescente.

Agli adolescenti, e a quello che non vediamo, VITA ha dedicato il magazine a giugno. Se hai un abbonamento leggilo subito qui e grazie per il tuo sostegno. Se vuoi abbonarti puoi farlo a questo link.
Le fotografie sono state fornite dal Cde Creta di Milano
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.
