«Troppo spesso oggi la comunicazione non genera speranza, ma paura e disperazione, pregiudizio e rancore, fanatismo e addirittura odio». Nella Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Papa Francesco aveva invitato a cercare la speranza nelle storie. Il suo successore Leone XIV lo ha ribadito non più tardi di una settimana fa: «Soltanto una comunicazione disarmata e disarmante permette di offrire una nuova visione del mondo, più coerente con la dignità umana». Per chi fa il mestiere di giornalista oggi, in un’epoca in cui in Italia la fiducia nelle notizie è al 34% (Reuters Digital News Report 2024) e cresce la disaffezione per l’attualità in nome di quella che in gergo si chiama news avoidance, ovvero la tendenza a evitare le notizie tra assuefazione e smarrimento di fronte a scenari di guerra, queste parole risuonano in modo speciale. Da oltre vent’anni, esperti e operatori si interrogano e cercano nuove strade per fare anche del giornalismo un’attività a impatto. Un’azione costruttiva anziché distruttiva, soluzioni oltre i problemi.
Oggi, in tutto il mondo, sono centinaia le esperienze che stanno guidando un cambiamento globale nel giornalismo. Un approccio che anche in Italia si sta affermando come bussola per rilanciare il ruolo etico e civile dell’informazione. È in questo contesto che si colloca l’Impact Journalism Spring Lab, un progetto formativo che fino al 24 maggio trova casa in Piemonte, realizzato da Torino Social Impact e dal Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino in collaborazione Anso – Associazione Nazionale Stampa Online e con il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte. Al centro, una narrazione orientata al cambiamento, che non si limita a raccontare il mondo ma si propone di migliorarlo, a partire da una relazione forte con persone, comunità e territori. Punto di partenza, l’iniziativa dello scorso anno Torino Impact Journalism.
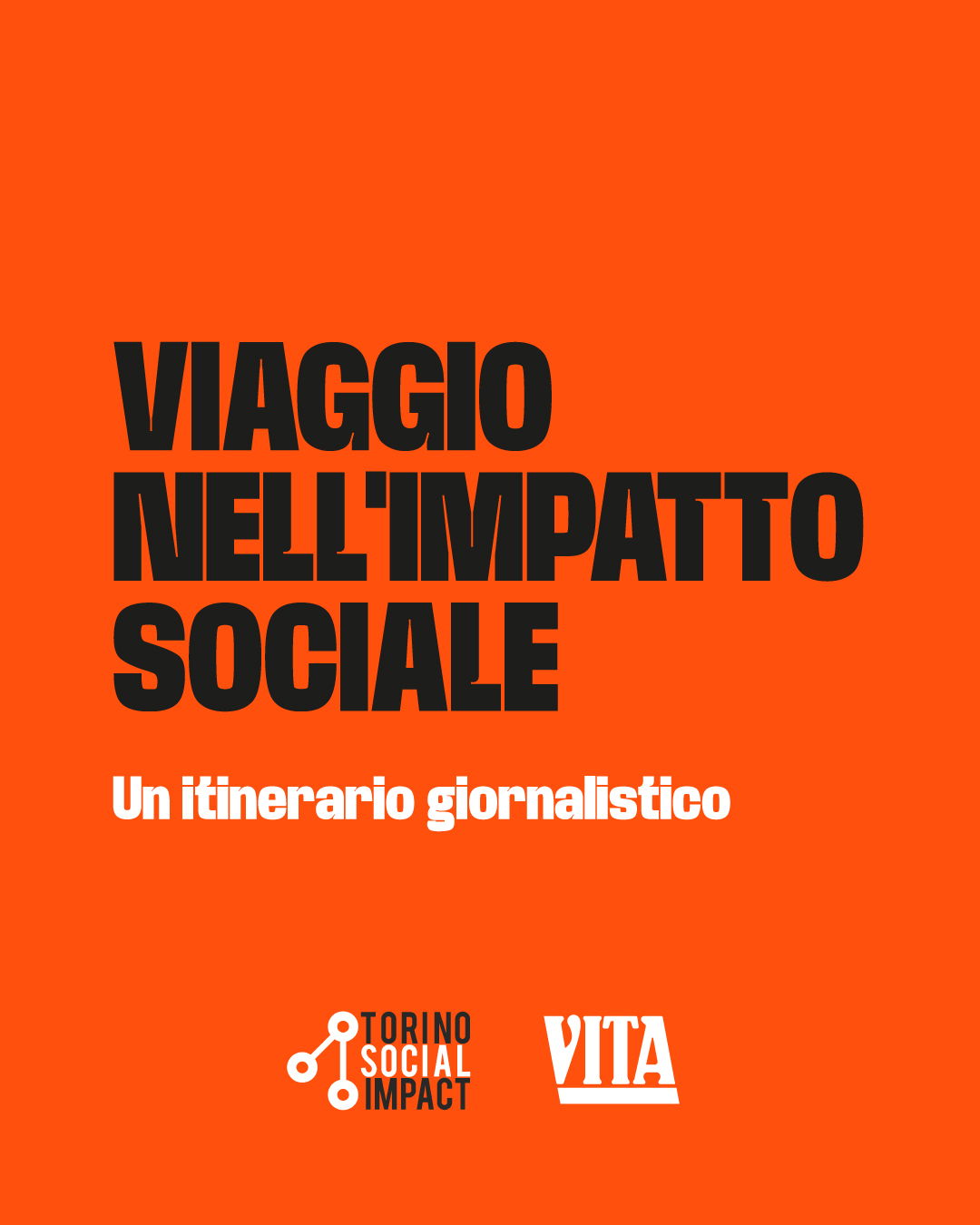
Tra le voci dei big del Constructive Journalism a livello internazionale, c’è quella di Richard Addy, che ha incontrato a Palazzo Venturi gli studenti della Spring Lab. Esperto di strategia, audience, comunicazione e impatto, insieme a Luba Kassova ha fondato Akas, una società di consulenza in materia di audience strategy che si rivolge a media, istituzioni internazionali, fondazioni e ong con l’obiettivo di aumentare l’impatto attraverso la comprensione del pubblico di riferimento, degli stakeholder e degli ecosistemi. Membro del Consiglio di amministrazione di theguardian.org e Africa No Filter, ha una lunga esperienza come stratega ed economista, ha fornito consulenze a ceo, ministri e leader e ha preparato le strategie digitali, editoriali e di audience della Bbc.
Cosa intendiamo oggi quando parliamo di giornalismo d’impatto?
Questa è una domanda molto interessante perché, chiedendo a più giornalisti cosa pensano dell’impatto, si possono ottenere un sacco di ragioni o aspetti diversi da misurare. Quando io penso all’impatto, penso al fare la differenza attraverso il giornalismo. Questa differenza può essere piccola o molto grande. Può essere una storia esclusiva o un’informazione in grado di raggiungere un sacco di persone che a loro volta intraprenderanno un’azione, impareranno qualcosa, cambieranno opinione rispetto a un tema o si sentiranno più influenti. Può accadere addirittura che il governo prenda una decisione o modifichi l’importo di un finanziamento.

Perché ha scelto questo ambito di ricerca?
Sono entrato in un’organizzazione giornalistica soltanto nell’ultima parte della mia carriera. Eppure, ho sempre collezionato articoli ritagliati. Ho probabilmente 100mila articoli conservati a casa. Lo faccio da quando avevo 15 o 16 anni. Ho sempre amato i giornali e gli articoli di giornale. Quando mi sono unito alla Bbc, ero il consulente del vicedirettore generale. Mentre facevo quel lavoro, mi sono spesso trovato a spiegare perché il giornalismo è così importante nella società. Ho capito che i giornalisti lo danno per scontato, ma il pubblico non sempre ne è consapevole. Quindi la storia dell’impatto deve essere raccontata in modo molto più efficace.
In che modo oggi l’informazione può contribuire al cambio di paradigma economico, ambientale e sociale?
Il giornalismo può fare molte cose. Può portare a un’azione immediata, mettendo a disposizione degli attori della società e del pubblico un maggior numero di informazioni su vari temi. E poi c’è un aspetto molto importante, che riguarda quelle che chiamiamo narrazioni. Il giornalismo e l’informazione sono fondamentali per costruire il bagaglio di competenze con cui le persone guardano il mondo. Le narrazioni governano davvero il modo in cui vengono prese le decisioni: in questo periodo mi sto occupando proprio di come le narrazioni più diffuse nei singoli Paesi ne influenzino le scelte.
Non si tratta di censurare le cattive notizie, ma di essere costruttivi, di cercare i luoghi nel mondo in cui di fronte allo stesso problema sono state individuate soluzioni. Occorre lasciare nel pubblico un senso di speranza
Richard Addy, esperto di strategia, audience, comunicazione e impatto
Come si misura l’impatto sociale di una notizia?
Ci sono vari modi. La prima cosa che i giornalisti possono fare è raccogliere le informazioni che conoscono in modo strutturato. Si chiama tracker di impatto: è uno strumento utile perché consente di visualizzare come il giornalismo abbia fatto la differenza in ottica qualitativa. In termini quantitativi, si può tenere traccia dei commenti, del numero di lettori, degli inoltri e delle citazioni. Fondamentali sono i collegamenti, un metodo di misurazione incredibilmente potente: se un’istituzione, un’università o una Fondazione attiva un link a un articolo, significa che lo apprezza e che lo ritiene autorevole.
La fiducia nelle notizie in Italia è al 34%. Il Solution o Constructive Journalism possono contribuire a modificare questo dato?
La posizione del giornalismo italiano deve essere letta nel contesto del giornalismo in generale. Stiamo osservando la tendenza delle persone a non seguire le notizie, a non essere interessate all’informazione tanto quanto lo erano dieci anni fa. Non è un fenomeno specificatamente italiano, e si somma alla percezione, aumentata soprattutto dopo la pandemia, che le notizie siano prevalentemente negative. Il giornalismo oggi si trova di fronte a una vera sfida che riguarda non soltanto la produzione delle notizie, ma soprattutto il modo in cui vengono date. Non si tratta di censurare le cattive notizie, ma di essere costruttivi, di cercare i luoghi nel mondo in cui di fronte allo stesso problema sono state individuate soluzioni. Occorre lasciare nel pubblico un senso di speranza. Non solo. Spesso i giornalisti danno per scontati i dettagli, e invece ogni storia va contestualizzata affinché venga compresa in modo chiaro da tutti. L’altra dimensione riguarda la rappresentazione nel giornalismo. Un esempio? Le donne sono sottorappresentate nei notiziari: lo sono ai livelli più alti della professione, lo sono nelle fonti e tra i protagonisti delle storie, in prevalenza maschili. I temi che interessano alle donne spesso non sono coperti e lo stesso meccanismo riguarda i giovani. È un problema di agenda.

La storia di un impatto che l’ha colpita in modo particolare.
Mi viene in mente una serie tv inglese che risale a un paio di anni fa sul caso di alcuni lavoratori di un ufficio postale accusati ingiustamente di aver rubato del denaro. In realtà, il problema era nel software che stavano usando: era difettoso. Di questo scandalo si era già parlato molto, ma soltanto con l’uscita della serie si è accesa l’indignazione. Questo è l’esempio di quanto il mezzo che scegliamo per restituire una storia possa avere un impatto sulla società.
Lei è nel consiglio di amministrazione di Africa No Filter, ong che lavora per sfidare e cambiare le narrazioni dannose sull’Africa, amplificando storie autentiche e diverse dal continente. Siete riusciti a cambiare la percezione?
L’esperienza di Africa No Filter è iniziata tre o quattro anni fa. È un’organizzazione molto piccola, eppure abbiamo fatto una valutazione d’impatto. Ho grande fiducia nel dire che, nonostante le sue piccole dimensioni, ha fatto e farà una differenza molto grande nel portare le organizzazioni a riflettere sui modelli a cui fanno riferimento quando si occupano di singoli Paesi africani o sul continente africano in generale.

Cinque cose che un giornalista deve tenere a mente per diventare motore di un cambiamento positivo.
Innanzitutto, bisogna conoscere la propria audience nel profondo, come se fosse un’amica: non intendo soltanto capire su cosa il pubblico stia cliccando o cosa stia condividendo, ma sapere come si sente, quali sono le sue preoccupazioni, cosa lo motiva, quali sono i suoi valori. Poi, essere molto chiari sul valore aggiunto che si vuole portare: bisogna sempre porsi questa domanda prima di scrivere una storia. In terzo luogo, pensare alle emozioni che si stanno evocando nel pubblico e a quelle che si vogliono trasmettere: se dopo aver scritto dieci articoli ci si accorge che tutti fanno sentire il pubblico depresso e triste, allora bisogna chiedersi perché non si è riusciti a portare nemmeno uno spiraglio di speranza. Quattro: non concentrarsi sul singolo articolo che si sta scrivendo qui e ora, ma chiedersi in quale viaggio si voglia condurre il proprio pubblico. In questo modo si potrà raccontare qualcosa di molto più profondo, una complessità molto più sfumata: a lungo termine si potrà dire di aver contribuito a cambiare il mondo. Infine, prendere consapevolezza del fatto che non basta pubblicare un articolo: bisogna condividerlo e guidare il lettore a comprenderne il contenuto, uscire dalla propria comunità, incontrare persone. Il giornalismo deve entrare a far parte della vita delle persone.

Questo articolo fa parte di una serie intitolata Viaggio nell’impatto sociale. Leggi anche:
Senza un’idea di giustizia sociale non c’è impatto
Alla ricerca dell’impatto perduto: la lezione di una crisi industriale
Il turismo sostenibile è la prossima destinazione
Le fotografie sono di Lorena Di Maria (Torino Social Impact) e dell’autrice dell’articolo
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it

