Ambiente
Greenpeace presenta il conto della crisi climatica
Presentato al Siciliambiente Film Festival di San Vito Lo Capo, “Il prezzo che paghiamo” di Sara Manisera: non è solo un documentario, ma la cronaca puntuale del legame tra crisi climatica e industria fossile. A produrlo Greenpeace Italia e ReCommon. In dialogo con Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia
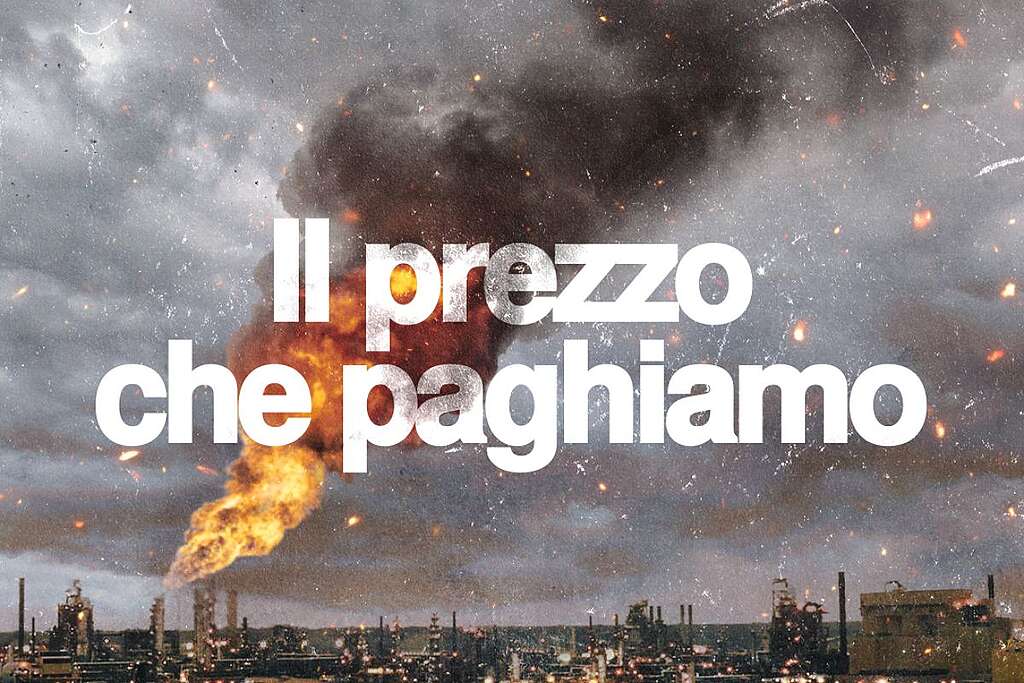
il coraggio di andare dritto al punto, non omettendo nulla, anzi. Il prezzo che paghiamo è il racconto crudo e autentico di come la crisi climatica sia diventata ormai una costante della nostra vita quotidiana e di come siano le persone più fragili e povere a pagare il prezzo più alto di scelte che riguardano gli interessi di pochi. Ancor di più quando le persone non ne hanno abbastanza consapevolezza da potere fare qualcosa. Pagano, così, le conseguenze degli interessi che ignorano le evidenze scientifiche e non si curano delle conseguenze per il pianeta e per le generazioni future. Il prezzo che paghiamo è il titolo del documentario prodotto da Greenpeace Italia e ReCommon, realizzato dal collettivo Fada e diretto da Sara Manisera. Il documentario è stato presentato alla 17esima edizione del Siciliambiente film festival, in corso a San Vito Lo Capo.
«Il documentario cerca di far vedere che i fenomeni che noi ancora ci ostiniamo a ritenere passeggeri stanno invece diventando strutturali», afferma Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia. «Il prezzo che paghiamo è anche un modo per presentare i risultati del monitoraggio dei media e dei social che realizziamo da tre anni e che ci porta a dire che da parte dei principali organi di informazione nazionali e regionali c’è stato un calo della copertura sulla crisi climatica. Di crisi climatica si parla poco e male, anche quando si parla di relazione con i combustibili fossili, Non si è ancora passato con sufficiente chiarezza che le emissioni sono legate ai nostri comportamenti, per esempio quando accendiamo il fornello di casa, ma anche a un sistema di produzione e consumo che è basato ancora sui combustibili fossili: sul cambiamento del sistema c’è una grandissima campagna di ostruzionismo. Il tentativo in atto è quello di bloccare una transizione che altrove sta andando un po’ più velocemente».
Stiamo monitorando i media e i social da tre anni: da parte dei principali organi di informazione nazionali e regionali c’è stato un calo della copertura sulla crisi climatica. Di crisi climatica si parla poco e male
Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia
Una transizione alla quale noi tutti dovremmo porre maggiore attenzione, in quanto ci pone innanzi ai vari cambiamenti epocali. «I cambiamenti da un lato riguardano la crisi climatica, della quale dobbiamo prendere atto», aggiunge Onufrio, «dall’altro il tema delle tecnologie. In questo campo la Cina è avanti agli altri semplicemente perché investe in maniera coerente da vent’anni. Ha una politica industriale molto determinata e lascia indietro tutti. Dopo di lei c’è l’Europa, gli Stati Uniti, in fondo alla classifica di questa transizione c’è la Russia, ci sono i Paesi produttori di petrolio, anche se alcuni di questi hanno iniziato da qualche anno a investire pesantemente anche nell’alternativa. L’Italia? Noi siamo un paese di media o bassa classifica. Avevamo iniziato negli anni ’90 a produrre il fotovoltaico, ma già alla fine di quel decennio si è deciso che si non doveva più andare avanti. A chi abbiamo venduto l’unica fabbrica di proprietà dell’Eni, vicino a Roma? Ai cinesi. Tutte queste cose si fa fatica a farle capire alle persone anche perché ci sono persone a cui sapere queste cose non piace. Oggi, secondo me, ci troviamo in una situazione di rischio legata al fatto che siamo di fronte a un cambio di guida nell’economia e nella tecnologia, per cui occorrerebbe discutere e negoziare. Vediamo, invece, che la reazione è ostile, armata. In questi passaggi di grandi cambiamenti della storia purtroppo, la specie umana risolve le contraddizioni con la guerra che infatti incombe su tutti noi».
Sono i poveri a pagare il prezzo più alto anche perché non sono messi nelle condizioni di sapere chi e perché ha deciso di gestire il loro destino
Giuseppe Onufrio, direttore di Greenpeace Italia
Lo sforzo fatto da Greenpeace, con il documentario Il prezzo che paghiamo, è quindi quello di ribadire con chiarezza «che questa crisi colpisce di più i poveri, ricordando quel che diceva papa Francesco e cioè che “i poveri pagano il prezzo più alto”. Questo è vero perché hanno meno risorse per difendersi, ma anche perché i poveri vivono in quelle aree con maggiore stress di desertificazione e di cambiamento. Attenzione, però: la crisi climatica colpisce anche i Paesi ricchi, colpisce l’Emilia Romagna e la Basilicata – le due regioni su cui abbiamo focalizzato il lavoro nel documentario – come anche la California, l’Australia, l’India, la stessa Cina», spiega Onufrio.
Il prezzo che paghiamo, infatti, dà spazio alle voci di chi del cambiamento climatico ne subisce già gli effetti più diretti e drammatici. Come quella di Maria Gordini, agricoltrice dell’ Emilia-Romagna che ha perso la sua casa e l’azienda a causa delle alluvioni del 2023 e 2024. O come quelle di Camilla Nigro, Isabella Abate e Giorgio Santoriello, abitanti della Basilicata, che raccontano cosa significa vivere in un territorio che ospita il più grande giacimento petrolifero su terra dell’Europa occidentale, segnato da decenni di trivellazioni.
Storie di resilienza appartenenti a chi dalla propria terra non vuole andare via, per non perdere le proprie radici ma anche per non darla vinta a chi continua a sfruttare il territorio senza considerare le devastanti ricadute sociali, ambientali ed economiche. Ma anche per continuare a tenere alta l’attenzione dei media che – vuoi per superficialità, incapacità di guardare oltre e interessi – non danno con sufficiente chiarezza il messaggio che la crisi climatica non riguarda solo il cambiamento delle temperature, ma ha un raggio di azione immenso, che ha a che fare con la contaminazione delle terre e delle acque le alluvioni egli eventi climatici estremi: tutti fenomeni di cui le compagnie fossili sono tra i principali responsabili.

«Questo legame con le fonti fossili è un legame che la comunicazione troppo spesso cerca di nascondere. Da un lato cerca di sostenere tesi terribili sulle rinnovabili, e dall’altro non dice che è questa è l’unica tecnologia che consente di chiudere con il gas, di produrre elettricità pulita per darla alle auto, riducendo l’effetto devastante che l’energia sporca ha sul clima. Purtroppo oggi sono pochissimi i produttori di fonti rinnovabili. Dobbiamo fare delle scelte a basso impatto ambientale, cercare di muoverci in un’altra maniera, facendo pressione affinché le cose cambino. L’idea che un cittadino non possa rinunciare all’auto perché nella sua città i servizi di trasporto pubblico sono molto scarsi non ha senso: l’alternativa non può essere responsabilità del cittadino, ma delle politiche pubbliche che non dovrebbero costruirla», prosegue il direttore di Greenpeace.
Alla fine, Il prezzo che paghiamo che messaggio ci lascia? «L’obiettivo prioritario è quello di rappresentare il fatto che già oggi vediamo i danni che stiamo pagando. E possiamo anche sapere con esattezza anche quali sono gli impatti che abbiamo sull’ambiente quando facciamo, per esempio, il pieno di benzina alla nostra auto. Ci sono anche impatti locali che colpiscono le popolazioni che abitano vicino alle zone di produzione delle fonti fossili. In Basilicata, per esempio, il documentario ci fa vedere come il potere dei soldi sia in grado di narcotizzare la situazione, anche se c’è sempre una società civile critica che agisce, seppure con grande difficoltà. Questo documentario vuole fare memoria, informazione ed elevare il livello di consapevolezza e di coscienza critica. Come sappiamo, la forza dei film e del cinema è quella di arrivare e di imprimere molto più di mille libri o parole».

Siciliambiente Film Festival
Il Siciliambiente film festival è promosso dal Comune di San Vito Lo Capo, da Demetra Produzioni e dall’associazione culturale Cantiere 7 in collaborazione con partner come Greenpeace Italia, Amnesty International, AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e Ttpixel. Si tratta di un evento internazionale dedicato al cinema indipendente, che mette al centro temi come ambiente, diritti umani, conflitti e trasformazioni: cinquanta le opere presentate. L’obiettivo è fare riflettere su tanti temi, primo tra tutto quello ambientale, lanciando un allarme.
«La nostra maggiore attenzione va allo sviluppo sostenibile e alle tematiche ambientali», spiega il direttore del Festival, Antonio Bellia, «senza però dimenticare i diritti. Quest’anno abbiamo una nuova sezione dedicata alla salute del mare e dei suoi fondali, un omaggio al territorio che ci ospita da 17 anni, ma anche un impegno a comprendere qual è lo stato di salute delle nostre splendide acque. Il linguaggio audiovisivo negli ultimi anni sta diventando uno strumento di informazione anche per il mondo scientifico e questa è sicuramente un tappa importante: vuole dire che il sistema di educazione ambientale su cui noi lavoriamo da tanti anni, attraverso il cinema d’autore, comincia a entrare di diritto anche nella formazione e nella diffusione della scienza. Anche il documentario di Greenpeace utilizza il cinema come strumento, per poi affrontare una serie di temi di educazione ambientale dei quali la scuola oggi si fa – o si dovrebbe fare – portatrice».
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
