Giustizia
Carceri: causa sovraffollamento, il detenuto torna a casa
Per la prima volta un uomo ristretto nel carcere "Lorusso e Cotugno" di Torino ha ottenuto di scontare la pena ai domiciliari (anche) in ragione delle condizioni di sovraffollamento. L'uomo ha delle patologie, che erano state valutate come compatibili con la vita in carcere: con l'attuale situazione dell’istituto di pena, però, le condizioni sono diventate insopportabili. Maria Brucale, membro dell'Osservatorio carcere dell'Unione camere penali italiane: «Questa pronuncia ha il merito di riconoscere l’afflizione aggiuntiva prodotta per i detenuti dallo stato indecoroso delle nostre prigioni»

Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha stabilito che la condizione di celle stipate oltre ogni limite può diventare un importante elemento per la concessione della pena a domicilio. Il caso riguarda un detenuto del carcere “Lorusso e Cotugno”, che oggi registra un tasso di sovraffollamento oltre il 130%. «Quest’ordinanza del 5 agosto 2025 è importante perché mette per iscritto che in condizioni così gravi di sovraffollamento una persona che già è malata, per quanto non incompatibile col carcere, raggiunge una afflizione che non è più coerente con i principi di umanità che devono presiedere a ogni incarcerazione. Il mio timore è che, a fronte di una detenzione più lunga, questo ragionamento sull’umanità della pena verrebbe meno». dice Maria Brucale, membro dell’Osservatorio carcere unione camere penali italiane, Ucpi.
Riconoscimento dell’afflizione aggiuntiva prodotta dallo stato indecoroso delle carceri
«L’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino, per certi aspetti, palesa tra le righe un atteggiamento non infrequente delle aree sanitarie delle carceri che è quello di ridimensionare la sofferenza delle persone detenute», dice Brucale. Nell’ordinanza si legge che, in un primo momento, l’area sanitaria aveva escluso la gravità delle patologie di questa persona, poi però aveva affermato che c’era la possibilità di trasferirla per la cura in un altro luogo, sempre intramurario, dando contezza del fatto che le patologie c’erano ed erano anche importanti».
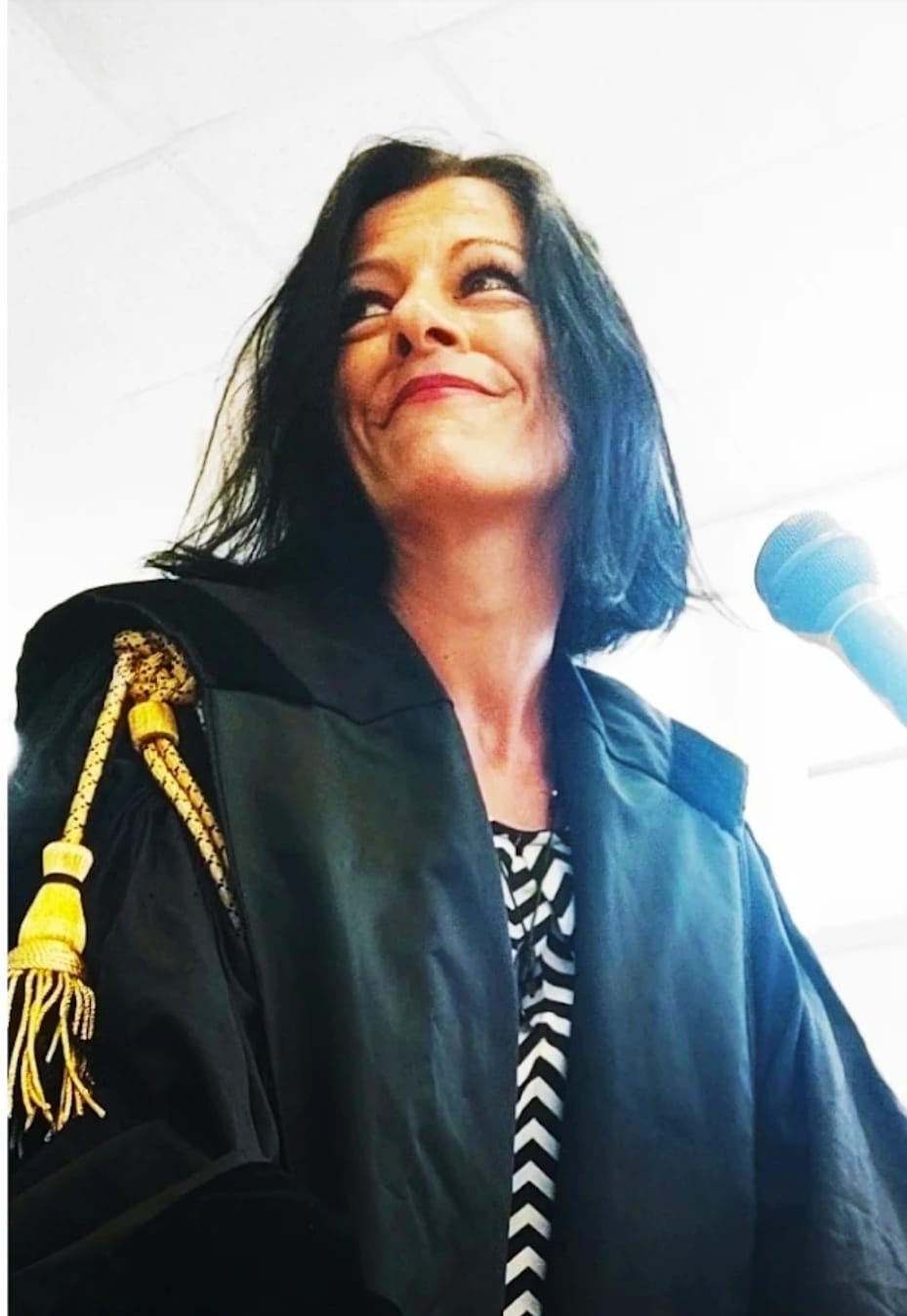
«Nel caso in questione, l’area sanitaria – da quel che si legge – ha dichiarato che le patologie non erano gravi, erano sotto controllo e potevano essere gestite in un altro istituto. Deduco insomma che ci fossero e che meritassero attenzione. Il primo magistrato di sorveglianza che ha valutato la situazione ha escluso che ci fosse l’incompatibilità delle malattie con la vita nell’istituto penitenziario e ha rigettato la richiesta di scontare la pena ai domiciliari», continua l’avvocato. Dopodiché il tribunale di sorveglianza di Torino, in sede di reclamo, «ha posto in perequazione la sofferenza derivante dalle condizioni di salute con le condizioni detentive, quindi con il sovraffollamento e la mancanza di adeguatezza degli spazi. Ha affermato che, con il concorso delle due situazioni (la sofferenza di salute e la sofferenza intramuraria derivante dal sovraffollamento), la pena risultava inumana e degradante e ha concesso la misura di favore. Questa pronuncia ha il merito di riconoscere l’afflizione aggiuntiva prodotta ai ristretti dallo stato indecoroso delle nostre prigioni».
La pena residua esigua: ragione importante dell’ordinanza
«Purtroppo, però, l’ordinanza mi rallegra fino a un certo punto perché lo sguardo del giurista va al caso di specie, che è di una persona alla quale mancavano più o meno due anni di pena per la fine della sua condanna. Quindi, un tempo davvero piccolo rispetto all’enfasi che ha seguito la pronuncia», prosegue Brucale. «Quando mancano due anni alla fine della pena, in termini di prognosi della riabilitazione, è difficile ipotizzare un percorso di rieducazione e di reinserimento. Il mio timore è che, a fronte di una detenzione più lunga, questo ragionamento sull’umanità della pena verrebbe meno».
Altre decisioni del genere? Non con la stessa motivazione
Analoghe decisioni ci sono già state, «di una a Roma me ne sono occupata io, anche se non ha avuto una motivazione così accurata e specifica». In quel caso, i giudici hanno concesso la detenzione domiciliare a una persona che aveva in corso un’espiazione di cinque anni, quindi più grave di quella del recente caso di Torino, «scrivendo semplicemente che dal momento che il carcere non garantiva la possibilità di usufruire delle scorte per accompagnare questa persona a eseguire gli interventi necessari in ragione delle sue condizioni di salute, la misura alternativa veniva concessa. Purtroppo gli agenti penitenziari sono pochi e ciò crea non pochi problemi».
Nel carcere di Rebibbia Nuovo complesso, che ospita circa 1.600 detenuti ci sono oltre 2mila richieste di visite inevase, presso gli ospedali, i luoghi di cura e di intervento chirurgico
Maria Brucale, membro dell’Osservatorio carcere unione camere penali italiane
Rebibbia: oltre 2mila richieste di visite mediche inevase
Nel carcere di Rebibbia Nuovo complesso, che ospita circa 1.600 detenuti, ci sono oltre 2mila richieste di visite inevase, presso gli ospedali, i luoghi di cura e di intervento chirurgico, spiega Brucale. «Naturalmente tra queste 2mila ce ne saranno tante che non rivestono carattere di estrema urgenza, ma ci sono anche le chemioterapie, gli interventi chirurgici di tumore, i salvavita, quelli cardiaci. Insomma, c’è veramente una disperazione totale. Quindi, le due cose sono strettamente connesse perché la mancanza di scorte è una delle conseguenze del sovraffollamento».
Richieste di domiciliari (per chi un domicilio ce l’ha)
Rebibbia si compone di quattro istituti detentivi, «con un carico di umanità dolente impressionante. Il nucleo traduzioni della Polizia penitenziaria conta circa 190 unità e dovrebbe occuparsi delle condizioni sanitarie e delle esigenze dei trasporti di tutte le persone detenute nel polo di Rebibbia. È completamente irragionevole, non è proprio in grado di essere sufficiente. Succede che una persona, per qualunque tipo di visita, deve attendere un sistema che è completamente al collasso, per cui inevitabilmente si accede a richieste di detenzione domiciliare quando è possibile», continua. «Ma molte di queste persone sono così indigenti e sole da non avere nemmeno un domicilio dove chiedere di andare. A questo dovrebbe sopperire la politica, inventando delle strutture nuove dove allocare le persone che hanno un fine pena a breve, che hanno esigenze di cura e che non possono essere adeguatamente gestite nelle carceri». C’è un appalto in corso che prevede la costruzione di container in otto carceri, «solo la parola “container” mi fa orrore».
Aumento delle richieste di detenzione domiciliare collegate alle condizioni di salute
Le richieste di detenzione domiciliare «sono tantissime, soprattutto perché le persone malate, per qualunque cura, hanno l’esigenza di uscire dal carcere accompagnate dalle scorte negli ospedali. E gli agenti non sono sufficienti, al punto che cominciano a non esserci nemmeno per permettere alle persone di partecipare alle loro udienze. La richiesta di beneficio di una pena alternativa al carcere viene fatta da chiunque si trovi nella condizione di farla». Una pena sotto i quattro anni consente una richiesta di misura alternativa. «Ripeto, quest’’ordinanza è importante perché mette per iscritto che in condizioni così gravi di sovraffollamento una persona che già è malata, per quanto non incompatibile col carcere, raggiunge una afflizione che non è più coerente con i principi di umanità che devono presiedere a ogni incarcerazione. Ma la ridimensiono perché purtroppo, da pratica della materia, so bene che la misura scaturisce dal fatto che questa persona aveva ancora poco tempo da espiare».
Se per un sospetto tumore si rinvia un accertamento per otto volte
Le richieste di detenzione domiciliare che sono in aumento «sono quelle di misure alternative collegate alle condizioni di salute. Molte situazioni potrebbero essere gestite in ambito intramurario, qualora il sistema penitenziario funzionasse meglio. Se si ha un sospetto tumore e si rinvia per otto volte la visita per un accertamento, è chiaro che insorge anche uno stato emotivo che rende intollerabile la propria carcerazione. Ipotizziamo questa situazione in un ambito di vita ordinaria. Qualora mi dicessero che, dalle mie indagini cliniche, c’è il sospetto che io abbia un tumore, lo vorrei sapere al più presto se questo tumore ce l’ho o no e come devo fare ad aggredirlo», dice Brucale. «Invece nelle carceri spesso succede questo, che fissano una visita che slitta regolarmente, a volte per anni perché mancano le scorte, che non hanno nessuna colpa perché c’è un problema di ordine amministrativo, di correlazione tra l’istituto di pena e l’organizzazione sanitaria che non è più in capo al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Dap». Quindi c’è un triplo passaggio: c’è il detenuto malato che si rivolge al carcere, che si rivolge all’area sanitaria. In tutto questo, ci si muove tra carenza di personale e sovraffollamento.
«Condizione del vivere completamente brutale»
«Noi facciamo le visite in carcere, vediamo anche degli ambienti piccolissimi che erano prima utilizzati per attività trattamentali, come le salette per gli incontri o quelle per lo studio, che sono adibiti a celle, con le brande buttate a terra perché non sanno più dove mettere le persone». Ma queste salette che utilizzano come luoghi abitativi non sono avvezze ad essere utilizzate come tali, «non hanno i servizi igienici essenziali, non hanno la doccia, un cucinino. È una condizione del vivere completamente brutale. I detenuti, per andare in bagno o fare una doccia, devono recarsi nei locali comuni».
L’affettività dimenticata
Una sentenza della Corte costituzionale, la n. 10 del 2024, ha stabilito che le persone detenute hanno diritto all’affettività, ma finora si è fatto poco o nulla per metterla in pratica. «A questa sentenza tengo moltissimo, ormai sono passati quasi due anni da quella sentenza della Corte Costituzionale che obbligava a istituire i luoghi dell’affettività, ma invece mettono scatole nuove per stiparci gente dentro. Per mettere i container nelle carceri si sottrae anche spazio alle attività trattamentali, allo sport, ai campetti, ai passeggi. Dell’affettività non se ne parla proprio più». L’avvocato precisa che «le uniche volte in cui il diritto all’affettività è stato concesso a qualcuno, dietro c’era una ordinanza impositiva di un magistrato di sorveglianza. Non c’è un progetto di modifica strutturale dei luoghi per consentire a tutti il diritto all’affettività».
Peraltro, quando la precedente direttrice del Dipartimento Lina Di Domenico, con una Commissione, stilò le linee guida per i luoghi in cui poter garantire i colloqui in intimità per i detenuti, ragionò su un numero di aventi diritto intorno alle 16mila persone a fronte delle 62mila presenze negli istituti penitenziari (che adesso sono più di 63mila). «Affermò che qualunque addebito disciplinare determinasse l’esclusione dall’accesso al diritto. Lo trovo assurdo», conclude Brucale, «il fatto di avere un comportamento disciplinare poco corretto non pregiudica in sé l’accesso alla sessualità o comunque all’affettività riservata quando non si traduce in un rischio concreto correlato alla fruizione del diritto».
Foto di apertura di Larry Farr su Unsplash e, nell’articolo, dell’intervistata
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.
