Libri
Fondazione Foqus: l’impresa sociale come strumento di analisi della realtà
Recensione de “Il laboratorio della città nuova” di Renato Quaglia: un’opera ricca di riferimenti teorici e approcci disciplinari che consentono di significare Foqus e altre iniziative simili, mettendo in luce il valore dell'intrapresa sociale anche in termini riflessivi e analitici e non solo strettamente gestionali e societari

Renato Quaglia è un importante manager culturale e imprenditore sociale, in particolare da quando ha costituito e gestisce insieme a Rachele Furfaro e altri la fondazione Foqus, un’infrastruttura sociale a trazione educativa che sta contribuendo a rigenerare i Quartieri Spagnoli di Napoli e che rappresenta un punto di riferimento a livello nazionale per chi vuole fare innovazione. A questa iniziativa, ma non solo, è dedicato il suo libro “Il laboratorio della città nuova” da poco pubblicato per le edizioni Rubbettino. Si tratta di un’opera ricca di riferimenti teorici e approcci disciplinari che consentono di significare Foqus e potenzialmente altre iniziative simili, mettendo così in luce il valore dell’intrapresa sociale anche in termini riflessivi e analitici e non solo strettamente gestionali e societari. Ma è anche un libro esplicito nelle prese di posizione che riguardano in particolare i rapporti tra i diversi attori che compongono l’ecosistema dell’innovazione sociale e del Terzo settore. Due ambiti che di solito vengono rappresentati come quasi coincidenti ma che in realtà presentano intersezioni limitate anche se promettenti come dimostrano i recenti dati Istat sulle istituzioni non profit socialmente innovative. Si tratta infatti di un sottoinsieme ridotto (8% del totale) ma solido da un punto di vista strategico, operativo e organizzativo oltre che in crescita se si considerano alcune specifiche forme giuridiche come fondazioni (che arrivano al 13%) e cooperative sociali (15%).
Forse è proprio a questi soggetti che ci si potrebbe rivolgere per risolvere le asimmetrie di potere che secondo Quaglia rendono ristretto e poco armonico questo ecosistema limitandone così il contributo trasformativo. Potrebbero essere loro, citando ancora l’autore, i “terzisti” che ce l’hanno fatta, cioè che hanno saputo sottrarsi al ciclo della fame (starvation cycle) innescato da bandi pubblici e filantropici che riducono all’osso i sostegni per i costi di gestione e coordinamento. Nel libro, a tal proposito, non mancano le accuse agli enti filantropici, fondazioni bancarie soprattutto, per aver scalato attraverso una specie di “opa” il settore sociale investendo una quota di risorse tutto sommato limitata dei loro ingenti patrimoni e per di più mal distribuita sui territori (in particolare lungo l’asse nord sud del Paese).
A ciò si aggiunge il fatto di aver contrattualizzato sistemi esperti (centri di ricerca, think tank, enti di valutazione, società di consulenza) che hanno contribuito a costruire un sistema gestionale e una narrativa rispetto all’assegnazione delle risorse che guarda sempre meno a chi ci sta davvero provando ad affrontare le sfide socio ambienti di quest’epoca e sempre più a chi confeziona risposte che sono “compliant” rispetto all’artificiosità delle call. È importante quindi chiedersi come questi terzisti siano riusciti a non farsi fagocitare da quello che, sempre lo stesso Quaglia, definisce un “metaverso” di bandi, policy tecnocratiche, modelli di valutazione e azioni di supporto. Tutto ciò al fine di arricchire di realismo le soluzioni proposte nel libro che puntano su un rilancio di alleanze e partnership non solo con la filantropia ma anche con il settore pubblico nonostante siano evidenti i limiti di quest’ultimo pure quando si rapporta in chiave collaborativa alla società civile.
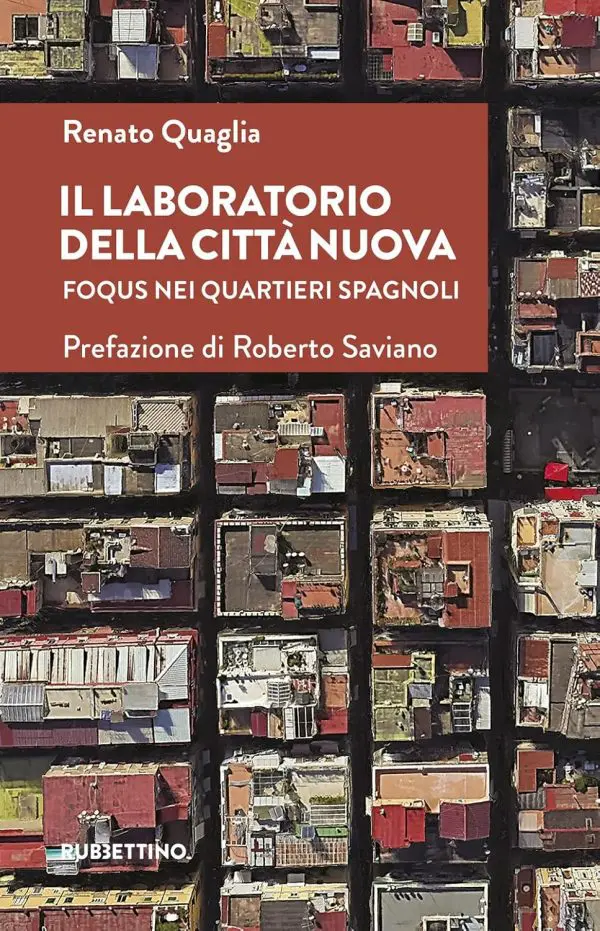
Un primo elemento di realismo riguarda quella capacità rendicontativa che spesso viene additata come “via della perdizione” rispetto alle finalità di interesse generale e alla propensione all’innovazione dei soggetti non profit. In realtà può diventare una funzione organizzativa cruciale per dare vita a sistemi informativi, anche tech e data driven, che incrementano la capacità di apprendimento consentendo così di alimentare nuovi percorsi di sviluppo. Inoltre una rendicontazione strategicamente efficiente può consentire di gestire meglio l’interlocuzione con apportatori di risorse (fondazioni ma anche istituti di credito e fondi d’investimento) che nei sistemi di accounting individuano la chiave di volta per rendere più precisi gli effetti dei loro interventi.
Un secondo elemento riguarda il pluralismo non solo delle attività e dei progetti ma anche dei business model portati avanti da soggetti di Terzo settore e impresa sociale e che li fanno assomigliare sempre più a conglomerati territoriali di economie sociali e di prossimità piuttosto che a startup specialistiche. Se queste ultime sono più facilmente investibili (e controllabili) attraverso strumenti e logiche trasferite dall’innovazione tech a quella sociale, nel secondo caso si tratterà, come si sostiene nel libro, di dar vita a joint ventures pazienti caratterizzate da principi di intersezionalità delle sfide e integralità degli impatti. Ma affinché questo possa avverarsi è necessario che tutti, investitori compresi, facciano un passo indietro rispetto alle loro velleità egemoniche sui processi sociali dando così spazio al protagonismo generativo delle comunità.
Foto dalla pagina Facebook di Foqus
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it
