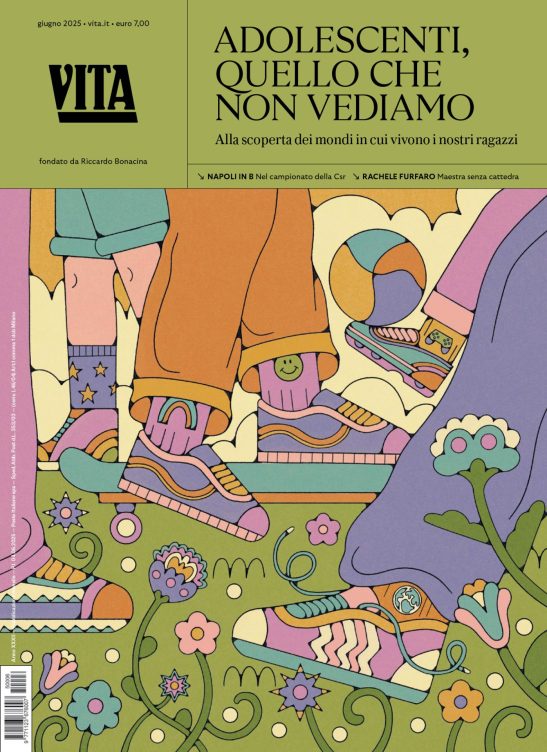È necessario domandarsi se l’attuale assetto distributivo può supportare
e sopportare l’onere di una funzione sociale di fondamentale importanza.
A partire dal recupero di aree teoricamente marginali La prima considerazione da fare in termini di consumi riguarda la scarsa dinamica dei consumi effettivamente oggetto di scelta da parte dei cittadini, i cosiddetti consumi commercializzabili, e il peso delle mancate liberalizzazioni nello sviluppo economico del Paese.
Contrariamente a quanto sembra sostenere la tesi della saturazione dei consumi di base – dall’alimentazione all’abbigliamento – il problema della spesa che passa per i negozi è la compressione pluridecennale che deve subire a causa del peso crescente delle spese obbligate, soprattutto legate all’ambiente domestico (affitti, luce, acqua, gas e altro). Questi servizi sono offerti prevalentemente da imprese in situazione di oligopolio oppure nell’ambito di mercati troppo o troppo poco regolati. Di conseguenza la dinamica dei prezzi di questi beni e servizi è significativamente superiore a quella riscontrata per i beni commercializzabili.
I dati strutturali sono negativamente declinati durante le fasi di bassa congiuntura. L’ICC (Indicatore dei Consumi Confcommercio) presenta una variazione dei consumi pari a -0,7% in termini reali per il 2008, nella metrica dei consumi sul territorio economico, cioè al netto dei consumi degli italiani fuori dall’Italia e includendovi le spese degli stranieri in Italia. Anche per tutto questo 2009, quindi, le prospettive della spesa reale delle famiglie appaiono negativamente orientate.
La perdurante crisi di produttività, redditi e consumi, facilita la saldatura tra la vasta e crescente area dei cittadini-consumatori in difficoltà e gli organismi che dovrebbero prendere decisioni di politica economica: un asse bipartisan che porta, attraverso l’operare acritico dei mezzi di comunicazione, a fare dire ai decisori non ciò che è opportuno ma ciò che le persone vogliono sentirsi dire. E queste, ancora attraverso i media e i sondaggi, a suggerire ai decisori cosa dire. La teoria della demagogia si invera perfettamente, lasciando scoperti i bisogni di riequilibrio strutturale nelle dotazioni di capitale tanto necessarie al Paese.
L’efficienza di costo va affiancata dall’innovazione nel formato. Tutte le ricerche, oggi, stabiliscono che il punto vendita è il luogo, nell’accezione estesa di spazio e tempo, in cui si decidono gli acquisti. Non solo e non tanto in termini di marche ma anche del cosa e del come consumare, dove per consumare si intende, in modo finalmente chiaro e radicale, non distruggere, diminuire, ma sviluppare gradevolezza per la propria vita. Anche nei termini di relazione e socialità. Il punto di vendita vende se stesso assieme ai servizi e ai prodotti ed è il principale veicolo pubblicitario o di comunicazione. Parla di valori oltre che di consumi e consumo.
Se queste idee sono verosimili e condivisibili allora è necessario domandarsi se l’attuale assetto distributivo può supportare e sopportare tutti questi oneri, connessi agli onori di svolgere una funzione sociale di fondamentale importanza (e non solo nei centri storici ma anche come veicolo di recupero di aree teoricamente marginali).
L’innovazione del prodotto negozio è rilevante proprio perchè il settore della delivery deve contribuire a ottimizzare le risorse disponibili dei consumatori per migliorare il benessere fruito attraverso i consumi.
Se esiste, e deve esistere, una responsabilità individuale e collettiva per migliorare il benessere del Paese, anche in termini di benessere medio fruito, allora possiamo dichiarare che anche il commercio, può, deve e vuole fare la sua parte.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.