Idee Modelli di sviluppo
Siamo proprio sicuri che Milano sia una città di successo?
Tutti gli indici di misurazione del successo urbano si basano su un implicito assunto di base: le città competono su scala globale per attrarre risorse finanziarie, sedi di aziende, turisti e abitanti benestanti. Gli abitanti espulsi perché non possono permettersi il costo della vita, l'inquinamento portato da un eccesso di mobilità e di produzione, l'aumento del divario tra i poveri e i ricchi? Effetti collaterali della città vincente. Ma siamo siamo sicuri che sia questo il modo corretto di misurare il successo?

Molte persone – spesso intelligenti e preparate – quando parlano di Milano a vario titolo argomentano che «sì, è vero, a Milano ci sono alcune cose che non vanno, ma è comunque una città di successo»; «Se Milano non è un modello di successo, allora quale altra città lo è?»; «Milano è vittima del suo successo».
Ma che cosa vuol dire “successo di una città?”. Tra i significati della voce “successo”, sulla Treccani troviamo:
- Un risultato favorevole, buona riuscita in qualcosa
- Il riconoscimento da parte degli altri dei propri meriti o l’approvazione del proprio operato da parte di un vasto pubblico.
Il senso comune considera “di successo” quelle città che hanno una buona performance in termini economici – Pil e Pil pro capite, investimenti esteri, tassi di occupazione e disoccupazione, etc – e di qualità della vita – termine fumosissimo, come testimoniano le decine di graduatorie che ogni anno puntualmente si contraddicono. Gli addetti ai lavori guardano spesso indici aggregati composti da numerosi parametri legati a produttività, innovazione tecnologica, servizi, connessione globale e impatto ecologico, come il Global Power City Index, lo Schroders Global Cities Index, il Globalization and World Cities Research Network (GaWC).
Nella loro grande differenza, tutti questi indici di misurazione del successo urbano si basano su un implicito assunto di base: le città competono su scala globale per attrarre risorse finanziarie, sedi di aziende, turisti e abitanti benestanti (una dinamica fotografata già alla fine degli anni ’80 da David Harvey in “From Managerialism to Entrepreneurialism“). Le risorse sono limitate, il gioco è a somma zero, le città che hanno successo si producono in buone performance agonistiche e riescono ad ottenere un buon posizionamento negli indici globali.
L’idea di fondo è che ci sia una grande gara planetaria, con vincitori e vinti. Quello che importa è piazzarsi tra i primi. Ottenere un “risultato favorevole” e “il riconoscimento dei propri meriti” sui mercati. Gli abitanti espulsi perché non possono permettersi il costo della vita, l’inquinamento portato da un eccesso di mobilità e di produzione, l’aumento del divario tra i poveri e i ricchi sono “effetti del troppo successo”. Esternalità negative, incidenti di percorso, danni collaterali. E se provassimo a considerare le cose da una prospettiva completamente diversa?
Proviamo a guardare all’attuale situazione di Milano. È uno dei luoghi in cui si sono manifestate in modo particolarmente veloce e drammatico alcune trasformazioni che hanno già interessato molte altre città: finanziarizzazione immobiliare, turistificazione, gentrificazione, crisi abitativa, cambiamenti climatici, crisi dei modelli di welfare, logiche attrattive dei city user a sfavore degli abitanti, nuove polarizzazioni. Sono dinamiche che si sono già viste e studiate a Londra, Amsterdam, Barcellona, New York, Berlino. La peculiarità di Milano è quella di aver vissuto questi cambiamento in un lasso ristretto di tempo – convenzionalmente se ne fa risalire l’inizio all’Expo del 2015 – e su una scala geografica molto ridotta – 181,8 km² contro, ad esempio, i 891,8 km² di Berlino o i 1.572 km² di Londra.
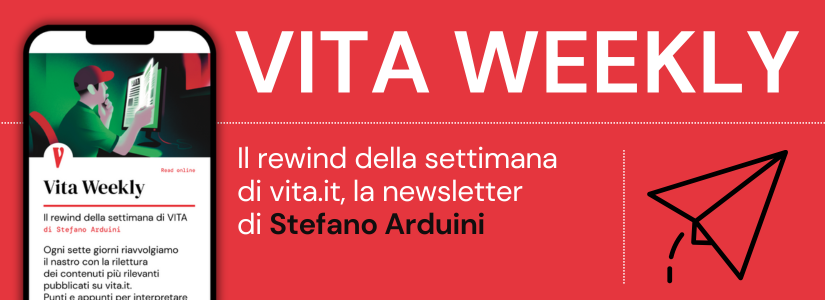
Le tensioni e le fratture che stanno emergendo a Milano in questi anni – e che prendono anche la forma della crisi del Salva Milano e delle inchieste sulla Commissione Paesaggio – sono in ultima istanza riconducibili ad una grande, diffusa crisi della dimensione urbana nel XXI° secolo: la produzione e l’estrazione di valore – economico, sociale, culturale, politico – si addensano nelle metropoli, producendo disuguaglianze crescenti a fronte di una generale contrazione dei sistemi di rappresentanza e di governo.
Se guardiamo le difficoltà particolari nell’ambito di un quadro di globale, allora il significato di “successo” cambia. Nessuna metropoli o grande città è riuscita a trovare una vera formula di sostenibilità, come non si stancano di ricordarci costantemente. Barcellona ha fatto molto contro Airbnb, ma soffre ancora enormemente per il turismo. Amsterdam ha introdotto misure importanti contro la speculazione immobiliare, ma è ancora al centro di brutali processi di finanziarizzazione della città. Abitare a Vienna è incredibilmente economico, ma i costi aumentano continuamente assieme ai rischi finanziari.
Nella loro grandissima differenza, nei tempi lunghissimi delle trasformazioni urbane, in anni difficilissimi di continua instabilità globale, sono città che ci stanno provando. Sono città che non si limitano a correre, e a dire a chi non riesce a stare al passo di andare a vivere nell’hinterland prendendo mezzi pubblici in costante malfunzionamento. Sono città che – in modo imperfetto, attraverso prove ed errori – stanno cercando di trovare soluzioni locali a una crisi globale. In nessuno di questi casi, molto probabilmente, si può parlare di “successo”. Ma si tratta comunque di città che stanno provando ad offrire risposte – economiche, sociali, culturali, politiche – a tutti gli abitanti. Il che è probabilmente la cosa migliore che si può fare.
Foto di Jonas Allert su Unsplash
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.


