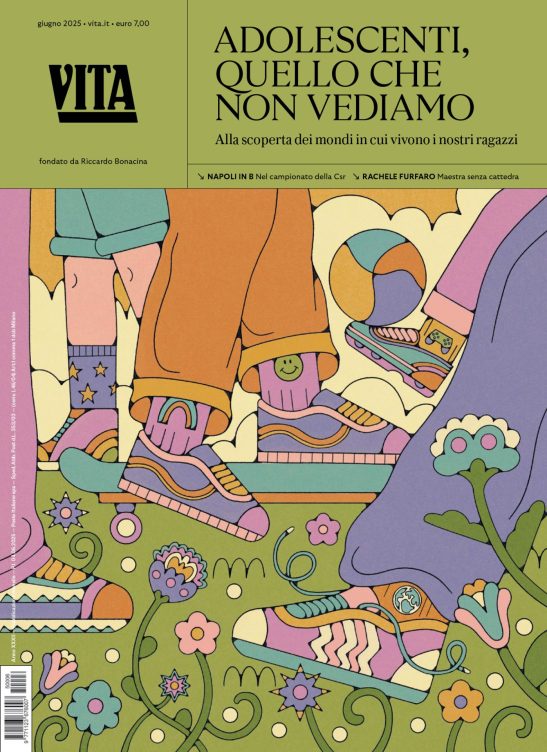Non profit
Il mal d’Africabvisto da Harvard
Crollo delle classi dirigenti. Che dopo il grandebsogno degli anni 60 si sono chiuse su se stesse. CosìbRobert Bates spiega il black out di oggi
di Redazione
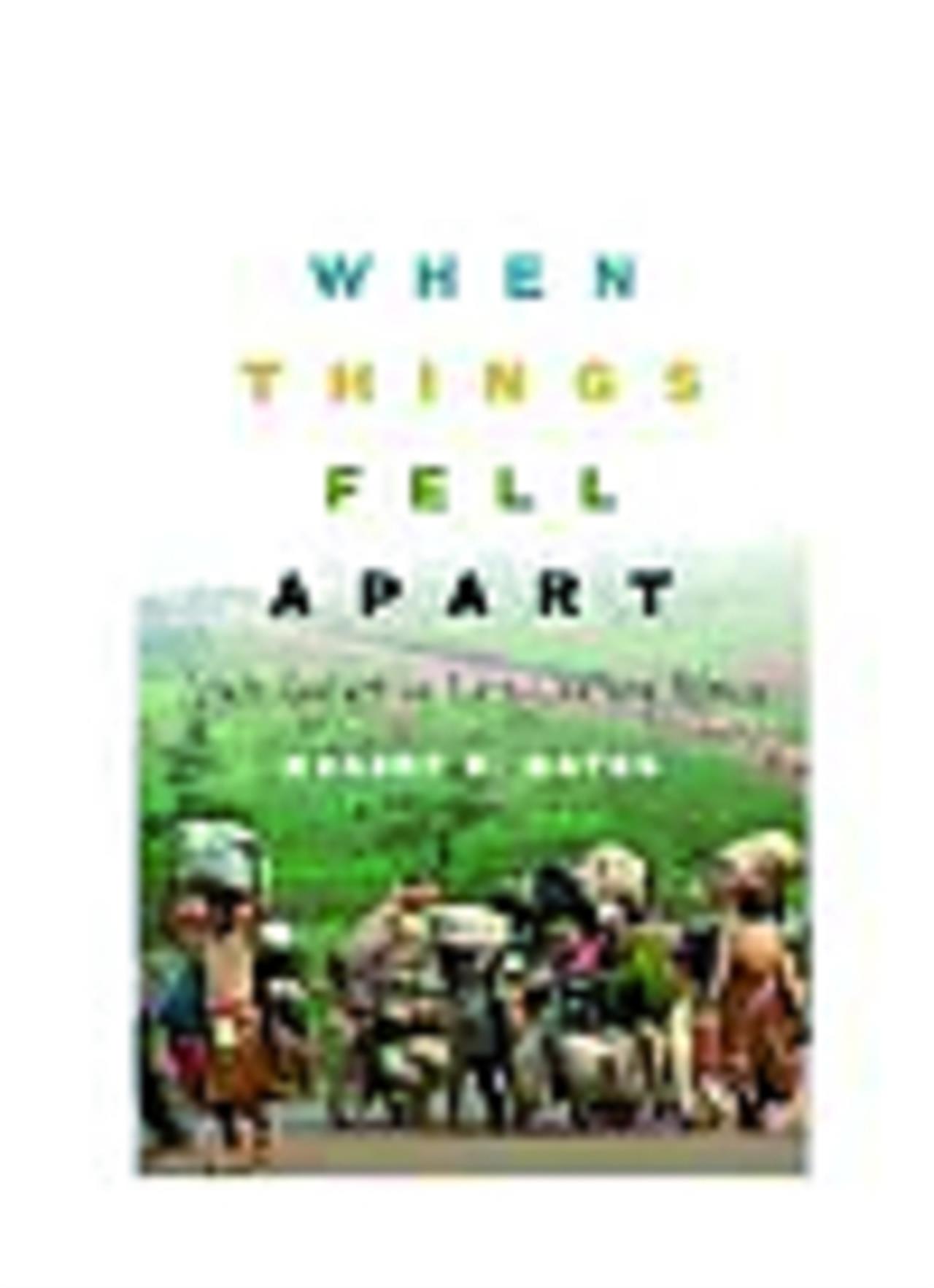
C he cosa esattamente è andato storto? Da dove è nata quella situazione di disordine e “crollo dello Stato” che ha travolto l’Africa in maniera pressoché generalizzata a partire dagli anni 80? Questo è l’interrogativo che si è posto un politologo di Harvard in un piccolo libro il cui titolo evoca esplicitamente un romanzo del celebre scrittore nigeriano Chinua Achebe ( Things fall apart , nell’edizione italiana diventata Il crollo ). Il quadro che ne esce è la brillante sintesi di un percorso che, attraverso oltre quarant’anni di studio, ha fatto di Robert Bates uno dei maggiori esperti di politica ed economia dei Paesi africani.
Subito dopo l’indipendenza dei primi anni 60, ci ricorda Bates, le cose non erano in realtà sembrate andare male per i nuovi Stati africani. Leader visionari e strategie di sviluppo ambiziose davano corpo alle grandi aspettative del continente.
La svolta, però, arrivò prestissimo, già nella prima metà degli anni 70. Le crisi petrolifere e il peggioramento dei prezzi internazionali delle produzioni africane misero a nudo la debolezza delle economie subsahariane, e molti, troppi Paesi del continente si persero rapidamente nella spirale dell’indebitamento e della crisi fiscale. Quanto più la crisi si aggravava e le entrate pubbliche si contraevano – questo è il perno della ricostruzione di Bates – tanto più i governanti africani cominciarono a cercare risorse alternative.
Da qui l’avvio di alcuni dei peggiori vizi delle classi politiche continentali, tra cui l’appropriazione indebita delle abbondantissime ricchezze del sottosuolo e quella del poco che gli africani ancora avevano in tasca. In questa lunga fase di “malamministrazione”, gran parte dell’Africa sperimentò regimi economici sostanzialmente anti liberali. Uno dei principali obiettivi fu quello di proteggere e favorire i ceti urbani e “industriali”, a danno delle popolazioni rurali e agricole, attraverso politiche che trasferivano sistematicamente risorse dagli uni agli altri. Gli apparati pubblici, nel frattempo, venivano progressivamente imbottiti di personale fedele al governo, convertendoli di fatto in organizzazioni politiche volte a preservare i gruppi al potere.
Anziché perseguire il benessere della collettività, la prima preoccupazione degli Stati africani era diventata la difesa dei benefici di pochi. E mentre l’endemica crisi economica favoriva la corruzione e deteriorava i servizi pubblici, questi apparati statali si trasformarono sempre più in una minaccia, anziché una garanzia, per la sicurezza e il benessere dei loro stessi cittadini. D’altra parte, sostiene Bates, per governanti timorosi di perdere il potere, soprattutto quando alcune aperture al pluralismo diedero voce ai loro oppositori, e con esso il controllo sulle ricchezze naturali, la promozione del disordine e della violenza ha talvolta rappresentato un’opzione perseguita in modo deliberato.
A fronte di autorità che privilegiavano la predazione e la repressione, la reazione dei cittadini africani fu spesso quella di affidarsi a protettori locali capaci, con appelli all’identità etnica, di mobilitare e organizzare milizie armate. Questa contrapposizione tra autorità centrali e milizie locali a dimensione etnica è stata una causa decisiva dell’erosione dei sistemi politici ed economici africani, fino al “crollo” – una nozione forse utilizzata e generalizzata con troppa disinvoltura da Bates – degli Stati del continente. Qui si ferma la bella e sintetica analisi di Bates. Quello che il libro lascia aperto è ciò che è accaduto, in alcune parti del continente, negli anni più recenti.
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.