Volontariato
Vivere è aprire ogni giorno porte sul futuro
«La vita più che un progetto è una vocazione a cui rispondere ogni giorno. Devi essere sempre pronto ad alzarti e partire». Ne è convinto padre Giuseppe Bettoni, presidente e fondatore di Arché, che in un libro racconta il suo costante tentativo di conciliare spiritualità e fragilità del vivere. Dalla Milano da bere all'Aids, dalle donne vittime di violenza ai bimbi bisognosi di amore, 30 anni di Arché hanno mostrato che «ciascuna persona, quale sia la sua ferita o la sua colpa, ha un dono da condividere».

Se vogliamo parlare di futuro, se vogliamo guardare oltre l’immediato, dobbiamo imparare a usare bene il nostro tempo perché, come diceva Rainer Maria Rilke: «Il futuro entra in noi molto prima che accada!». Questa citazione, che è contenuta nel libro “Quanto pesa la luna?”, riassume perfettamente il senso della vita di padre Giuseppe Bettoni, presidente e fondatore di Arché.
Abbiamo dialogato con lui per ripercorrere insieme le tappe della sua formazione, il suo scendere e sostare nelle profondità di ciò che caratterizza la condizione umana nei suoi aspetti più fragili: ospedali, carceri, ricoveri, comunità di recupero.
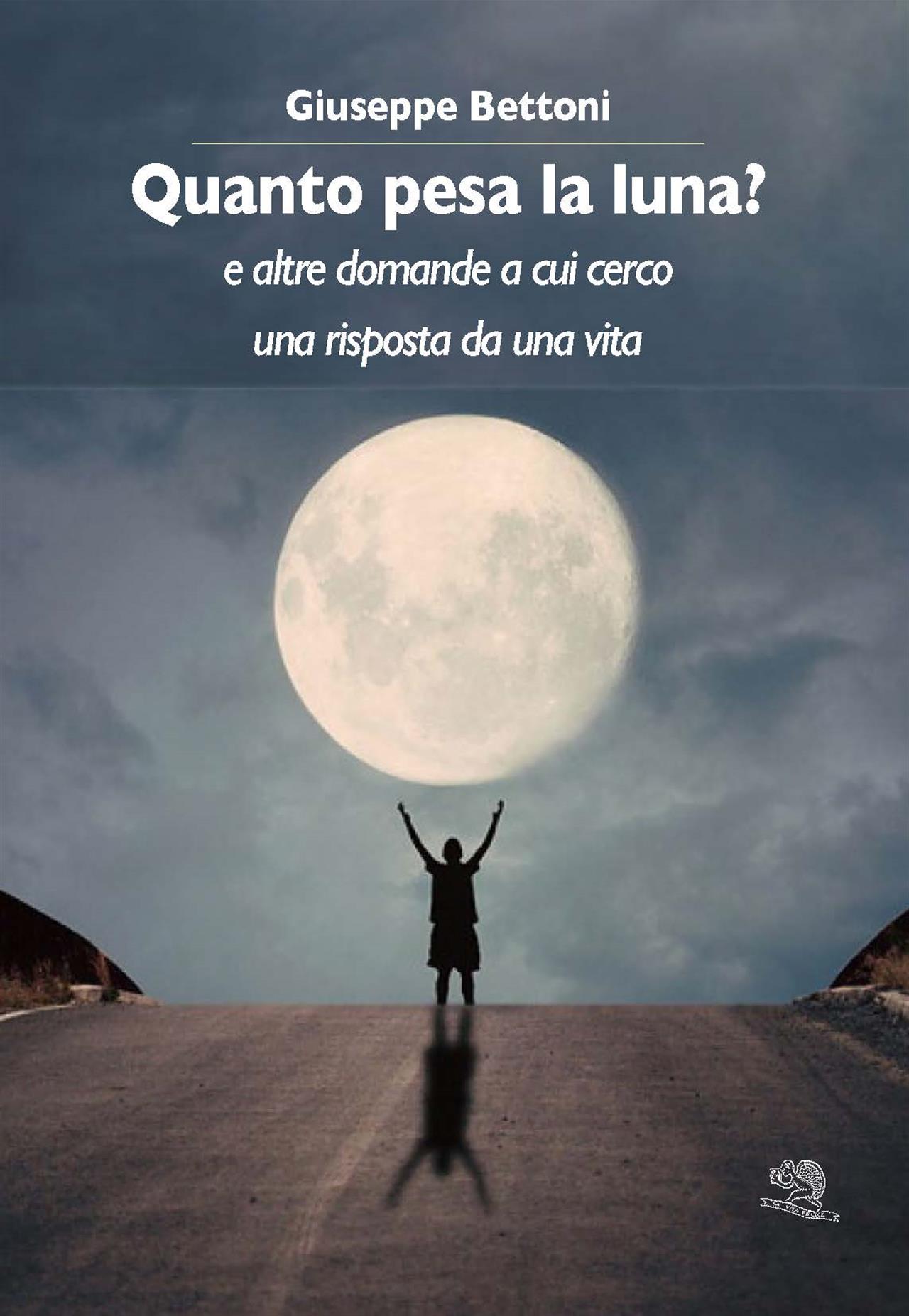
Il libro, che mette insieme il racconto di episodi e di incontri significativi della biografia personale dell’autore con alcune tappe importanti dell’organizzazione, inizia con una consapevolezza: «la vita, più che un progetto, è una vocazione a cui devi rispondere ogni giorno, ogni ora, e devi essere sempre pronto ad alzarti e partire. A questa considerazione ci si arriva da adulti. Da bambini è solo un’intuizione, figlia dello stupore con cui si osserva e si sperimenta il mondo, un minuscolo seme interiore che nasce e germoglia nutrito dall’ambiente che ti circonda e, soprattutto, dall’esempio famigliare».
Quella di padre Bettoni è una stata una vocazione nata da bambino, osservando il prete dell’oratorio, che giocava con i ragazzi a pallone, che li portava a fare le gite. «Nella mia ingenuità mi dicevo che da grande avrei voluto essere come lui». Lo scrisse anche in un tema, a scuola, in quinta elementare: «vorrei essere come don Guglielmo». A undici anni, l’ingresso in seminario. Ripensando a quei momenti, racconta nel libro, quel luogo restava comunque un mondo chiuso, che non insegnava la relazione con l’altro. Giuseppe provava un po’ di fastidio. Cercava "la vita vera". All’Università Teologica di Fermo il professore di diritto canonico era don Vinicio Albanesi, presidente della comunità di Capodarco, che gli aprì gli occhi su un mondo di disabilità, marginalità, carcere e devianze.
Ma è stato soprattutto suo padre, operaio in un cementificio, ad insegnargli l’umiltà e la fatica del vivere. Per questo padre Giuseppe Bettoni ha sempre cercato di avere «una fede scevra da tanti orpelli. Una fede concreta. Solida. Essenziale ma vera», opposta – dice, «a quella mentalità che ti viene trasmessa in seminario, secondo la quale tu saresti più in alto».
Ho sempre cercato di avere una fede scevra da tanti orpelli. Una fede concreta. Solida. Essenziale ma vera. Opposta a quella mentalità che ti viene trasmessa in seminario, secondo la quale tu saresti più in alto
padre Giuseppe Bettoni
Gli insegnamenti di questi due uomini sono stati per lui un nutrimento dell’anima, del cuore e della mente, e hanno segnato profondamente la sua vita, il suo «costante cercare di mettere insieme e conciliare queste due dimensioni: la spiritualità e la fatica del vivere; la marginalità e le fragilità mie e quelle che incontravo negli altri».
E questo “altro” gli è venuto incontro a Milano, dove arrivò a venticinque anni, a Sant’Angela Merici, nel quartiere della Maggiolina. Qui padre Bettoni trovò una città con le ferite ancora aperte del terrorismo, delle sparatorie e degli attentati, eppure infiocchettata dietro lo slogan “Milano da bere”, polo attrattivo per chiunque volesse affacciarsi al mondo dell’arte, del cinema, della musica, dello spettacolo. Qui incontrò ragazzi e famiglie smarrite nei fumi dell’alcol e della droga. «Devo riconoscere che l’incontro con la devianza, la marginalità e le dipendenze è stato per me un vero e proprio corso di teologia, nel senso che ho dovuto ripensare tutte quelle categorie e quegli schemi appresi sui manuali che volevano spiegarmi Dio e mi inducevano ad assumere l’atteggiamento di chi deve sempre insegnare agli altri».
Sono stati anni di esperienze e di incontri importanti, momenti di confronto e di condivisione. Non sono mancate le incertezze, le tensioni, i dubbi. Sulle panchine dei giardinetti si vedevano adolescenti devastati dall’eroina, con lo sguardo spento, le braccia piene di ecchimosi e i denti cariati. Un’unica certezza: il valore di ogni essere umano. «Sono convinto che ciascuna persona, quale che sia la sua ferita o la sua colpa, abbia un dono da condividere. Sotto questo aspetto ho sempre trovato più capacità di confronto con i laici che con il mondo clericale, eccetto alcune figure libere come il cardinale Martini e altri, che mi hanno sostenuto e aiutato e con i quali c’è stato un confronto molto schietto, vero, non di maniera».
Tornando indietro con la memoria, ripensando a quegli anni, dice: «Nel nostro piccolo la risposta che siamo riusciti a dare è stata quella della relazione, dell’incontro, della capacità di ascoltare e di aiutare a scoprire percorsi capaci di rispondere in maniera diversa alla fuga dalla responsabilità».
Giuseppe Bettoni è fatto così: un uomo che non si accontenta del “si è sempre fatto così”, ma osa aprire strade nuove, esplorare terreni. «Certamente posso dirlo oggi, voltandomi indietro, in alcuni momenti posso affermare tranquillamente di essere stato un ribelle. Se per “ribelle” si intende il fatto di non essere conformisti, di non adottare un atteggiamento rinunciatario, codardo, tipico di chi fatica ad assumersi la responsabilità dei propri pensieri e delle proprie azioni, temendo il giudizio degli altri e di non essere accettati».
Certamente posso dirlo oggi, voltandomi indietro, in alcuni momenti posso affermare tranquillamente di essere stato un ribelle.
Eppure, nella sua moderata ribellione, non è stato un uomo solo, uno di quei navigatori solitari che pensano di salvare il mondo senza l’aiuto di nessuno. È stato il suo amore e la sua esperienza in montagna a insegnargli l’importanza della corresponsabilità, del lavoro svolto insieme. Lo ha sperimentato sulle montagne bergamasche, dove è nato (e dove torna appena può) e anche nel 2019, quando ha fatto un trekking al campo base dell’Everest. «Quando sei in cordata devi stare al passo con il più debole. Mentre si sale il capofila sta davanti e in discesa è l’ultimo, pronto a puntare la piccozza in caso di bisogno».
Nel 1991, i bambini e l’Aids
E poi un giorno arriva una telefonata da parte di un’assistente sociale della clinica pediatrica De Marchi: «So che voi fate questo lavoro con i tossicodipendenti e le famiglie. Noi, qui, abbiamo un bambino di quattro anni in Aids conclamato. I genitori non se ne possono occupare e andrebbe assistito per circa otto ore durante la giornata». Per entrare in ospedale ed essere operativi, avevano bisogno di far parte di un ente riconosciuto: «Così, il 10 maggio, ufficializzammo la nostra avventura di solidarietà e nacque Arché». Era il 1991. Trent'anni fa. «Se fosse stato un progetto solo mio, si sarebbe arenato subito; ora, invece, mi rendo conto che la mia è stata la risposta a un appello irresistibile, prorompente, che mi ha dato la forza e il coraggio di andare avanti».
Se fosse stato un progetto solo mio, si sarebbe arenato subito; ora, invece, mi rendo conto che la mia è stata la risposta a un appello irresistibile, prorompente, che mi ha dato la forza e il coraggio di andare avanti
Il 1991 fu anche un anno significativo nella storia italiana per la promulgazione di due leggi: una sulla cooperazione sociale e una sul volontariato, che cercarono di sostenere e strutturare un grande fermento d’impegno civico. «Associazioni e organizzazioni nascevano ovunque, sia per farsi carico delle situazioni più fragili, sia per la tutela dei diritti delle fasce di popolazione altrimenti tenute ai margini». Ma l’Hiv faceva molta paura: «Lo stigma in quegli anni era molto forte, divideva la società in buoni e cattivi. Alcuni erano giunti ad affermare che fosse il castigo di Dio», ricorda padre Bettoni. I volontari di Arché iniziarono ad occuparsi dei bambini e delle bambine malate, figli di coppie sieropositive, dando non solo una mano concreta ai genitori e ai famigliari ma anche promuovendo un nuovo modo di pensare rispetto a una malattia dilagante. Vicino ai sieropositivi ci sono anche alcuni medici e professori, come Gian Vincenzo Zuccotti e Alessandro Albizzati (alcuni di questi momenti sono raccolti nel docufilm “Cuori pensanti”).
I progetti durano una decina di anni. Fino all’inizio del Duemila, quando l’Aids diventò una patologia cronica tenuta sotto controllo con gli antiretrovirali e non nascevano più bambini sieropositivi grazie all’Azt somministrato alle donne in gravidanza.
E poi Casa Carla, Casa Adriana, Casa Marzia…
«In quel momento ci interrogammo se non fosse il caso di considerare esaurita la nostra funzione. Ma presto venimmo coinvolti in un fenomeno che andava emergendo e al quale non potevamo rimanere sordi: la violenza di genere». P. Bettoni e Arché accolgono la nuova sfida: «si trattava ancora una volta di entrare in punta di piedi in situazioni delicatissime». Ma questa volta non erano inesperti: sapevano già che era fondamentale tenere insieme il nucleo madre-figlio. «La nostra esperienza con mamme e bambini sieropositivi ci aveva fatto capire che l’affido famigliare dei bambini sieropositivi, quando i genitori non erano più in grado di occuparsene, non era sufficiente. Fin da subito avvertimmo la necessità di garantire la continuità del rapporto mamma-bambino. Fu immediato estendere questo modello anche alle donne vittime di violenza di genere e ai loro figli». E’ così che si arriva alla costruzione di Casa Carla, Casa Adriana, Casa Marzia, (l’ultima struttura inaugurata pochi mesi fa, a Roma).
Le prossime sfide: futuro e formazione
Il percorso non è ancora finito. Le prossime sfide per il futuro? «Generare opportunità di lavoro per le donne. «Per questo daremo vita all’Impresa sociale Porta Futura, un luogo che ospiterà una trattoria sociale, un asilo nido per l’infanzia e una comunità di accoglienza per mamme e bambini fragili», conclude p. Bettoni. «E infine aggiornare il sistema attuale delle comunità di accoglienza, immaginando altri possibili percorsi innovativi nella cura dei nuclei mamma-bambino».
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.
