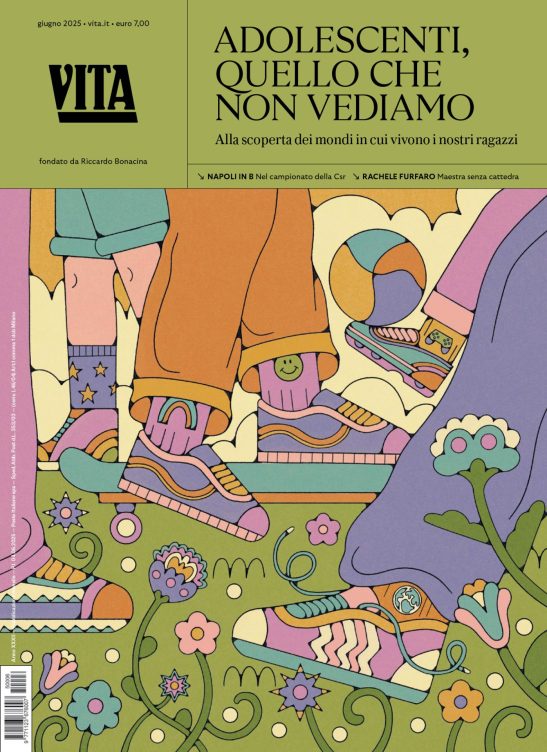Mondo
L’Italia a Sarajevo esporta la normalit
La città sta vivendo una delle fasi più importanti della sua storia. Una difficile ricostruzione in cui gli italiani giocano il ruolo di costruttori della nuova economia di pace
Come si vive oggi in quello che è stato uno dei luoghi più pericolosi del mondo? Che cosa è diventata Sarajevo? Dopo un assedio costato più di 10mila vittime (di cui oltre 1.600 bambini) la capitale della Bosnia-Erzegovina sta rielaborando il lutto collettivo della guerra con un contrasto agrodolce tra antico e moderno, in cui si incontrano periferie che si svuotano e città in via di ricostruzione, dove le nuove generazioni che non hanno conosciuto la guerra vivono accanto agli adulti che cercano di conservarne la memoria.
In questo cocktail culturale postbellico, i cartelloni pubblicitari raccontano di concerti di Pavarotti e creme anticellulite davanti a edifici distrutti, nei parchi ci sono giochi per bimbi appena installati a un passo da vecchi elicotteri militari ormai inservibili e ricoperti di graffiti. Per le strade di Sarajevo i fantasmi della guerra ti sorprendono a ogni angolo, e anche una semplice passeggiata si trasforma in un rito del ricordo, in un pellegrinaggio laico che passa dal tristemente noto ?viale dei cecchini?, davanti alla biblioteca nazionale ?chiusa? con la forza il 25 agosto ?92 dai proiettili al fosforo, o nel mercato dove il 5 febbraio del ?94 un colpo di mortaio ha stroncato la vita di 68 persone.
Il pericolo nazionalismo
Bruno Palestra, un sarajevita di origini italiane, quel 5 febbraio era diretto proprio al mercato, ma lungo il tragitto è stato raggiunto da una richiesta di aiuto che lo ha rallentato quel tanto che basta per far tardi a un appuntamento con la morte. Laico, di padre milanese, madre serbo-ortodossa, sposato con una musulmana e con un montenegrino per genero, Bruno è un simbolo vivente della Sarajevo multietnica, multirazziale e multiculturale dove, prima della guerra, il 90% dei matrimoni che si celebravano erano misti, mentre oggi un decennio di giochi di guerra ha creato una città popolata prevalentemente da musulmani.
«Questa guerra non è stata uguale a nessun?altra», racconta Bruno, che è presidente dell?associazione dei cittadini di origine italiana di Sarajevo. «Non c?erano allarmi, non c?erano aerei, e le granate arrivavano silenziose». La sua storia personale ha portato Bruno ad avere un atteggiamento molto laico rispetto ai sentimenti di appartenenza etnica e religiosa: «sono di origine italiana, come molti altri bosniaci, ma non per questo ci sogniamo di dire che questo è territorio italiano. Al contrario, oggi in Bosnia ci sono serbi e croati che hanno in testa un ?paese di scorta? e si sentono orfani dei loro luoghi di origine. è qui», conclude Bruno, «che si innesta il nazionalismo, una brace che cova sotto la cenere».
Già dall?ottobre 2002, infatti, le elezioni in Bosnia hanno visto una forte riaffermazione dei partiti nazionalisti.
Ma se in queste coalizioni politiche serpeggiano le forze distruttive del nazionalismo, un delicatissimo tiro alla fune bilancia queste forze con i tentativi di ricostruzione sociale e materiale del paese, e la presenza italiana a Sarajevo gioca un ruolo importantissimo in questo ?ritorno alla normalità?.
Le realtà italiane sul posto
Sono circa venti le organizzazioni italiane che operano in Bosnia nel silenzio dei mezzi di informazione, e fra queste c?è Intersos, impegnata nelle operazioni di sminamento del territorio.
«Quest?anno per noi è più difficile», racconta Vito Alfieri Fontana, l?ingegnere italiano di Intersos che sovraintende il programma di sminamento, «stiamo lavorando in una zona vicina al centro di Sarajevo, dove nessuno voleva andare». Le organizzazioni statali sono rallentate dalla pesantissima burocrazia bosniaca e quindi scelgono zone facili da sminare in poco tempo, mentre le ditte private attive in questo settore fanno progetti su vasta scala per zone molto estese, e quindi la patata bollente passa alle ong. «Lo scopo di organizzazioni come la nostra», spiega Fontana, «è proprio quello di andare dove lo Stato e i privati non arrivano, cioè in zone molto piccole e difficili da sminare. Tutti noi potremmo essere sostituiti da robot sminatori, ma sono molto costosi e sarebbero abbordabili solo con un massiccio intervento economico da parte della comunità internazionale. Gli sminatori potrebbero essere tutti sostituiti da macchine, ma non lo si fa per questioni economiche. Entro un paio di anni il problema mine in Bosnia cesserà di esistere», promette Fontana. «Grazie al cielo le mine jugoslave erano fatte male, al contrario di quelle italiane, e quindi molte si stanno disattivando da sole. Abbiamo impiegato una dozzina d?anni per bonificare».
Da quella famosa ?marcia dei 500? su Sarajevo che nel 1992 ha portato un gruppo di pacifisti nel cuore di una città assediata, sotto la guida del vescovo don Tonino Bello, è partito il ?Progetto Sarajevo?, curato dagli scout dell?Agesci, che ha portato in Bosnia migliaia di ragazzi italiani. «A Sarajevo» racconta Anna Scavuzzo, educatrice scout referente del progetto, «ci sforziamo di ascoltare le persone e le loro storie. Ci accorgiamo che la complessità va affrontata informandosi, leggendo, ragionando. Perché è difficile considerare la realtà avendo un unico punto di vista».
L?incontro tra i ragazzi e la popolazione locale ha portato nel corso degli anni un elemento di distensione nella vita della città. «Per molti sarajeviti» prosegue Anna Scavuzzo, «siamo una ?bella abitudine?. Siamo spesso i loro occhi, le loro orecchie, la loro memoria. Sarajevo è soprattutto luogo di incontro, di conoscenza e di condivisione: richiede rispetto, compassione, silenzio. è una città che ci interroga sul nostro presente e ci aiuta a perseguire un obiettivo: aprire gli occhi e imparare l?ascolto».
Questo ?cuore italiano? della Bosnia è una realtà invisibile per chi non la tocca con mano, e la memoria del fortissimo rapporto che durante i giorni dei mortai ha unito due popoli attraverso l?Adriatico inizia impietosamente ad appannarsi. Ma a distanza di così tanti anni, c?è ancora qualcuno che ogni tanto porta rose rosse sul ponte di Vrbanja a Sarajevo, dove il 3 ottobre 1993, i colpi di un cecchino hanno stroncato a 34 anni la vita di Gabriele Moreno Locatelli, un volontario dei Beati i costruttori di pace.
Oggi a Sarajevo gli italiani sono accolti con sorrisi e la freschezza delle nuove generazioni che sfuggono ai vecchi cliché nazionalisti sembra l?unico antidoto al ripetersi della storia.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.