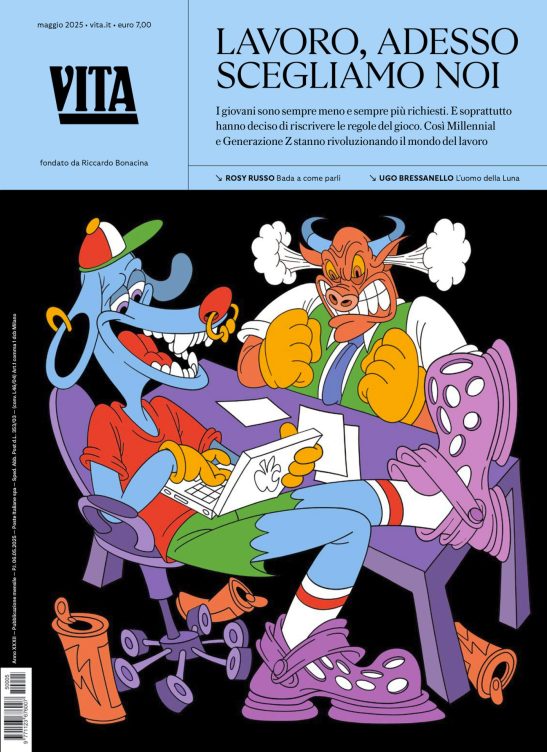Verso il referendum
Fatima, Cavaliere della Repubblica senza cittadinanza
Classe 2000, Zahra El Maliani fa parte del Consiglio generale di Fondazione Compagnia di Sanpaolo ed è la presidente regionale di United World College. Nel 2023 è stata premiata da Mattarella, ma non ha la cittadinanza italiana. «Il referendum dell’8 e 9 giugno», dice, «è un’occasione per la comunità, nel suo intero, di misurarsi»

Il curriculum di Fatima Zahra El Maliani dice più di qualunque racconto. Laurea triennale in Global law and Transnational legal studies, magistrale in International Security Studies, prima in graduatoria per una borsa di studio offerta dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e dall’Università di Trento. Da un anno fa parte del Consiglio generale di Fondazione Compagnia di Sanpaolo ed è la presidente regionale di United World College, il movimento globale che lavora affinché l’istruzione e i giovani in particolare possano unire persone, nazioni e culture per la pace e un futuro sostenibile. Nel 2023 è stata nominata Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana per aver ideato il doposcuola Prime CasArcobaleno nel quartiere multietnico di Porta Palazzo a Torino. È nata in Marocco il 4 luglio 2000, ma è diventata grande tra le vie di Aurora, settima circoscrizione di Torino. Non ha la cittadinanza italiana.

Chi è Fatima?
Sono cresciuta con mia mamma, mia zia Aisha e mia zia Habiba, poi mia nonna e mia sorella. La mia è una famiglia femmina, forte e coraggiosa. La mia mamma mi ha sempre detto “Fatima, a liberarti sarà la tua mente, e a liberare la tua mente sarà la scuola”. Lei hai studiato molto poco in Marocco, ma vedeva nello studio l’unica cosa che avrebbe potuto fare la differenza tra la sua vita e la mia. E di questo ha fatto una missione. Mamma lavorava sempre, tanto. Tre lavori diversi, ogni giorno, ogni notte. Ne ho sempre avuto la consapevolezza. Di quel lavoro a cui non poteva dire di no nemmeno quando sarebbe dovuta stare a letto, ma anche quel lavoro che le ha permesso di incontrare un’Italia bella, attenta e pronta ad aiutarla. Un avvocato, compagno della signora da cui mamma lavorava nei primi anni 2000, una mattina passò a prenderci a casa per farci fare il giro di tutti gli asili della città, cercandone uno che accettasse me e mia sorella. È andato avanti per giorni fino a quando non ci è riuscito. Accompagnandola al lavoro, ho visto case italiane, ho conosciuto famiglie e bambini che questa lingua la parlavano alla perfezione. Ho vissuto all’interno di una fraternità piena di un amore profondo. Ho avuto amici sognatori, piccole mattonelle che si staccano da un muro di mondo che separa. E poi sono cresciuta libera nella mia identità che ogni giorno si forma, si struttura nel ricordo di quelle persone, di quelle parole e immagini. Perimetrata da valori assiomatici: il rispetto, la determinazione e il ricordo. “Non dimenticarti mai di chi sei, e da dove vieni” e con questo mamma intende anche il Marocco, ma lo intende come parte del mio cammino. Poi c’è la sazietà.
In che senso?
Che bello il concetto di sazietà quando me lo racconta mia mamma. “Sii sazia Fatima, grata di quello che hai perché è tutto ciò di cui hai bisogno. Non avere più fame di quanto chiede il tuo stomaco. E se ti avanza, vuol dire che stai custodendo ciò che è di qualcun altro. Assicurati di darglielo”.
I sogni necessitano di una struttura, di un canale da percorrere. Solo che non tutti sono aperti o accessibili. E a 19 o 20 anni non ti spieghi perché al tuo compagno quella porta è aperta mentre per te è chiusa
Fatima Zahra El Maliani
Che cosa l’ha spinta verso un percorso di studi giuridico internazionale?
Volevo che il mio percorso futuro valorizzasse quello passato. Approfondendo gli studi mi sono resa conto che il mio bagaglio culturale, linguistico e identitario mi dava un osservatorio unico sulla società. Mi sono focalizzata sempre più sullo studio delle migrazioni nella loro dimensione di criminalità organizzata. Ho analizzato le sue dinamiche a livello socio-culturale, economico e geopolitico e gli effetti su di noi come Paese di destinazione, come comunità straniera e come figli di immigrati associati a uno stereotipo criminale veicolato dall’informazione popolare.
Come è nato l’impegno nel doposcuola Prime CasArcobaleno e per il Sermig?
Il Sermig è la fraternità di cui parlavo prima. Mamma mi ci portò per la prima volta a nove anni. Al Sermig ho vissuto gli anni più delicati della mia vita, marcati da grandi contrasti indecifrabili, molta rabbia e molto poco spazio dove sfogarla. E con tutto il brutto che vedevo in me era difficile trovare il bello fuori. Ma questo è stato più forte, è bastato il “Ti voglio bene” di un volontario, una mattina in cui, al posto di arrabbiarsi perché lo stavo insultando, infastidita dal fatto che volesse che io finissi i compiti, mi ha guardata e mi ha detto: “Se mi urli contro non ti odio. Non cambia quanto ti voglio bene”. Quello è stato un momento disarmante, un punto di svolta importante. Lì mi sono resa conto che stavo ricevendo qualcosa di non dovuto ma volutamente donato ed è stato il mio punto fermo per anni. Il doposcuola nasce proprio da quel punto fermo, al Sermig la chiamiamo restituzione. Non era concepibile per me, che un’esperienza così semplice, così naturale come una persona che senza paura e aspettativa ti dice che ti vuole bene, potesse cambiarti la vita. E ancora meno lo era che non tutti avessero l’occasione di vivere la semplicità del bene. E così ho voluto dare un po’ del mio bene ai bimbi del mio quartiere. Oggi sono quasi 40 ed è bellissimo pensare che quel piccolo contributo si possa essere moltiplicato così tanto.

Che cos’è il Marocco per lei?
Quando mi chiedono di ripercorrere la mia storia ho la tendenza a cominciare dai due anni, dall’Italia, anche se in realtà c’è un pregresso, seppur breve. Mamma era arrivata in Italia prima di noi. Soltanto un mese dopo, l’abbiamo raggiunta. In quel mese in Marocco da sole, io e mia sorella siamo state separate. Mia sorella, due anni più grande, era rimasta a casa con nonna, io con zia Amina. Ho un vivido ricordo della passeggiata che ogni giorno facevo sulla schiena di zia Amina, stretta a lei con un velo bianco spesso che annodava sul suo petto, e sorretta dalle sue mani che si intrecciavano all’indietro. Tutti i giorni attraversavamo le stesse strade, e percorrevamo gli stessi marciapiedi. Passavamo davanti agli stessi negozi, e di fronte a uno in particolare le chiedevo di fermarsi e le promettevo che una volta arrivata in Italia, da grande, avrei lavorato tanto e le avrei comprato quella tazza, due piatti che tanto le piacevano, poi un orologio e una borsa. E lei, girando il velo e facendomi trovare il suo viso di fronte, sorrideva e mi diceva “Mi raccomando, non dimenticarlo. Ci tengo!” E poi rideva. Sono stata con lei un mese. Un mese in cui piangendo cercavo mamma, e lei, stringendomi forte, mi diceva alle orecchie “Arriva Fatima, arriva. E poi, non sei forte? Come vuoi andare in Italia se piangi per così poco?”.
E l’Italia?
Mamma alla fine è arrivata veramente, anche se in realtà a essere arrivata ero io. Mamma già mi aspettava qui. Da lei mi ha portata nonna. Avevo due anni. Sono ripartita da una nuova casa torinese con sempre nel cuore, e solo più tardi nella testa, mia nonna, mia zia Amina, e quel lenzuolo che non mi faceva cadere. Il Marocco è stato il mio primo letto soffice e sicuro. L’Italia il tavolo su cui ho disegnato prima i quadri per mamma, poi la mia vita. È la casa dove ho ricordato il mio passato, vivo il mio presente e sogno il mio futuro.
Occupa importanti ruoli “in uscita”: ne sente la responsabilità?
Ho imparato una cosa in questi anni, e cioè che la responsabilità non bisogna soltanto chiederla, ma volerla. Fa paura, a 22 anni, diventare all’improvviso una figura rappresentativa di una generazione, di un’esperienza e di una condizione. Fa paura perché è un microfono e un’attenzione a cui non solo non sei abituata, ma che per vari motivi non immaginavi ti potesse capitare. E quando ti capita vai in crisi. Ho vissuto questo quando ho saputo della nomina dal Presidente Sergio Mattarella. Mi sono detta “Perché hai così tanta paura se sai cosa vuoi dire?”. E mi sono risposta che, seppur impreparata, spaventata e intimorita, era possibile che a una ragazza qualunque di Porta Palazzo venisse chiesta la sua opinione. Fare un passo indietro avrebbe significato arrendersi a un recinto che non avevo costruito io.
Lo stesso driver mi sta guidando nel percorso in Fondazione Compagnia di San Paolo. La nomina è stata del tutto inaspettata. Non è semplice metabolizzare che una realtà così grande, e che un po’ mi ha coltivata, creda che la mia opinione ed esperienza siano importanti per migliorare un territorio. Anche qui si è sdoganato un mito importante: all’usuale tavolo dei grandi c’è spazio anche per una giovane donna che dialoga e costruisce alla pari di tutti gli altri.
L’esperienza al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico è stata un’occasione per me di auto-misurazione: ho avuto l’opportunità di vivere una scuola di dialogo e costruzione, oltre che di studio. Un’esperienza che dai primi giorni mi ha caricata di una responsabilità alla quale non volevo rinunciare e che mi accompagna nelle mie scelte di tutti i giorni, ma mi porta, nel mio ruolo di presidente regionale, ad assicurarmi che un’occasione come questa possa essere di tutti e di tutte.
Infine, il doposcuola ormai battezzato Prime. Qui la responsabilità è fare fede alle paure che avevo quando sono entrata per la prima volta al Sermig. Ascoltare i bimbi come sono stata ascoltata io, abbracciarli e amarli anche quando mi urlano contro.
Cosa significa la parola cittadinanza?
La cittadinanza è responsabilità. È costruzione, contributo e cammino verso una direzione comune. È lotta e voce, ed è il diritto di averne una che si possa sentire. Non avere la cittadinanza comporta un limite oggettivo, insormontabile nel breve termine che ti obbliga, se hai la “fretta” di vivere una vita serena come tutti gli altri, a essere creativo e cercare, e per forza trovare, delle alternative. All’inizio, quando tutto è diritto di tutti, e cioè quando sei ancora piccolo, è una cosa di cui non ci si accorge. Ma più si cresce più la consapevolezza diventa frustrante. I sogni sono quello su cui si lavora quando si hanno tutti i diritti, i sogni necessitano di una struttura, di un canale da percorrere. Solo che non tutti sono aperti o accessibili. E a 19 o 20 anni non ti spieghi perché al tuo compagno quella porta è aperta mentre la stessa per te è chiusa. E quei sogni che tanto volevi realizzare facilmente si trasformano in rabbia.
Che cosa rappresenta il referendum dell’8 e 9 giugno?
Questo referendum è un’occasione per noi come comunità, nel suo intero, di misurarci. Per capire, prima ancora di quale Italia vogliamo, che Italia siamo. Abbiamo tutti l’innegabile responsabilità morale, civile e sociale di rompere quel recinto. Per noi e per chi è cresciuto accanto a noi. È una legge che, se approvata, consente di sognare e di poter vedere, anche in una minima percentuale, quei sogni realizzarsi. E questo può cambiare tutto.
Le fotografie sono state fornite dall’intervistata
Cosa fa VITA?
Da 30 anni VITA è la testata di riferimento dell’innovazione sociale, dell’attivismo civico e del Terzo settore. Siamo un’impresa sociale senza scopo di lucro: raccontiamo storie, promuoviamo campagne, interpelliamo le imprese, la politica e le istituzioni per promuovere i valori dell’interesse generale e del bene comune. Se riusciamo a farlo è grazie a chi decide di sostenerci.