Adolescenti
L’urbex, la trasgressione e la reputazione: parola agli esperti
La nuova passione dei giovani, l'urbex, ha aspetti di illegalità e comporta dei rischi. Come leggerla? Ecco le voci di Francesca Antonacci (pedagogista Università Bicocca), dell'antropologo francese David Le Breton e di Cristiano La Mantia (Ascosi Lasciti)

Che la meta sia una casa diroccata, o una fabbrica in disuso, o una vecchia discoteca abbandonata, o una stazione dismessa, l’esplorazione urbana è un’attività che ha sempre il sapore e le caratteristiche della clandestinità, del buio, del rischio. Ed è proprio questo uno dei suoi elementi attrattivi nei confronti dei più giovani. Questa attività, tuttavia, da qualche tempo viene riconosciuta e valorizzata anche come esperienza di formazione: al punto che, alcuni anni fa, il progetto europeo “Urban Exploration as an Educational Tool: UrbEx” è stato dedicato proprio a questo.
Il carattere formativo, quasi fondativo di questa esperienza viene messo in luce da Francesca Antonacci, docente di Pedagogia del gioco e di Pedagogia dei linguaggi artistici presso l’Università di Milano-Bicocca: «L’urbex è uno dei modi in cui i ragazzi dicono e dimostrano di sentirsi espropriati, quasi derubati da un mondo che non li sta considerando: non li sta considerando la scuola, che non è fatta per loro, con la sua impostazione vecchia 150 anni. Non li sta considerando il lavoro, che è uno spazio degli adulti in cui i giovani si sentono costretti e poco adatti, visto che con titoli di studio anche alti trovano solo stage pagati male. Non c’è, insomma, un pensiero su di loro. E questo i ragazzi lo sentono. Per questo cercano di riappropriarsi di spazi urbani e di un posto nella società».
Un altro elemento fondamentale nell’urbex è «la dimensione del gruppo», continua Antonacci. «E nel gruppo, la costruzione e il rafforzamento della reputazione, individuale e collettiva. In questo, l’urbex ricorda molto altri fenomeni, come l’hip hop, o il parkour, oppure il graffitismo, con cui i ragazzi si prendono le piazze, gli spazi, i mezzi pubblici. I ragazzi cercano spazi in cui far sentire che sono qualcuno, in un mondo e un modo diverso da quello dei social. Anche se poi i social, inevitabilmente, ne diventano cassa di risonanza».

L’urbex come “contronarrazione delle adolescenze”
L’urbex, insomma, così come altre esperienze simili, del presente come del passato, «ci parla di un’altra adolescenza rispetto alla narrazione terribile che facciamo e sentiamo sui giovani, vecchia e figlia di conformismo: da sempre le generazioni adulte e anziane si lamentano dei giovani, è una storia cha va avanti addirittura dall’antica Grecia, come racconta un video divertente e illuminante di Franco Nembrini», dice Antonacci. «Ma l’adolescenza, di cui tanto ci piace parlare male, di fatto non esiste: esistono “le adolescenze”, come preferiamo chiamarle in Bicocca. Gli adolescenti sono quelli dipendenti dalle sostanze e dai social, ma sono anche quelli che vanno in giro per il mondo per fare volontariato. Certo, i ragazzi vogliono differenziarsi da noi, che in effetti ne abbiamo combinate di belle: nel pianeta, nel lavoro, nella politica, nella medicina. Sono loro che si lamentano di noi e hanno tutte le ragioni per farlo».
L’urbex può quindi essere un modo per creare questa distanza e differenziarsi. «E il bello è che non c’è volontà distruttiva – fa notare Antonacci – e neanche un desiderio di disegnare, trasformare, modificare, com’è per esempio nel graffitismo. Nell’urbex c’è al contrario quell’idea di rispetto che è propria di questa generazione, la quale esplora e si prende cura. Non c’è nessun afflato di scontro con gli altri, ma la voglia di scoprire insieme, in un’impresa che è anche atletica, un’altra cosa che piace a questa generazione, che ha tanto a cuore il proprio corpo. Questo lavoro sul corpo e con il corpo è un modo per prepararsi alle sfide del mondo, per irrobustirsi e diventare forti e pronti per un futuro sempre più imprevedibile».
I rischi e il compito degli adulti
E l’adulto? «L’adulto fa il suo lavoro, che è quello di cercare di impedire un’attività piena di rischi. Da madre, non nascondo che sono preoccupata, ma da pedagogista so che quest’attività, se svolta nel rispetto di se stessi, degli altri e delle regole di sicurezza e buon senso, va letta come legittima richiesta di essere visti dagli adulti. Una richiesta che ci arriva da una generazione che ci piace definire nascosta, apatica, debole. E che con l’urbex viene a dirci: “Guardate dove siamo: siamo sui vostri tetti“».
Di tutto questo fa parte, evidentemente, la componente di rischio e di sfida, «di cui parla molto bene l’antropologo svizzero David Le Breton nei suoi saggi sull’adolescenza», prosegue Antonacci. «Il rischio appartiene al mondo dell’adolescenza come rivincita sociale, spazio che viene contrastato dagli adulti perché ne hanno paura: l’urbex, come le gare tra le auto nei film degli anni ‘50, diventa un luogo del rischio in cui gli adulti non si avventurerebbero mai».
De Breton, l’avventura e l’oblio dei padri
Proprio a David Le Breton abbiamo quindi chiesto una lettura “antropologica” dell’urbex, in relazione soprattutto all’esperienza dei più giovani. «L’urbex è l’avventura dietro l’angolo, una meravigliosa fuga dalle regole sociali e dall’istituzione. E poi c’è sempre la fantasia, il sogno di trovare un tesoro, non uno scrigno pieno d’oro, qualcosa di inaspettato, straordinario. In realtà, è una vecchia storia: da adolescente, anche io adoravo esplorare case abbandonate e rovine. Questi spazi incarnavano una sorta di libertà; non c’era più il controllo degli adulti, in questi spazi liberati dai vincoli».
Nell’urbex c’è poi il fascino della rovina, del mistero, del silenzio, che per De Breton «è un po’ una costante, un po’ come costruire una capanna: significa distinguersi dai propri genitori, invitare gli amici a condividere questi spazi. Nell’urbex c’è la fantasia di partecipare a una sorta di spedizione clandestina, deridendo tutte le autorità e consolidando la forza dei propri coetanei. È l’oblio dei padri a favore dei coetanei: una resistenza alle parole adulte dei loro genitori e a quelle della società che mette cartelli di divieto».
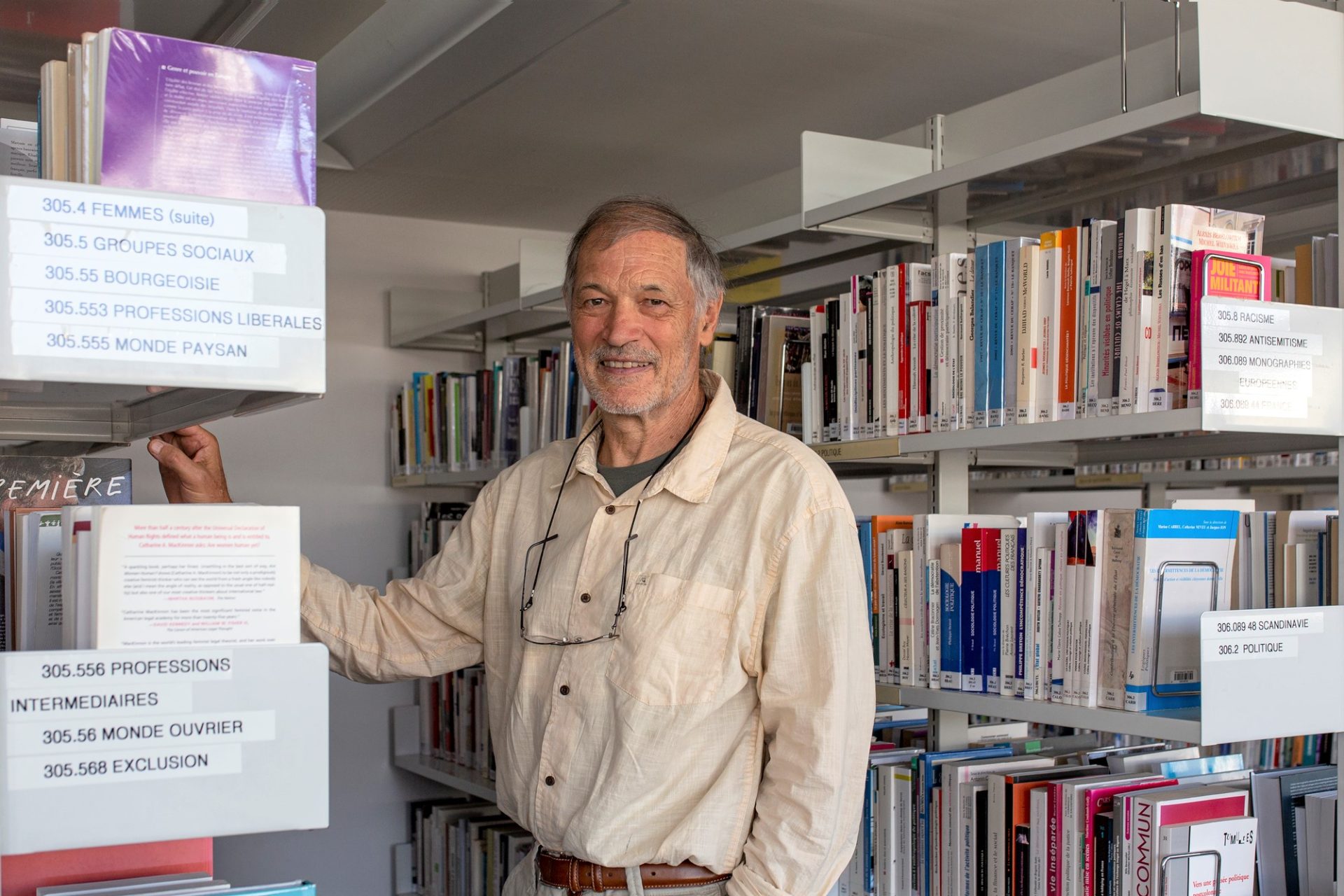
I divieti, però, servono anche a proteggere, a mettere in guardia da pericoli reali: proprio questi pericoli, però, sono elemento fondante e fondamentale dell’esplorazione: «I giovani sanno che alcuni di questi luoghi sono potenzialmente pericolosi, ma questo accresce l’entusiasmo nell’esplorarli e nel mettersi alla prova. Devono superare le proprie paure e dimostrarsi all’altezza della situazione di fronte agli altri. E andare avanti. È sia una sfida che un senso di appartenenza a un gruppo un po’ clandestino, un po’ piratesco».
Ascosi Lasciti, «ragazzi, non rischiate la vita per una foto»
Cristiano La Mantia, urbexer storico e dalla passione intramontabile, mette in guardia: «L’urbex ha delle regole e vanno rispettate. L’obiettivo non è scattarsi foto belle, ma riscoprire e valorizzare le radici». Per questo scopo è nato, 15 anni fa, da un’idea di Alessandro Tesei e Davide Calloni, il collettivo Ascosi Lasciti, la più importante realtà nazionale che si occupa di esplorazioni urbane. Un collettivo che si articola in sedi regionali, ciascuna con il proprio referente, il quale periodicamente pubblica sul sito le foto e le storie delle proprie esplorazioni. Da questa esperienza, che ha conosciuto negli anni uno sviluppo straordinario, è nata l’associazione culturale, di cui La Mantia è presidente. «L’urbex è di per sé una realtà culturalmente e socialmente trasversale: ne fanno parte fotografi come me, ma anche professori di storia, di lingue, di architettura, o semplici appassionati di esplorazione e trekking». L’obiettivo è scoprire ed esplorare luoghi, spesso antichi e carichi di storia, che siano testimoni di un passato che non c’è più, ma anche ancora vive nell’anima dei territori e ne costituisce parte integrante. «Oggi il nostro archivio fotografico conta circa 1.700 luoghi esplorati, di cui quasi mai forniamo le coordinate: un po’ per tutelarli, un po’ per gelosia, lo ammetto. L’obiettivo dell’associazione non è promuovere urbex dato che non si può promuovere un’attività che comporta pericoli evidenti, ma riscoprire le radici dei luoghi. Possiamo dire che l’ urbex nasce quando vedi una porta aperta e ci entri. Non sfondare nulla è la prima regola».
I luoghi sono i più disparati. dalle stazioni alle fabbriche, passando per le case o le discoteche abbandonate: «Queste ultime riscuotono un grande interesse, come dimostra il successo di un libro che abbiamo dedicato proprio a loro: testimoni di un mondo e di un costume che sta scomparendo, ma che tanti di noi ricordano bene, come parte della loro giovinezza. Max Pezzali ci ha contattato e si è ispirato al nostro libro per il brano Discoteche abbandonate».

Per scovare questi luoghi, ci sono tante applicazioni, «ma io» dice La Mantia, «preferisco gli anziani nei bar di paese: li avvicino, inizio a parlare di un edificio abbandonato che ho visto nelle vicinanze e loro si rivelano enciclopedie viventi». E così l’urbex diventa anche un luogo d’incontro intergenerazionale, anche per il fatto che sempre più giovani e giovanissimi ci si stiano avvicinando. Questo, a La Mantia, piace e non piace. «L’urbex è per chi crede nel territorio e vuole dargli valore. Io sono un siciliano di 45 anni che non è andato via, ma gli amici rimasti li conto su una mano. Credo nel territorio e credo anche che intorno ai luoghi abbandonati si possa sviluppare il turismo, che peraltro già esiste sotto forma di cosiddetto ‘dark tourism’: Chernobyl, per esempio, era un tipico luogo di esplorazioni, prima della guerra in Ucraina». Cosa c’entra questo con i giovani? «C’entra con il fatto che l’urbex diventi di massa, come se fosse una moda. E che automaticamente venga fatto con superficialità e poca consapevolezza sia dei valori che ci sono dietro, sia delle regole che si devono rispettare, nell’interesse proprio e nel rispetto dei luoghi e delle persone». Anche di se stessi.
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
