Per gentile concessione dell’editrice Città Nuova, pubblichiamo la prefazione del professor Luigino Bruni, ordinario di Economia politica all’Università Lumsa di Roma, al libro L’astuzia del capitalismo di Pierre-Yves Gomez, uscito recentemente nella collana IdeeEconomia.
C’è bisogno di una nuova riflessione sul capitalismo, in particolare in rapporto alla pace e alla democrazia. Il capitalismo ha tenuto un rapporto ambivalente sia con la democrazia che con la pace. Il sistema capitalista vive e cresce guidato da un solo unico fine, cioè la massimizzazione razionale della ricchezza sotto forma di profitti e sempre più di rendite.
È questo il nucleo che spinge tutto il treno del nostro capitalismo. Per i proprietari dei grandi attori globali, tutto ciò che non sia accrescimento di profitti e rendite è solo un vincolo da aggirare o allentare, incluse le varie legislazioni ambientali, sociali, fiscali. Per questo capitalismo la sola motivazione “intrinseca” è la massimizzazione dei flussi e degli asset economici e finanziari: tutto il resto è solo mezzo in vista di questo unico fine.

Tra questi mezzi ci possono essere anche la democrazia e la pace, ma non sono necessari. In genere, lo spirito del capitalismo e dei capitalisti è adattivo e pragmatico: se in una regione del pianeta ci sono democrazia e pace, si inseriscono in queste dinamiche democratiche e pacifiche e fanno i loro affari; ma non appena il clima politico cambia, con un pragmatismo cinico cambiano linguaggio, alleati, mezzi, e usano guerre, dittature, populisti e populismi per continuare a perseguire il loro unico scopo. In altre circostanze, del passato e del presente, se qualche grande potentato economico intravede in scenari bellici e non democratici opportunità di maggiori guadagni, non si fa nessuno scrupolo a svolgere un ruolo attivo nel cambiamento, perché, giova ripeterlo, il telos, la natura di questo capitalismo, è massimizzare profitti e rendite. Quindi non c’è nessun rapporto necessario né affinità elettiva tra capitalismo e pace né tra capitalismo e democrazia, e neanche tra capitalismo e liberismo: sono tutte alleanze tattiche, tutti mezzi in vista dell’unico fine. Basti pensare, per un grande e scomodo esempio, all’avvento del fascismo in Italia: non avremmo avuto nessun ventennio fascista senza la scelta della borghesia industriale e finanziaria italiana di usare quello sparuto gruppo di picchiatori violenti per proteggersi dal “pericolo rosso” concreto e possibile.
Davanti alla paura di perdere ricchezze e privilegi, quell’élite capitalista italiana un secolo fa non ebbe nessuna remora ad abbandonare democrazia, libertà e diritti e favorire l’emergere del regime fascista. L’economia corporativa del fascismo, che conquistò e contagiò la gran parte degli economisti liberali italiani e cattolici, si presentava come superamento sia «del sistema individualistico-liberale», che «aveva dominato le nazioni civili durante il XIX secolo fino alla guerra», sia «del comunismo: si vuole un sistema atto a mediare gli estremi, superandoli.
Se qualche grande potentato economico intravede in scenari bellici e non democratici opportunità di maggiori guadagni, non si fa nessuno scrupolo a svolgere un ruolo attivo nel cambiamento, perché, giova ripeterlo, il telos, la natura di questo capitalismo, è massimizzare profitti e rendite
Si rivela, anche qui, l’armonia dello spirito latino». E Francesco Vito, uno degli economisti cattolici italiani di riferimento, nella sua Economia politica corporativa, scriveva: «Il compito dell’economia nuova consiste essenzialmente nell’assunzione consapevole dei fini sociali al posto della concezione individualistica della società finora prevalsa».
La teoria individualista liberale non conveniva più al capitale, ecco pronta la nuova economia corporativa e statalista.
A metà Settecento, Montesquieu nel suo Spirito delle leggi scriveva la celebre tesi che «l’effetto naturale del commercio è portare la pace», aprendo la stagione dell’utopia del “dolce commercio”. Qualche anno dopo, Antonio Genovesi così commentava quella frase del filosofo francese: «Gran fonte di guerra è il commercio». Genovesi sapeva molto bene che il mercato è un’alta forma di civiltà, e su questo muro maestro aveva costruito la sua economia civile. Però sapeva anche che «lo spirito del commercio non è altro che quello delle conquiste», perché, «tra i barbari si conquistano persone e le terre, tra i popoli trafficanti le ricchezze». Genovesi stava, realisticamente, dicendo che quando il commercio è usato dalle potenze politiche, diventa un mezzo molto simile alle navi da guerra e ai cannoni.
Ieri, e oggi. Stiamo attraversando una nuova fase di alleanza tra lo spirito capitalistico e quello bellico e illiberale, che lascia le democrazie per le leadercrazie populiste nazionaliste e protezioniste. Ieri le paure erano quelle “rosse”, oggi sono quelle dell’immigrazione, di una globalizzazione troppo rapida, del cambiamento climatico (cui si risponde negandolo), dell’impoverimento della classe media. Il capitale globale sta di nuovo sacrificando i valori democratici e la pace sull’altare del suo unico fine.

Questo libro è una riflessione sul suo spirito, un tema reso celebre da Weber, e prima di lui da Marx, quindi da Benjamin e infine oggi da Agamben, che Gomez tratta con una sua originalità.
Il capitalismo ha sviluppato un rapporto predatorio con la terra, non applicando la legge aurea del mutuo vantaggio anche nel rapporto uomo-natura, e ha considerato il pianeta e le altre specie come risorse da usare per accrescere i propri vantaggi, senza includere tutte le creature dentro la propria rete cooperativa. Nel Novecento era ancora costruito attorno alla figura dell’imprenditore, poi verso la fine del secolo il timone è passato ai manager e infine ai consulenti, che oggi sono i veri protagonisti del capitalismo del XXI secolo. La leadership che sta trasformando la democrazia in leadercrazia è il grande dogma, insieme alla meritocrazia, del nuovo capitalismo del XXI secolo.
In questa mia prefazione vorrei soffermarmi su una dimensione poco affrontata, ed è ovvio, nel saggio, quella cioè della dimensione religiosa o meglio idolatrica del capitalismo del XXI secolo, che è esplosa in concomitanza con lo spostamento del suo centro dalla produzione e dalla fabbrica al consumo e allo shopping online. Ogni idolatria è culto di puro consumo senza metafisica, e solo un capitalismo di consumo poteva mostrare i segni sacrali che già conteneva da secoli ma che non erano ancora abbastanza evidenti.
Il capitalismo dei secoli XIX e XX è stato animato da uno spi- rito economico con profonde radici ebraico-cristiane, spirito di lavoro, di fatica, di produzione. Ma oggi non capiamo più lo spirito del nostro capitalismo attuale se continuiamo a cercarlo solo o principalmente all’interno del cristianesimo o della Bibbia. La società di mercato negli ultimi anni assomiglia sempre più a una religione, ma i tratti che sta assumendo l’avvicinano alle civiltà mediorientali di tremila anni fa, o a quelle greche e romane di alcuni secoli successive, e ai loro spazi pubblici occupati da statue, templi, steli, altari, edicole sacre, e ai loro spazi privati riempiti di amuleti, penati, e da un’enorme produzione di idoli domestici, e ai loro molti sacrifici, attorno ai quali erano ordinate la vita, le feste, la morte. L’umanesimo cristiano è stato, soprattutto, un tentativo di svuotare il mondo dagli idoli e liberarlo dai sacrifici, un tentativo solo in parte riuscito, perché è sempre stata troppo forte negli uomini la tendenza a costruire idoli per poi diventarne adoratori. I profeti, la tradizione sapienziale (Qohelet), e poi Gesù, hanno operato una rivoluzione religiosa straordinaria anche per la loro lotta idolatrica radicale. Hanno cercato di eliminare gli idoli dai templi, dalle chiese e dalle case e creare così un ambiente spirituale più alto, meno legato ai cicli naturali della vita e della morte. Il cristianesimo, poi, avrebbe dovuto superare per sempre l’antica logica sacrificale, perché al sacrificio degli uomini offerti a Dio ha sostituito il sacrificio-dono di Dio offerto agli uomini, instaurando l’era spirituale della gratuità. Ma oggi, dopo duemila anni, il capitalismo, combattendo prima la gratuità e poi cercando di metterla nel suo libro paga, sta reintroducendo nel proprio culto arcaiche pratiche sacrificali.
La cultura sacrificale del capitalismo la possiamo intravedere di fatto ovunque. Sacrificio è anche una parola chiave delle nuove grandi imprese globali.
Vediamone qualche accenno.
La cultura sacrificale del capitalismo la possiamo intravedere di fatto ovunque. Sacrificio è anche una parola chiave delle nuove grandi imprese globali. Per capire l’universo del “sacro” aziendale, non dobbiamo fermarci ai suoi aspetti più superficiali ed evidenti a tutti, quali la presenza nelle imprese di coach che cercano di imitare i vecchi padri spirituali; l’uso di parole prese dal linguaggio spirituale, come “missione”, “vocazione”, “fedeltà”, “merito”; i finti riti di iniziazione dei neoassunti e le pseudoliturgie; il disprezzo della parola “vecchio” che ormai è diventata una parolaccia o un insulto (“sei vecchio!”), tutti i culti idolatrici adorano la gioventù. Questi fenomeni sono infatti sintomi epidermici di qualcosa di molto più profondo e radicato nell’organismo del capitalismo.
Dopo aver utilizzato, fino a pochi anni fa, linguaggi e metafore presi dalla vita militare e poi dallo sport (“win win”), le grandi imprese capitalistiche si stanno accorgendo che per comprare il cuore dei propri dipendenti c’è bisogno di un codice simbolico più forte, e lo stanno prendendo dalla sfera religiosa. Solo la religione è capace di far dare molto o tutto ai suoi fedeli.
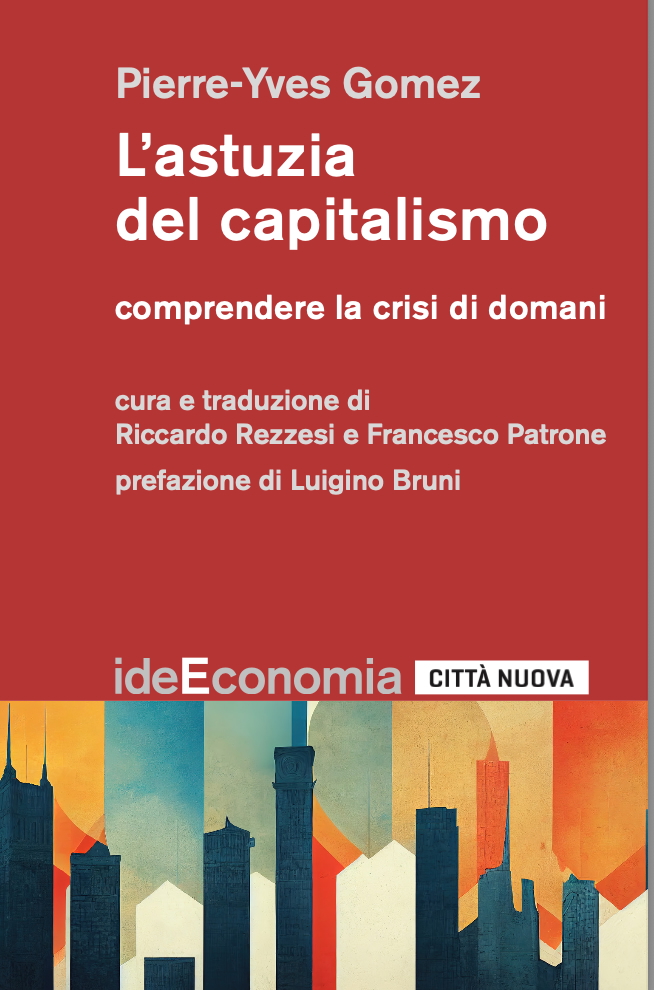
Se il business assume i caratteri religiosi
Ma i codici simbolici non li sta prendendo dalla religione ebraico-cristiana (questo lo ha fatto il capitalismo dei secoli passati), né, tantomeno, da altre grandi religioni (islam o induismo), anche se ha rapporti equivoci con un certo buddismo.
Questi grandi umanesimi spirituali sono troppo complessi e resilienti per essere facilmente manipolati dal business. E allora, con un balzo indietro di millenni, tornano direttamente al totemismo, allo sciamanesimo (oggi di gran moda) e ai suoi sacrifici. Siamo dentro un’inondazione di culti banali, imitazioni di cose più serie dei millenni passati, e non ce ne stiamo neanche accorgendo.
“Sacrificio” è una parola centrale nel nuovo business. Il sacrificio è chiesto ai lavoratori delle grandi imprese: sacrificio di tempo, della vita privata, sociale e familiare. Il lavoro è sempre stato fatica, sudore, e quindi in un certo senso anche sacrificio. Ma il sacrificio della cultura dell’impresa del XX secolo era trasparente in chi lo faceva e in chi lo riceveva. Tutto il movimento sindacale era riuscito a contenerlo dentro limiti politici, e quando eccedeva questi limiti non era chiamato “sacrificio” ma “sfruttamento”.
Abbiamo sempre saputo che dietro a molto lavoro c’erano “dèi” lontani che vivevano di rendita grazie ai nostri sacrifici e allo sfruttamento del nostro lavoro nei campi e nelle fabbriche: ma ne eravamo coscienti, ci soffrivamo molto, e abbiamo lottato per ridurre o eliminare queste ingiustizie. Oggi la manipolazione semantica della nuova religione sta riuscendo a presentarci il sacrificio come una forma di “dono” volontario da parte dei lavoratori. Siamo più sfruttati, ma, diversamente da ieri, dobbiamo essere felici dei nostri sacrifici, interiorizzarli come dono. Il sacrificio richiesto ai lavoratori dalle grandi imprese è un atto necessario per poter sperare nel “favore degli dèi” e quindi fare carriera.
Chi, invece, si rifiuta di fare questi sacrifici e di salvaguardare un confine tra impresa e famiglia, chi non accetta le richieste di restare in ufficio fino alle 11 di sera, rimane fuori dal numero degli eletti e, spesso, sviluppa gravi sensi di colpa per il suo essere un perdente.
Inoltre, come nei sacrifici agli antichi dèi e idoli le offerte e i voti non potevano mai estinguere il debito del sacrificante, oggi in queste imprese più si dona tempo e vita più vengono richiesti tempo e vita, finché un giorno esauriamo le nostre offerte – ma in questo giorno, il management ci offrirà “gratuitamente” il giusto coach che ci farà rialzare per recarci di nuovo all’altare e offrire altri sacrifici. L’idolo non si sacrifica, può solo ricevere sacrifici dai suoi fedeli.
Il colpo di genio del neo-capitalismo:
il sacrificio nel contratto
Gli dèi invisibili e lontani si nutrono dei sacrifici dei lavoratori, ne hanno sempre più un bisogno vitale. Ma il colpo di genio di questo capitalismo sta nell’essere riuscito a coprire con il contratto la struttura sacrificale del “mercato del lavoro”. Ciò che in realtà ci chiedono è un sacrificio, ma presentandolo come contratto libero nascondono molto bene la sua vera natura. Inserendo il sacrificio della vita all’interno di un normale contratto, pagando le imprese diventano totalmente slegate e ingrate verso i loro fedeli. E il giorno in cui le opportunità di mercato e di profitti cambiano, non si sentono debitrici per quei molti sacrifici ricevuti, e volano via verso nuovi paradisi fiscali; e, nell’ipotesi migliore, con poche migliaia di euro ripagano il sacrificio di una vita, il sacrificio della vita. Il sacrificio degli antichi culti doveva essere vivo: agli dèi si offrivano animali, bambini, vergini, raramente piante (libagioni), mai oggetti. I nuovi dèi continuano a chiedere sacrifici vivi, chiedono vita e restituiscono denaro.
La natura sacrificale di questo capitalismo non è tanto una proprietà morale delle persone, riguarda il sistema nel suo insieme. Le sue prime vittime sacrificali sono gli stessi dirigenti e manager, sacerdoti e vittime insieme. Lo scenario probabile e cupo che si prospetta all’orizzonte della nostra civiltà è una rapida crescita di questa nuova idolatria, che dall’ambito economico sta via via migrando verso la società civile, la scuola, la sanità. Non trova opposizioni nel suo sentiero di espansione, perché ricorre a simboli religiosi che la nostra cultura non ha più le categorie per comprendere. Chi oggi vuole capire e magari governare l’economia e il mondo, deve studiare meno business e più filosofia e antropologia.
Al tempo stesso, siccome la realtà è superiore all’idea, anche dentro questo culto capitalistico ci sono fenomeni che vanno nella direzione opposta al culto globale, imprese e persone che si muovono in direzione ostinata e contraria – forse mai come oggi si moltiplicano le esperienze di economie circolari, sociali, green, benefit, civili, di comunione, di transizione, profetiche, utopiche.
Camaleontico spirito del capitale
Anche questi segni diversi fanno parte dello scenario del capitalismo attua
se proprio vogliamo chiamarlo così, per quella capacità camaleontica che lo contraddistingue, come messo in luce dai lavori di Luc Boltanski sul “nuovo spirito capitalismo” (che, per i temi che tratta, ci aspettavamo dentro questo libro). Il sistema sta generando anomalie che ne decreteranno il superamento, come è avvenuto con tutti gli imperi della storia, e il primo luogo dove questo superamento si sta compiendo è l’ambiente; perché se possiamo discutere i pro e i contro del capitalismo in alcune aree sociali (dalla diseguaglianza all’aspettativa di vita), e possiamo lasciare la somma algebrica aperta in base ai pesi che assegniamo ai vari fattori, dove il capitalismo ha fallito è nel suo rapporto con il pianeta, e quindi con il futuro.
E sarà qui che sarà superato. Di queste tendenze ostentate e contrarie nel libro si parla poco, e così un tono cupo lo avvolge dalla prima all’ultima pagina. Un tono cupo di cui l’autore è ben cosciente, e che ha voluto lasciare, consapevole della gravità etica – perché di etica si parla – delle attuali crisi procurate dal capitalismo, senza indugiare in considerazioni che avrebbero potuto aumentare le molte illusioni generate dal capitalismo stesso.
Nella foto di AP Photo/Darron Cummings/Lapresse, l’11 agosto scorso, addetti dello stabilimento Ford di Louisville ascoltano in assemblea il ceo di Ford Jim Farley.
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it

