Continua il nostro viaggio fra personaggi che, a vario titolo, si occupano di sostenibilità, per capire che cosa vedono dai loro punti di osservazione. Davvero stiamo tornando indietro? Davvero siamo pronti a dimenticare gli impegni presi (o quelli che dovremmo prendere), per la lotta al cambiamento climatico? O per raggiungere quelli che, fino a ieri, sembravano obiettivi condivisi per lo sviluppo sostenibile? La parola allo scrittore Matteo Righetto.
Oltre a scrivere e intervenire in convegni e dibattiti, Matteo Righetto è presidente di una sezione del Club alpino italiano sulle Dolomiti, in un territorio tra i più belli e più sotto attacco. Ha voluto mettersi al servizio della montagna non solo con le parole, ma con un impegno concreto nel volontariato, al servizio delle terre alte. Le iniziative che promuove vanno tutte nella direzione di una rieducazione sull’andare in montagna. Tiene seminari di Letteratura del paesaggio all’Università di Padova e insegna in un liceo. Vive tra Padova e Colle Santa Lucia. È autore, tra l’altro, del romanzo La pelle dell’orso (Guanda 2013), da cui è stato tratto un film con Marco Paolini.
Il suo libro più recente, Il richiamo della montagna, uscito quest’anno per Feltrinelli, è dedicato ai suoi studenti. Insegnando letteratura, riesce a parlare anche di ambiente e sostenibilità?
Sì, la letteratura permette di costruire percorsi tematici, pluridisciplinari, ponendo grandi riflessioni etiche. L’ecologia integrale, oggi, è una delle frontiere più importanti. Comprende anche l’economia e il sociale, aspetti cruciali, in una società sempre più disgregata e attraversata da disuguaglianze. Tutto questo ha a che fare con la cura del creato, e della montagna. Prendersi cura della terra significa anche prendersi cura degli altri, e viceversa. Basta leggere l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, per capire quanto importanti siano queste interconnessioni. La questione ecologica è molto complessa, non è semplice ambientalismo. È una sorta di legame tra tutti i viventi. I ragazzi lo capiscono molto più dei genitori o dei nonni. Loro avranno la possibilità concreta di cambiare direzione rispetto a un sistema economico e di sviluppo che non è sostenibile. Ed è a loro che mi rivolgo e dedico questo libro, con la speranza di risvegliare le coscienze e una consapevolezza ormai necessaria. Sono fiducioso, perché registro una sensibilità che la mia generazione non aveva.
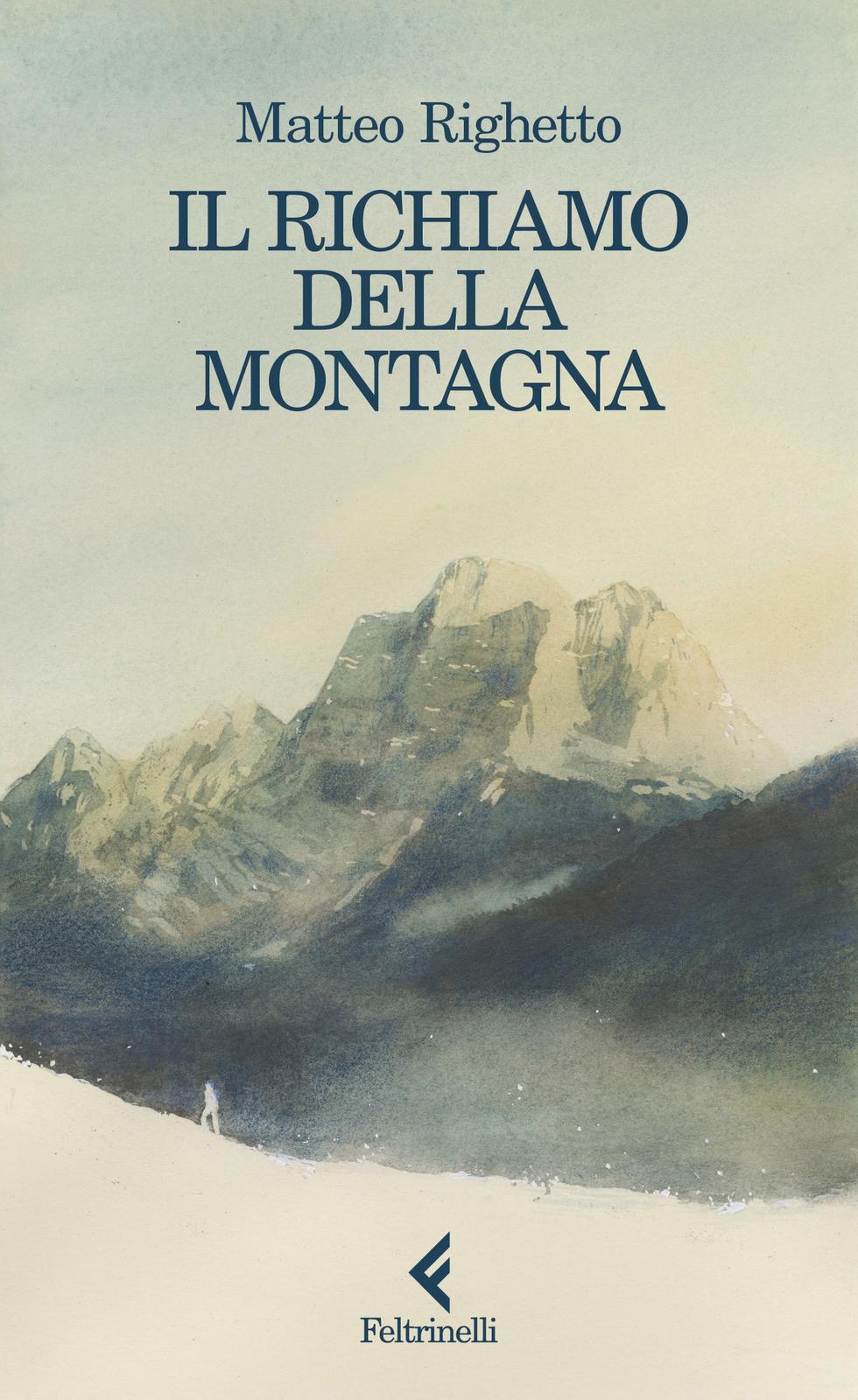
Ma non dipenderà anche dai messaggi che ricevono? Da chi fa lezione?
Sicuramente sì, ma al di là dei buoni o cattivi maestri, avverto che c’è un’attenzione degli studenti, in generale verso ciò che è altro da sé, più attenta e puntuale rispetto al passato. Si rendono conto, per esempio, che il consumo del suolo mina la qualità delle loro vite, che le città non sono respirabili… Quando ero ragazzo, io non vedevo l’ora che arrivasse l’estate, perché era la stagione più bella. Oggi, per uno studente è il periodo più brutto dell’anno, perché c’è una sorta di isolamento domiciliare. Nelle città fa troppo caldo, stanno chiusi in casa con il condizionatore, non vedono nessuno, come durante la pandemia. È cambiato veramente il mondo. C’è una grande voglia, e necessità, di riscoprire l’ambiente naturale, di respirare aria buona.
Ci sono però anche i risvolti negativi dell’overtourism. Quest’estate, si parla delle code per prendere la funivia e salire sul Seceda, in Alto Adige. Lo scorso inverno si discuteva dell’assalto alle piste di sci di Roccaraso, in Abruzzo…
Le persone che salgono in montagna il fine settimana, in maniera spesso scomposta, sgradevole, volgare, devono essere educate. La loro è una frenesia tossica. Sembra quasi ludopatia, una continua ricerca di divertimento, in un ambiente trasformato in parco giochi. È la coda di una cultura consumistica partita negli anni Settanta, che negli anni Ottanta ha raggiunto la muscolatura più importante. Ce la portiamo ancora dietro, con l’aggiunta della superficialità accentuata dall’edonismo dei social. Alla fine, si torna a casa frenetici, senza portare a casa nulla di culturale, di esperienziale, di spirituale. Intendo la spiritualità non nel senso della religione, ma del sacro, come negli scritti del filosofo e naturalista scozzese americano John Muir, o di Mario Rigoni Stern. Parlo di quella luce che c’è nelle cose vive, non riproducibili tecnicamente, quella sorta di benedizione che si trova solo nel raccoglimento in un ambiente naturale.

Qualcuno potrebbe dire che non c’è il tempo per queste cose…
Si può ricavare. Andare in montagna in modo diverso si può. Bisogna avere la volontà e la capacità empatica di porsi in ascolto. Se non lo si capisce, vuol dire che non si è capaci neanche di ascoltare le persone intorno a sé. Se si è frenetici in montagna, lo si è anche nei confronti delle altre persone. Cambiare farebbe bene a tutti, non solo a chi cammina, ma anche a chi in montagna ci vive e si trova ad avere a che fare con persone che spesso arrivano come corpi estranei. Proviamo invece a staccare i telefonini, rimanere con la nostra voce, con i suoni della natura.
Nel suo libro, lei parla di frenesia anche per chi frequenta la montagna cercando la cima a tutti i costi, inseguendo la performance…
Io non ho mai la vetta come meta. Credo, tra l’altro, che ormai la visione competitiva, frenetica, dell’alpinismo abbia fatto il suo tempo. Chi sale e scende guardando l’orologio, controllando l’altimetria, i tempi, non fa altro che trasferire nelle terre alte gli stessi paradigmi e stili di vita della città. Invece la montagna dovrebbe rappresentare un luogo dove ritrovi te stesso. Passo dopo passo, camminando, ascolti le domande che hai dentro. Un respiro. Una voce. Il richiamo della montagna, appunto. Da due anni e mezzo, sono presidente della sezione del Club alpino italiano di Livinallongo – Colle Santa Lucia. Sin dall’inizio, ho dato un indirizzo ben preciso, nella direzione della sostenibilità, senza rincorrere la performance a tutti i corsi, l’ascensione eroica… E infatti si stanno iscrivendo molti giovani, persone che condividono questo modo di stare in natura. Ho scoperto che c’è una grande comunità che aveva bisogno di intercettare quella sensibilità di cui scrivo, di trovarla scritta nero su bianco.
Lei dice le persone si avvicinano attirate da un modo sostenibile di vivere la montagna. Eppure nel discorso pubblico è un continuo proporre nuovi impianti di risalita, piste da sci, piste per e-bike, eliski, etc., senza parlare dello scempio della pista da bob per le Olimpiadi a Cortina 2026. Si dice che, se non si fa tutto questo, la montagna muore…
È una dissacrazione continua dell’alpe. Chi ha una visione diversa non ha voce in capitolo. Non si sente protetto. Non ha riferimenti né politici, né culturali che lo sostengano concretamente, e non solo a parole, o sui social. Ma si dice che fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. È pieno di persone, di ragazzi, che si rendono conto che non ha più senso fare piste da sci, caroselli, perché non c’è più neve. Si rendono conto che quelle che prevalgono solo logiche di un’economia cieca, insostenibile, che fa i propri interessi, dominata dall’ego, dalla brama di potere, e non porta nulla al bene comune. Costruire la nuova pista da bob è stata una scelta scellerata. Da un mese, le montagne franano sulla statale Alemagna e Cortina non si riesce a raggiungere per quella via. Ma si organizzano le Olimpiadi, un evento anacronistico, in un territorio fragile. E lo dico da sportivo, che ama guardare lo sport anche in tv.

Perché, nonostante il precedente della pista da bob di Cesana, costruita per Torino 2006 e abbandonata, nonostante le proteste e il parere del Comitato olimpico internazionale, a Cortina non si è fatto un passo indietro?
Personalmente, e anche come Cai, abbiamo fatto tutto il possibile. Ma le cose buone hanno bisogno di tempo, pazienza e persone che si dedichino. Un po’ alla volta, ci arriveremo. Un giorno si capirà che a queste montagne abbiamo tolto tutto e si dovrà restituire loro qualcosa. Iniziano a rendersene conto anche i montanari, compresi quelli che hanno tratto profitto dal turismo di massa. Adesso sono stufi delle moto sui passi, delle auto che fanno le corse sui passi dolomitici. E ci credo! C’è tanto rumore che se vai ad arrampicare in parete non senti il tuo compagno di cordata perché i motori lo sovrastano. Non è più sostenibile tutto questo.

Cosa ci vorrebbe secondo lei, per arrivare finalmente a una svolta?
Oggi, come società, non distinguiamo più i veri pericoli dalle paure inutili. Ci spaventano le piccole cose e non ci rendiamo conto della guerra, delle disuguaglianze sociali ed economiche nel mondo. Temiamo lo straniero, il vicino di casa, abbiamo paura se un figlio va a scuola da solo… Gli animali selvatici, come la volpe, il lupo, l’orso, non hanno paura di una nevicata o di farsi male nel bosco. Ma se sta arrivando una tempesta, o un terremoto, lo avvertono ore prima. Ecco, anche noi dovremmo ritrovare quell’istinto selvatico, per renderci conto dei veri pericoli.
Ne Il richiamo della montagna, dedica molto spazio alla tempesta Vaia e al crollo del ghiacciaio in Marmolada, sottolineando che si è parlato di tutto tranne che della ragione di quei disastri, il cambiamento climatico…
Non si affrontano mai le vere ragioni. La discussione è sugli effetti immediati. È la fotografia, l’attimo. Infatti io dico che siamo la società dei dieci secondi: non ci rendiamo conto che ci sono un passato e un futuro. Quel che di negativo facciamo oggi all’ambiente, provocherà danni magari tra un decennio. Vediamo solo il tutto subito, tutto adesso. E, quando gli effetti si verificano, dopo due giorni cambiamo argomento, senza analizzare le cause. Pensiamo al crollo della Marmolada: si è parlato del recupero dei feriti, dei morti, ma nessuno mai ha detto: forse è arrivato il momento di discutere del riscaldamento globale. Eppure è stata colpita una montagna simbolo, un ghiacciaio perenne. Eppure, nonostante tutto, credo che, un po’ alla volta, arriveremo ad affrontare i problemi. Io vedo un’onda verde che sta crescendo.
Però a livello globale i discorsi che dominano adesso vanno in tutt’altra direzione…
Un tempo c’erano i negazionisti. Adesso si dice che il riscaldamento globale esiste ma prima di tutto viene l’economia. Ma allora, se ragioniamo di schei, una frana che dall’Antelao scende sull’Alemagna e blocca il traffico che va a Cortina, quanto costa? Perdere milioni di ettari di bosco, milioni di metri cubi di legname per Vaia e per il bostrico, quanto costa? L’alluvione dell’Emilia Romagna, quanto costa? Quantifichiamolo in denaro pubblico: quanto costa? Parliamone, è economia, questa.
Perché critica anche gli ambientalisti, che da sempre chiedono di agire per fermare il riscaldamento globale: cosa dovrebbero fare?
Trovo che l’errore di fondo sia l’atteggiamento paternalistico di voler difendere il futuro dei nostri figli, di voler contrastare l’estinzione di massa. Invece io desidero salvare la terra, la bellezza, la montagna. Non è vero che lei ti salva, siamo noi che dobbiamo agire per difenderla, e allora forse avremo la speranza di salvare anche noi stessi. Vale anche nei confronti degli altri, delle persone più fragili, più deboli. Poi è vero il pianeta rimarrà anche senza di noi. Ma la spinta deve venire dall’amore per la terra. Io amo i larici, gli abeti, i fiori, le rondini che fanno migliaia di chilometri per tornare nello stesso nido. Amo tutto questo, perché è romantico, poetico. Dobbiamo ritrovare la poesia. Questo dico agli ambientalisti: sono troppo schiacciati su temi scientifici. La bellezza va salvata perché ha un valore inestimabile. Nei miei testi uso un linguaggio umanistico, filosofico, non scientifico. Siamo pieni di scienziati che parlano dei dati del clima… Io ho bisogno di una luce nuova dentro di me. Se non capisco che il larice che sto guardando è uno specchio della mia esistenza, non mi importerà di fare qualcosa per lui. Ed è così anche per i bambini di Gaza, per chi attraversa il Mediterraneo, o per i messicani che vengono deportati da Trump. Noi dobbiamo riconoscerci nell’altro, in chiave poetica, filosofica.
Se non capisco che il larice che sto guardando è uno specchio della mia esistenza, non mi importerà di fare qualcosa per lui. Ed è così anche per i bambini di Gaza, per chi attraversa il Mediterraneo, o per i messicani che vengono deportati da Trump.
Matteo Righetto, scrittore
Come nasce questa sensibilità?
È qualcosa che ho sempre avuto, ho sempre sentito questo richiamo della natura. Da bambino, stavo bene nel bosco, ne percepivo la sacralità. A tredici anni ero già iscritto alla Lipu, ed era una mia iniziativa, non c’entravano i miei genitori. Stamattina, con le mie figlie, abbiamo passeggiato tra grandi alberi meravigliosi e dicevo loro: «Ragazze, pensate quante cose hanno visto, quanti animali hanno incontrato, le epoche che hanno attraversato, le generazioni di montanari e boscaioli che hanno conosciuto. Quante cose sanno e non possono dircelo». Tutto questo per me è magico.
E chi vive in città, come fa a riconnettersi con la dimensione naturale? Come si può superare la contrapposizione tra wilderness e spazio urbano, cementificato?
Non c’è bisogno di grandi spazi. Il miracolo della natura si può scoprire anche in un prato, nel volo di un’ape, percorrendo un argine. La netta separazione tra città, con periferie periurbane invivibili, cementificate in maniera antiestetica, e gli spazi naturali porta a quella ricerca spasmodica di cui abbiamo parlato. Ma ecologia vuol dire equilibrio, convivenza, coevoluzione. Dobbiamo pianificare spazi urbani più vivibili, perché le persone stiano meglio in città, con più parchi, più corridoi ecologici, più biciclette, meno traffico e meno pericoli. E allo stesso tempo la montagna va pianificata in modo più sano. Sono due facce della stessa medaglia. Anche nelle città si possono spegnere le luci, per rivedere le stelle. Sono cose che fanno stare meglio, con gli altri e con se stessi. Non occorre scalare le montagne, per sentire il richiamo della natura.
Leggi anche le interviste a:
– Marco Morganti (Assobenefit)
Rivoluzionerò le società benefit, perché un giorno un giudice Antimafia mi spiego: “Funzionano solo i patti tra buoni”;
– Francesco Billari (Bocconi): La Bocconi non torna indietro sulla diversità che è ricchezza. Lo sapeva già la mia Inter nel 1908;
– Eric Ezechieli (Nativa): Lo sviluppo sostenibile non basta più. Le aziende devono rigenerare.
– Filippo Bettini (Global Compact): Aiutare la transizione si può: premiando i consumatori che sceglieranno prodotti sostenbili certificati.
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.

