Qual’è l’unità di misura che consente di stabilire se un affare è buono oppure no? Che cosa significa davvero la parola “profitto”? E soprattutto, come si calcola il valore di un progetto che in uno spazio vuoto può generare bene comune? Ruota attorno a queste tre domande, e al tipo di risposta che un ente pubblico può dare, la sperimentazione messa in campo, nell’ambito di Torino Social Impact, da Città di Torino, Camera di commercio e Fondazione Compagnia di San Paolo e Centro valutazione impatto (CeVIS) per dare contenuto a luoghi che abbiano perso la vocazione originaria o in attesa di nuove definizioni. Attenzione: non un contenuto qualsiasi, qui il carattere è sociale.
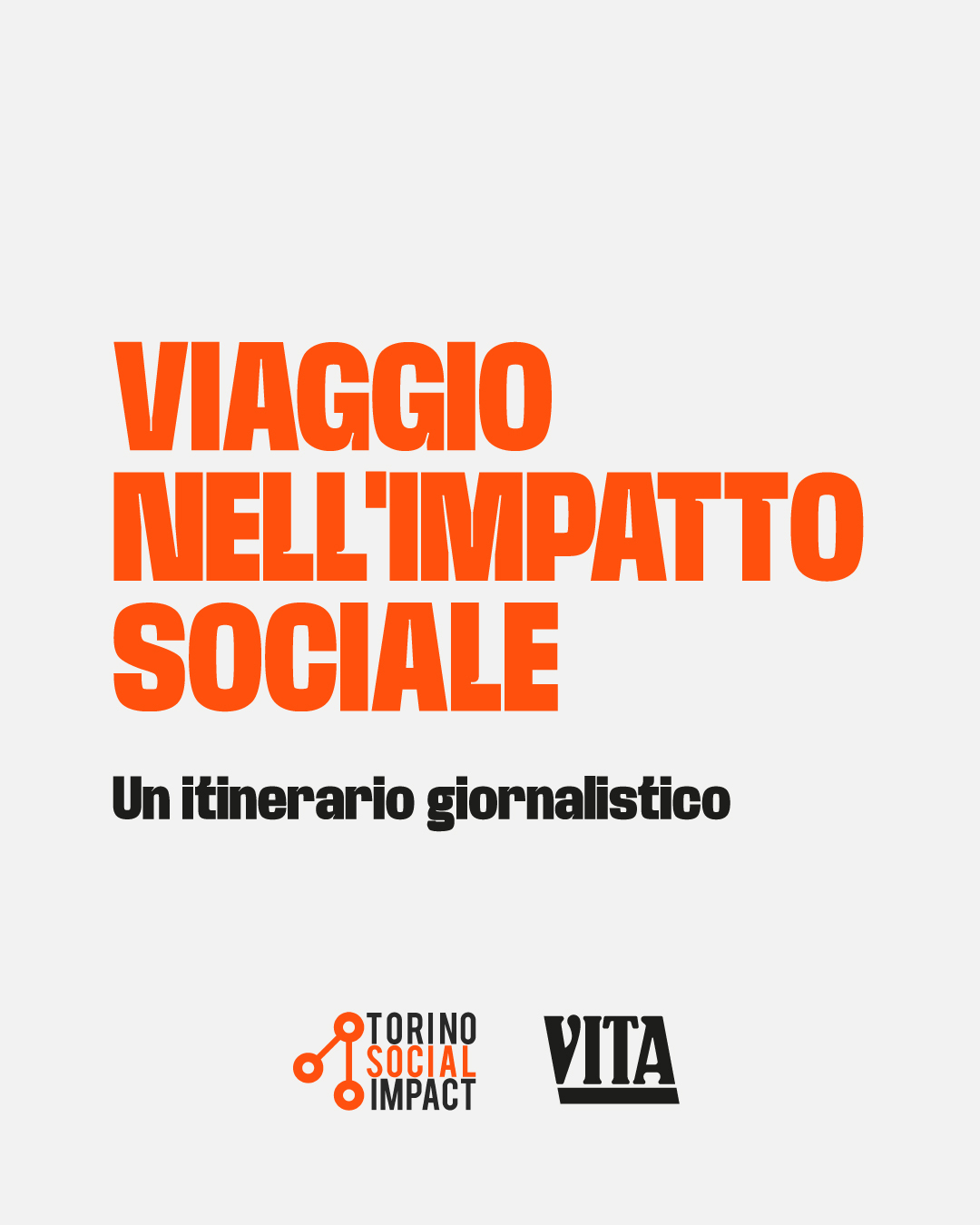
Predisporre un modello di misurazione di impatto per valorizzare il patrimonio immobiliare e riqualificare la città. È questo l’obiettivo di un’intuizione innovativa che, una volta strutturata, potrebbe svoltare la destinazione d’uso di innumerevoli gusci vuoti. «Oggi più che mai, il patrimonio immobiliare pubblico rappresenta una grande risorsa per la città, non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto come leva per generare valore sociale», spiega la vicesindaca di Torino Michela Favaro. «Abbiamo scelto di sperimentare un approccio innovativo alla valorizzazione immobiliare attraverso lo strumento dell’impatto sociale per puntare a progetti che rispondano alle esigenze reali dei cittadini, generando benefici concreti sul territorio. Il protocollo siglato nel 2022 rappresenta una tappa fondamentale per integrare le dimensioni economiche, ambientali e sociali nei processi di valorizzazione del patrimonio pubblico». L’obiettivo, per la città, è duplice: «migliorare la gestione del proprio patrimonio attraverso strumenti tecnico-estimativi evoluti e riconoscere il valore sociale prodotto dalle operazioni di riqualificazione urbana».
Si può monetizzare il ritorno sociale?
Sono due gli assessorati della Città di Torino coinvolti in un lavoro di ricerca che tutti gli attori definiscono «rivoluzionario»: Patrimonio, in capo alla vicesindaca Michela Favaro, e Urbanistica, affidato a Paolo Mazzoleni. «Il progetto nasce da un’esigenza molto pratica legata alla alienazione e concessione di proprietà pubbliche», spiega quest’ultimo. «Stiamo costruendo uno strumento dal potenziale enorme, non soltanto per Torino ma per una molteplicità di contesti».

Il punto di partenza è la convinzione che, in certi casi, il solo dato economico tenda a sottovalutare gli altri aspetti della vita di una comunità. «Nei bandi di assegnazione e alienazione, inevitabilmente il riconoscimento del valore economico dei beni è protagonista. Ma l’ente pubblico deve essere in grado anche di leggere e misurare l’impatto che le decisioni hanno sui cittadini. Non è semplice. Di fronte a un’offerta economicamente superiore, è molto difficile argomentare che un’altra è migliore dal punto di vista del bene comune. La storia recente ci racconta di tanti casi in cui adottare la lente del maggior guadagno ha portato a esiti divergenti dagli obiettivi iniziali». E qui si presenta il nodo della questione, continua l’assessore: «Come faccio a dare una base razionale, oggettiva e condivisibile a valutazioni che hanno a che fare con il tessuto sociale di un quartiere, una piazza, una strada?».
È a questo punto che entra in gioco l’ecosistema di Torino Social Impact, il marchio collettivo che unisce attori pubblici e privati, profit e non profit per l’imprenditorialità e gli investimenti a impatto. «Dal confronto con l’ecosistema, e dalla collaborazione con Camera di Commercio, Fondazione Compagnia di San Paolo e CeVIS, è nato un complesso lavoro per provare a dare solidità a questo tipo di misurazioni. Una conversione in euro del ritorno sociale generato da una progettualità».
Una novità assoluta
«Si tratta di una novità assoluta a livello nazionale che ha già influenzato lo sguardo dell’ente su queste tematiche», aggiunge Mazzoleni. «Quando si attivano processi di questo tipo, si costruisce una cultura che ha dei risvolti rivoluzionari: può impattare su tantissimi ambiti, a partire dalla pianificazione. Stiamo lavorando al nuovo piano regolatore e mi piacerebbe che possa tenere conto di una dimensione di impatto sociale almeno nel framework. Ci sono trasformazioni urbanistiche che hanno un impatto radicalmente migliore sul territorio: poter discriminare in maniera fondata e condivisibile sarebbe una grande opportunità».

Sono due i casi pilota che hanno guidato la sperimentazione. «Il primo riguarda la ex sede della storica fabbrica Superga, un complesso industriale dismesso in via Verolengo 28. Inserito nel programma di riqualificazione urbana “Superga” con destinazione a servizi pubblici, versa da anni in stato di abbandono», ricostruisce la vicesindaca. «Tra il 2018 e il 2023 è stato oggetto di sei gare pubbliche di vendita andate deserte. La modalità di valutazione in questo caso è stata ex ante, basata sulla proposta presentata dall’impresa sociale Prs (Paratissima) nell’ambito di una procedura di partenariato speciale pubblico-privato». Il secondo edificio messo sotto la lente di ingrandimento è Casa Ugi in corso Unità d’Italia 70, residenza collettiva in uso dal 2003 all’associazione omonima che ospita gratuitamente le famiglie di bambini in terapia presso il Centro di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita: «La valutazione qui è stata ex post, a partire dalle attività effettivamente realizzate, documentate con report di sostenibilità e calcolo del Social return on investment».
Abbiamo tradotto l’impatto in una moneta in grado di ridurre il costo che un soggetto dovrebbe sostenere per prendere in gestione o acquistare un bene pubblico
Marella Caramazza, direzione strategica del CeVIS
L’ambizione è che questa metodologia diventi uno standard applicabile anche in altri contesti urbani italiani, «un sistema trasparente, rigoroso e compatibile con i principi della finanza pubblica, integrando il modello di impatto sociale nelle procedure amministrative esistenti», conclude Favaro.
Per valorizzare un immobile bisogna farne un buon uso
«La vera originalità non sta solo nell’avere costruito un modello di valutazione dell’impatto che permetta la comparazione trasparente e oggettiva di più progetti candidati a utilizzare lo stesso bene. La vera originalità consiste anche e soprattutto nel correlare il valore dell’impatto a un valore economico sotto forma di sconto del prezzo di concessione». Marella Caramazza, direzione strategica del CeVIS, il Centro di competenze per la valutazione dell’impatto creato da Torino Social Impact di Camera di commercio di Torino e da Fondazione Cottino e gestito dal Cottino Social Impact Campus, entra nei dettagli di un meccanismo scientificamente robusto, in grado di mettere in luce il buon uso di un immobile: «Un algoritmo matematico che, in base al valore sociale creato, permette di assegnare a un progetto uno sconto da 0 al 90%. Abbiamo tradotto l’impatto in una moneta da utilizzare come contraccambio di una parte del costo che un soggetto dovrebbe sostenere per prendere in gestione o acquistare un bene di proprietà pubblica».

Il metodo, continua Caramazza, è soltanto una parte di un protocollo metodologico più ampio che si pone una serie di obiettivi di impatto coerenti con il piano strategico della città: «Attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto stakeholder del territorio e funzionari di diversi dipartimenti della Città di Torino, abbiamo individuato i criteri, i pesi e i meccanismi che devono essere adattati ai singoli beni e ai bisogni del territorio sulla base dei quali stipulare contratti outcome based, ovvero che riconoscano dei privilegi al progetto man mano che si vengano a manifestare gli effetti positivi». Il focus infatti non è sullo spazio rigenerato, ma proprio sul progetto. «Per questo il presupposto da cui partiamo è la volontà di creare un impatto addizionale, intenzionale e soprattutto misurabile»».
Questo articolo fa parte di una serie intitolata Viaggio nell’impatto sociale. Leggi anche:
Senza un’idea di giustizia sociale non c’è impatto
Alla ricerca dell’impatto perduto: la lezione di una crisi industriale
Il turismo sostenibile è la prossima destinazione
È l’impatto, bellezza. Il giornalismo che cerca la speranza
Social procurement, la filiera responsabile è un lavoro di squadra tra profit e non profit
In apertura la ex sede della storica fabbrica Superga a Torino (Fotografia fornita dalla Città di Torino)
Si può usare la Carta docente per abbonarsi a VITA?
Certo che sì! Basta emettere un buono sulla piattaforma del ministero del valore dell’abbonamento che si intende acquistare (1 anno carta + digital a 80€ o 1 anno digital a 60€) e inviarci il codice del buono a abbonamenti@vita.it



