Il libro
L’oceanografo Carniel: «Il Mediterraneo è anche le persone e i conflitti che lo attraversano»
Tra avventura e divulgazione scientifica, "Rotte mediterranee" esplora le sponde e gli abissi del Mare nostrum, con le sue (troppo rapide) trasformazioni. «Per coinvolgere il lettore, narro le storie delle persone, una dimensione umana che di solito manca nella comunicazione scientifica», dice l'autore, dirigente di ricerca al Cnr e divulgatore. La comprensione dei problemi sul campo, nel quotidiano di chi li vive, è un elemento chiave per affrontare il cambiamento climatico

«È il racconto di un viaggio, reale e a tratti immaginario, attorno a un mare che cambia troppo velocemente», così Sandro Carniel, oceanografo e divulgatore scientifico, descrive il suo libro Rotte mediterranee, appena uscito per Ediciclo editore. «Potrebbe essere una guida per visitare luoghi preziosi, fragili e minacciati, ma ancora vivi e affascinanti, per conoscere le storie delle persone e capire meglio le dinamiche del riscaldamento globale». L’autore, dirigente di ricerca all’Istituto di Scienze polari del Cnr, si muove tra narrazione e informazioni scientifiche, leggerezza e nostalgia, disillusione e speranza. E il lettore, dalla prima all’ultima pagina, lo segue. Si imbarca per un’incredibile avventura dalla Croazia alla Sardegna, dalla Spagna all’Egitto, tra innalzamento del livello del mare, plastiche e microplastiche, overfishing e whale watching, turismo e diseguaglianze.
Sandro Carniel, di tutti gli ambienti, il mare è forse quello che percepiamo come più lontano. È difficile far comprendere i problemi che riguardano un mondo che non si vede…
Il mare è una realtà estremamente vasta e distante, invisibile in alcuni suoi cambiamenti. Non è facile afferrarlo con le parole. Ho cercato di farlo raccontando le storie delle persone che sono testimoni delle sue trasformazioni. Questa dimensione umana solitamente manca nella comunicazione scientifica. Io credo invece possa aiutare a instaurare una sorta di confidenza con il lettore, attraverso la conoscenza dal basso. Nel libro c’è anche, in modo diluito e accessibile, la scienza dall’alto verso il basso. Ma sono le storie umane a renderla comprensibile, coinvolgente, umanizzata. Per risolvere la crisi climatica le due dimensioni sono entrambe necessarie: abbiamo bisogno dell’approccio dall’alto, ma anche di valorizzare la comprensione sviluppata dal basso, sul campo.

Le sue ricerche riguardano la circolazione oceanica, qualcosa di ancora più invisibile eppure fondamentale per l’equilibrio del pianeta.
Mi occupo di come le acque se ne vanno in giro per il mondo, come rispondono ai cambiamenti climatici e come, facendo questo, interagiscono con le onde, l’atmosfera, i sedimenti. Questo tipo di studi mi dà la possibilità di toccare tanti temi diversi. Passo dalla fisica dell’acqua alla geologia, alla chimica, quando per esempio considero lo scambio con i gas dell’atmosfera. E ancora, i miei studi hanno a che fare con la biologia, influenzata anch’essa dal movimento delle acque, che porta i nutrienti e l’ossigeno negli abissi. Studiare le correnti marine è un modo per mettersi a cavallo di quello che è il trasportatore per eccellenza di calore, umidità, gas, nutrienti in tutto il pianeta. Nel mio libro, considero il Mediterraneo come un piccolo oceano. Infatti ha le stesse dinamiche, più in piccolo e, ahimè, più accelerate per quanto riguarda i problemi degli oceani vasti.
Per risolvere la crisi climatica, accanto alla scienza, va considerato il punto di vista di chi è testimone diretto delle trasformazioni ambientali, dai pescatori ai ricercatori.
Sandro Carniel, oceanografo
In un capitolo di Rotte mediterranee, narra di una spedizione di ricerca nel golfo del Leone, in Spagna. È andata proprio così, avete davvero fatto una scoperta?
Si fa ricerca in mare quando si cercano conferme, o per formulare ipotesi. Trovare cose nuove è sempre una gioia. Quel giorno abbiamo fatto un passo avanti nella comprensione delle dinamiche delle acque profonde, che muovendosi sono alla base della circolazione del Mediterraneo. Parliamo di “motori freddi”, che si trovano in tre soli punti: nel golfo del Leone, appunto, nell’alto Adriatico e nell’Egeo. Sono aree in cui le acque diventano fredde e dense, precipitano verso il fondo e, così facendo, innescano una circolazione in tutto il Mediterraneo. Scendendo, trascinano giù con sé ossigeno e nutrienti, e garantiscono la vitalità della biodiversità sottomarina. Ma riescono a sprofondare solo se diventano abbastanza dense e pesanti. Un mare sempre più caldo, sviluppa sempre meno acque dense e correnti verticali, e sempre più riduce la ricchezza di vita in profondità. È come se il bacino si stesse impigrendo nella sua circolazione. Al tempo stesso, alimenta ondate di calore ed eventi estremi che non riusciamo a gestire: venti forti, cicloni, precipitazioni intense. Giugno 2025 è stato il più caldo in assoluto, per quanto riguarda le temperature registrate sulla superficie (intesa per parecchie decine di metri). Nel libro racconto come i fenomeni che chiamiamo “cascate di acqua densa” continuino ad avvenire ma, ahimè, sempre meno frequentemente, in un mare sempre più caldo.
Non solo scienza: lei si sofferma «nella parte del Mediterraneo meno seguita dai media, meno esposta ai servizi dei telegiornali, in una sponda così vicina a noi eppure così lontana», scrive. In Egitto, per esempio, si va a cercare un posto da cartolina, dove rilassarsi e dimenticare la propria vita frenetica, senza voler pensare ai problemi di quel paese. Come trovare un compromesso, visto che il turismo è economia?
Sulla sponda sud, fino a qualche anno fa, la biodiversità dei fondali era molto più ricca. Lungo la costa egiziana, ho voluto parlare di vita animale e vegetale, ma anche di geopolitica, di equilibri fragili, di risorse contese, degli effetti del canale di Suez. Ho introdotto il tema del legame tra giustizia ambientale e sociale. Capire il Mediterraneo significa anche capire le persone e i conflitti che lo attraversano. Uno di questi è legato al turismo, aggressivo, di chi vuole la vacanza a basso costo, con tutte le comodità e non si confronta con la vita delle persone e con la situazione del paese. È questo che ti rende cieco sugli effetti del tuo soggiorno. Credo che un turismo che porti economia senza depredare sia possibile, se siamo più consapevoli, se cerchiamo di essere più legati ai luoghi e alle comunità. Alcuni dettagli possono rendere la vacanza più consapevole, non necessariamente più cara, e se anche lo fosse, se legata alla consapevolezza che quella risorsa deve essere conservata meglio, è un costo che siamo disposti a pagare. Il punto è voler vedere i problemi. In un mondo globalizzato, prima o poi, anche se chiudi gli occhi, i problemi arrivano. Sarebbe più saggio affrontarli prima e non farli crescere tanto da non riuscire più a gestirli.
Il viaggio termina sull’Adriatico, dove ormai pochissimi ricordano com’erano le spiagge, prima del turismo di massa. Oggi quella conoscenza servirebbe per adattarsi al mare che sale. Come recuperarla?
Le spiagge dell’alto Adriatico sono state trasformate in distese piatte e uniformi, con sabbia setosa per accarezzare i piedi e una pendenza che prevede la rimozione delle dune e della vegetazione. In pochi decenni abbiamo cancellato un ecosistema e la memoria dei luoghi. Non è stato stravolto solo l’aspetto fisico, dell’equilibrio tra sabbia, vento, acqua, che rendeva le coste meno erodibili e più stabili. Abbiamo cancellato anche la cultura. Ma, prima o poi, l’ambiente marino chiede indietro ciò che ha perso. E così arriva la mareggiata e cerca di ricostruire quello che dovrebbe essere un sistema in equilibrio, formando una duna. Ma noi, verso marzo, aprile, rispianiamo tutto. Nel libro cerco di ricordare com’era un tempo, perché ci potrebbe consentire di vivere in un mondo diverso, godendo di quel turismo che vogliamo, con soluzioni che si alleino con la natura per proteggere meglio le coste.
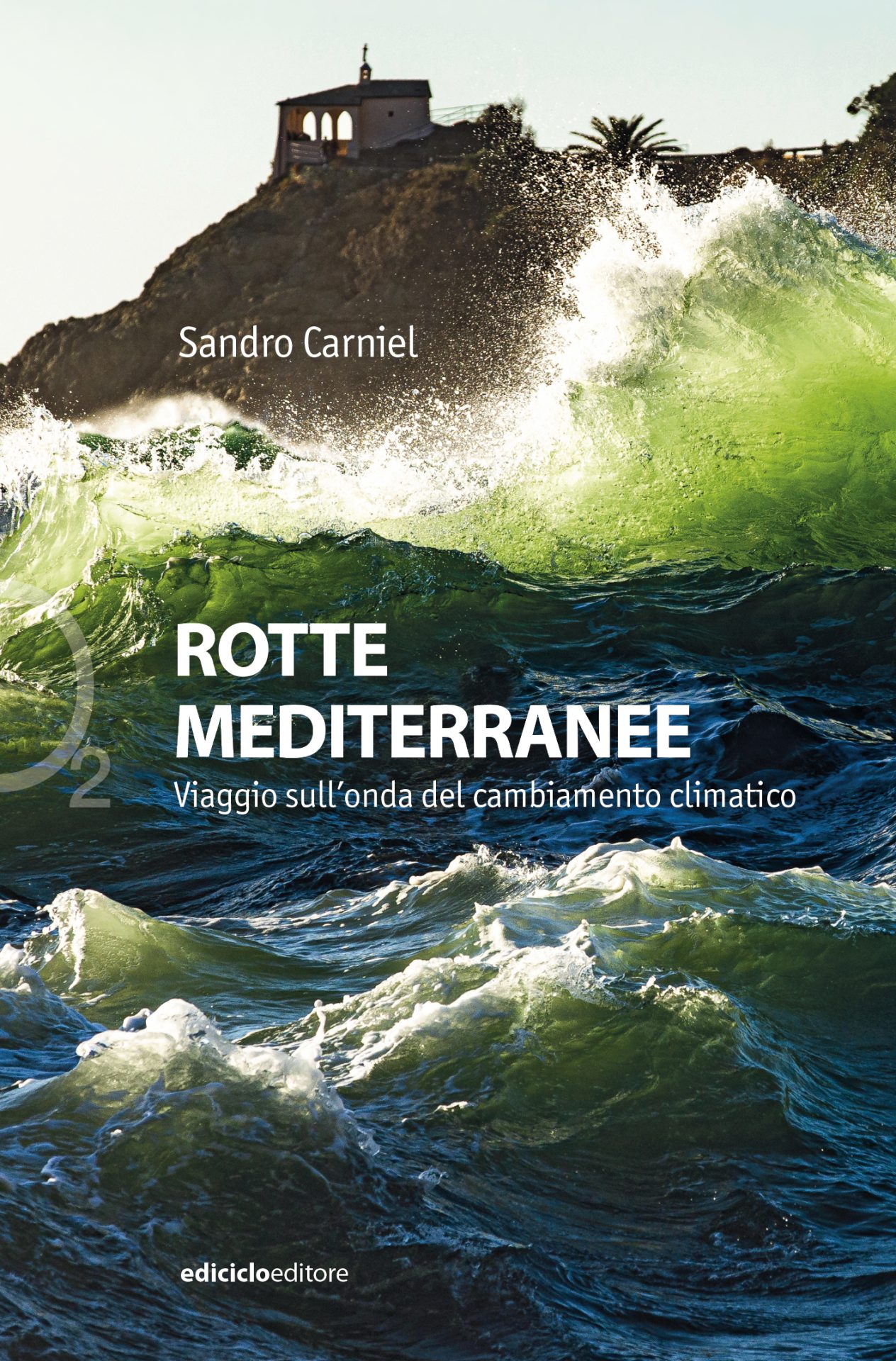
Da diversi anni, ormai, come divulgatore scientifico, cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ambientali legati al mare e al riscaldamento globale. Com’è cambiato il suo punto di vista?
C’è una nota di disillusione in questo mio libro, per il confronto tra sforzi profusi e risultati ottenuti. È migliorata la comprensione degli oceani e l’inquadramento della crisi climatica, ma non basta a determinare un cambiamento di rotta chiaro e deciso. La speranza però rimane, ed è concreta. Potremmo ancora incidere molto, anche se ormai è chiaro che i costi sono inevitabili. È come se stessimo giocando una partita di calcio: siamo sotto due a zero e mancano venti minuti alla fine. Abbiamo capito molto di come si gioca questa partita, sapremmo cosa fare, ma non abbiamo ancora deciso di farlo. Sarebbe il caso di muoverci, perché un’altra squadra non continuerà la partita al posto nostro. A questo si aggiunge la fase delicata che stiamo vivendo. La ricerca avrebbe necessità di fondi svincolati da risultati applicativi, per poter esplorare nuovi settori in modo neutro. Ma si confronta con il mondo economico produttivo, che richiede quasi sempre applicazioni veloci, di fronte a un problema di cui non si è capito benissimo tutto. La spinta, oggi, è verso il fare prima di capire. La necessità di confrontarsi con le logiche dei finanziamenti non va rifuggita, ma non può essere l’unica stella polare. A questo si lega il concetto di comunicazione della realtà, che incide sia nella speranza, sia nella decisione politica di finanziare un tipo di ricerca o un altro.
In apertura, Marsa Matrouh (Egitto) foto di Youhana Nassif su Unsplash
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
