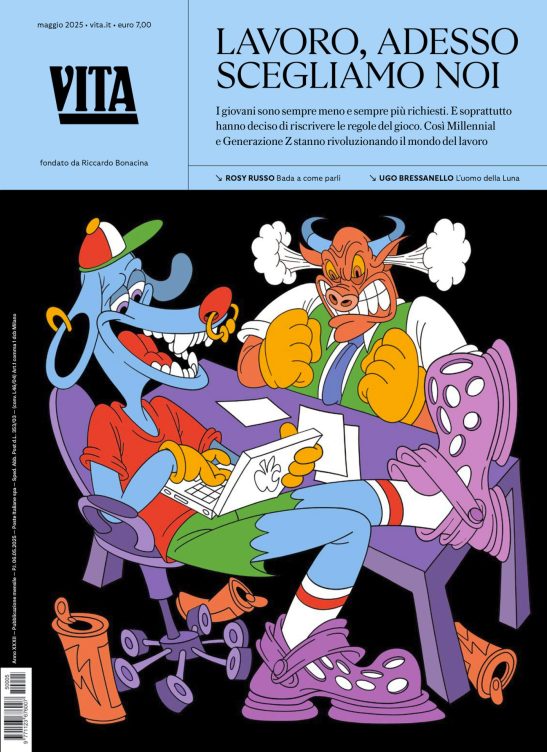Leggi e famiglia
Quell’aritmetica dei pernotti che non serve ai figli di genitori separati
A quasi vent'anni dalla legge sull'affido congiunto, il ddl 832 - già ribattezzato "ddl Salomone" - fa coincidere la bigenitorialità con il diritto dei genitori ad avere il 50% del tempo dei figli. «È un salto concettuale che porta alla spartizione dei bambini e dei ragazzi secondo una logica quantitativa», afferma Paola Cavatorta, psichiatra e psicoterapeuta, responsabile del consultorio familiare dell'Università Cattolica, sede di Roma

Il dibattito suscitato nel Paese dal disegno di legge n. 832, dimostra che l’affidamento dei figli in caso di separazione dei genitori è un tema che coinvolge e riguarda tutti, non solo i diretti interessati e gli addetti ai lavori. Quali scelte si fanno per i figli nella separazione, come si rispettano i loro diritti, come si tutela il benessere di bambini e ragazzi nelle riorganizzazioni familiari è infatti espressione della nostra sensibilità sociale.
Sono passati quasi vent’anni dalla legge n. 54 che ha cercato di regolare la vita dei figli di genitori separati affermando il loro diritto alla bigenitorialità, ossia a mantenere la relazione con entrambi i genitori in un regime di affido condiviso che prevede la cooperazione dei genitori. Questi principi fondamentali hanno faticato ad affermarsi e a tutt’oggi non sono pienamente garantiti, soprattutto quando le necessità degli adulti prevalgono sui bisogni affettivi dei minori. Continuare ad amare entrambi i genitori e a sentirsi amati e protetti da entrambi può smettere di essere una certezza se, per esempio, mamma e papà non riescono a dialogare, discutono per ogni decisione (“non sono andato in gita perché non si sono messi d’accordo”) o persino interrompono le comunicazioni (“non si dicono nemmeno ciao”).
La separazione dal punto di vista dei figli
Guardando la separazione dal punto di vista dei figli capiamo che per la maggior parte di loro è un evento doloroso, che mette in crisi le sicurezze, modifica le abitudini di vita, richiede tempo per essere rielaborato. Inoltre, richiede agli adulti di avere attenzione per l’unicità di ogni situazione, di cercare soluzioni “su misura” per tradurre i principi in scelte adeguate alle diverse realtà familiari, in particolare per quanto riguarda la frequentazione, vale a dire la modulazione della quotidianità. Vanno in questa direzione gli sforzi di molti genitori, dei professionisti e dei magistrati chiamati a dirimere i casi più complessi.

Una logica quantitativa
Tuttavia, nella duttilità applicativa della legge vigente si sono presentate molte contraddizioni tra gli orientamenti dei tribunali e i dispositivi dei giudici, alle quali contribuiscono anche i pareri discordanti degli esperti e i servizi per la famiglia oberati. Il diffondersi della conflittualità separativa – ben diversa dalle situazioni di violenza che richiedono azioni specifiche a tutela di chi la subisce – è da tempo oggetto di studi, di confronti tra operatori del settore giuridico sanitario e sociale, di elaborazione di modelli per prevenire e intervenire.
Nel ddl 832 si fa coincidere la bigenitorialità con la suddivisione paritaria dei tempi di frequentazione, passando dal diritto dei figli ad avere un rapporto con entrambi i genitori a quello dei genitori ad avere il 50% del tempo dei figli. È un salto concettuale che porta alla spartizione dei bambini e dei ragazzi secondo una logica quantitativa
Paola Cavatorta
Le proposte di cambiamento in materia di affido dei figli del ddl n. 832 si inseriscono in una discussione molto attiva, con l’intenzione dichiarata di riaffermare i diritti della prole.

In realtà, nella premessa del ddl si fa coincidere la bigenitorialità con la suddivisione paritaria dei tempi di frequentazione, passando dal primato del diritto dei figli al rapporto con entrambi i genitori a quello dei genitori ad avere il 50% del tempo dei figli. Si tratta di un salto concettuale che porta alla spartizione dei bambini e dei ragazzi secondo una logica quantitativa, non mitigata dall’obiettivo di correggere tanti sbilanciamenti ingiustificati che penalizzano per lo più la relazione dei figli con i padri.
Una non risposta al tema (vero) della conflittualità crescente
L’affidamento condiviso comporta uguali responsabilità e partecipazione alla cura dei figli, che non si traducono tout court nella frequentazione paritaria con il figlio. La normativa in vigore spinge a cercare la migliore organizzazione possibile nel rispetto del child best interests e della realtà di vita dei genitori, mentre il cambiamento proposto nel ddl n. 832 prevede come regola la divisione a metà della frequentazione. Una soluzione che sembra rivolta alle separazioni impantanate nel braccio di ferro tra genitori (troppe!), nell’ipotesi che sia possibile tacitare la disfunzionalità sottostante il mortificante mercato di giorni e ore da passare con l’uno o l’altro genitore.
La divisione a metà della frequentazione sembra rivolta alle separazioni impantanate nel braccio di ferro tra genitori (troppe!), nell’ipotesi che sia possibile tacitare la disfunzionalità sottostante il mortificante mercato di giorni e ore da passare con l’uno o l’altro genitore
L’idea che sia nell’interesse dei figli dividere esattamente a metà la loro vita richiama il passo biblico nel quale re Salomone, dovendo decidere l’assegnazione di un neonato reclamato da due madri, dispone che il bambino sia tagliato a metà e che ciascuna abbia mezzo figlio. La giustizia si compie perché Salomone la ottiene grazie alla rinuncia del neonato, purché resti in vita, da parte della vera madre. È un monito antico a non avallare la visione di un bambino divisibile e da dividere, che trova una drammatica corrispondenza con i vissuti dei figli esposti a conflitti genitoriali accesi e prolungati: “mi sento tirato da due parti e ho paura di spezzarmi a metà”, “il mio cervello è tagliato a metà”.
Parità di minutaggio vs integrazione degli affetti
Il bisogno affettivo dei figli è far coesistere l’amore per la mamma e l’amore per il papà, in un’integrazione che non scaturisce dalla parità del minutaggio stabilita dall’arbitro istituzionale. Scelte genitoriali che donano vita anziché arrecare morte sono quelle che modellano la riorganizzazione post separazione.
Il bisogno affettivo dei figli è far coesistere l’amore per la mamma e l’amore per il papà, in un’integrazione che non scaturisce dalla parità del minutaggio stabilita dall’arbitro istituzionale
Ad esempio, nella separazione di due giovani genitori, ambedue infermieri ospedalieri e turnisti che si sono sempre alternati nella cura dei figli, la suddivisione paritaria della frequentazione è in linea con le abitudini di vita dei bambini anche se ancora molto piccoli. Ciò non cancella la sofferenza dei figli per la separazione dei genitori, né la fatica dello spostarsi tra due ambienti domestici, ma l’adattamento è facilitato dalle consuetudini esistenti con ciascun genitore. Diverso è il caso di un nucleo familiare dove i ruoli di padre e madre si declinano in modo complementare: il primo è impegnato molte ore fuori casa e la seconda si occupa in modo prevalente dell’accudimento dei figli. Nella loro separazione la frequentazione paritaria, se desiderata e possibile, può essere un punto di arrivo con gradualità legate all’età dei figli, alle risorse economiche, alla distanza delle abitazioni.
Altra situazione è quella dei figli adolescenti che sono in grado di riconoscere ed esprimere più chiaramente le loro esigenze: alcuni chiedono di spostarsi il meno possibile (dalla loro stanza, dagli amici, dal quartiere), altri desiderano poter passare lo stesso tempo con l’uno e con l’altro genitore, altri ancora manifestano il desiderio di cambiamenti in base a nuovi bisogni (come il desiderio di maggiore vicinanza con il genitore dello stesso sesso oppure l’ingresso in casa di nuovi partner dei genitori, non sempre graditi).
Uno spazio affettivo condiviso
È indispensabile coltivare un approccio flessibile, nel quale la responsabilità genitoriale si realizza innanzitutto nella capacità di rispettare e collaborare con l’altro genitore, condizione che crea uno spazio affettivo condiviso nel quale i figli possono sentirsi visti e considerati da entrambi.
Ciò che parifica i genitori nella mente dei figli non è l’aritmetica dei pernotti, ma la loro capacità di abitare insieme la trama relazionale familiare
Ciò che parifica i genitori nella mente dei figli non è l’aritmetica dei pernotti, ma la loro capacità di abitare insieme la trama relazionale familiare. Per tutelare i diritti dei figli occorre diffondere la cultura della collaborazione genitoriale attraverso investimenti a sostegno della famiglia.
Molto si può fare e molto c’è da fare: favorire la partecipazione dei padri sin dalle prime fasi di vita dei figli con lo strumento del congedo di paternità, tutelare il lavoro delle donne che diventano madri, aumentare i nidi e investire nella scuola estendendo il tempo pieno alle medie e integrando nella frequenza scolastica la pratica sportiva e corsi di musica e altro, con beneficio formativo per i bambini e i ragazzi e facilitazione organizzativa per i genitori.
Viviamo un’epoca di grandi transizioni e la famiglia facilmente è il contesto dove si manifesta il disagio contemporaneo, rendendo i servizi per la famiglia interlocutori privilegiati per accogliere, orientare e trattare i problemi, per accompagnare i cambiamenti. Il loro potenziamento quantitativo e qualitativo può mettere a disposizione dei genitori e dei figli gli interventi più appropriati per ciascuna situazione.
Paola Cavatorta, psichiatra e psicoterapeuta, è responsabile del consultorio familiare dell’Università Cattolica, sede di Roma. Con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza l’anno scorso ha realizzato il volume “Perché proprio a me? La separazione vista dai bambini“, che raccoglie disegni e pensieri dei bambini che hanno partecipato ai Gruppi di Parola per figli di genitori separati. In apertura, foto di Raymond Petrik su Unsplash.
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.