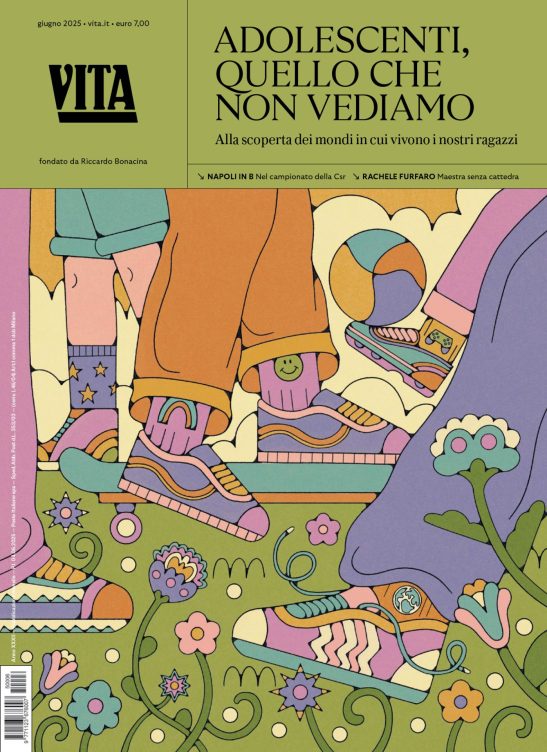In prima persona
Campi Flegrei, vivere sull’orlo del terremoto
La testimonianza di una giornalista che abita a Napoli. I racconti della vita quotidiana di chi vive oggi nella vasta area dei Campi Flegrei, tra la paura delle scosse e la resilienza di una comunità che si adatta e cerca di resistere

Da tre giorni, ho un borsone di fianco alla porta, con l’essenziale: cambi di vestiti, power bank, quaderno. Accanto, scarpe e chiavi. Sembra io stia aspettando che qualcuno venga a prendermi per una gita; in realtà, è tutto pronto, all’occorrenza, per un’uscita precipitosa. Dovrei chiamarla fuga, ma mi fa paura, apre ad altre domande: dove fuggo? Da cosa fuggo? La mia condizione e i miei interrogativi non sono né improvvisi né rari in questo momento: vivo in un quartiere di Napoli prospiciente ai Campi Flegrei di cui oggi tanto si parla perché colpiti da sciami sismici connessi al fenomeno del bradisismo. Essendo a una distanza di una decina di chilometri dall’area definita come zona d’intervento dalla Protezione Civile, le scosse più forti di questi ultimi giorni, come altre in precedenza, le ho avvertite chiaramente, anche se con minore intensità di chi, invece, vive a Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e in altre aree limitrofe alla caldera vulcanica. Non sono le prime, così come non è la prima volta che preparo il borsone, eppure ora qualcosa sembra diverso. Il mio fare è simile e per moltissimi versi più quieto e semplice di quello di moltissimi altri cittadini dell’area metropolitana di Napoli, soprattutto quelli che abitano il quadrante costiero a nord ovest (quante persone? Circa 500mila?).

Il respiro del vulcano
Il primo evento dello sciame sismico del 20 maggio mi ha sorpreso a cena: uno spostamento brusco sotto la sedia, come fossi a bordo di un treno su uno scambio di binari. Fatto intenso ma rapido, simile a quello del settembre 2023 sperimentato mentre guardavo il Tg regionale su Rai 3. Stavolta, venti minuti dopo, è arrivata la “scutuliata”: un altro scuotimento, sempre dal basso verso l’alto ma più forte e più lungo, accompagnato da grida dai balconi: «’O terramoto!». I sismografi registrano una magnitudo di 3.5 per il primo evento e 4.4 per il successivo, ve ne saranno altri durante la notte e la mattina dopo (qui le rilevazioni in tempo reale dell’Ingv), ma “terremoto” è un termine improprio. Questo è bradisismo, il “respiro del vulcano”, ovvero una lenta e costante deformazione del suolo che può avvenire con modalità e tempi diversi e può portare sia al graduale sollevamento che al graduale sprofondamento dell’area interessata. Per comprenderlo, bisogna approfondire cosa sono i Campi Flegrei.
Chi non vive a Napoli, potrebbe ricordare una dolcissima canzone di Eduardo Bennato o la stazione della metropolitana vicino allo stadio Maradona. In realtà, Campi Flegrei è molto più di un toponimo stradale. Dice l’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: “i Campi Flegrei sono un campo vulcanico attivo da più di 80mila anni la cui storia eruttiva è stata caratterizzata da almeno due eventi di grande magnitudo che hanno generato una caldera ampia circa 200 Km2”. Lo stesso ente chiarisce: “L’ultima eruzione, avvenuta nel 1538 (…) . A partire dalla seconda metà del XX secolo è iniziato un periodo di sollevamento che ha condotto a due crisi bradisismiche negli anni 1969-72 e 1982-84, quest’ultima caratterizzata da intensa sismicità”. Un po’ di storia recente permette di inquadrare meglio la situazione attuale: negli anni ’70, il suolo iniziò a sollevarsi, causando lesioni agli edifici e lieve attività sismica, e fu evacuato il Rione Terra, soggetto a continui abbandoni e ripopolamenti. Nel novembre 1980, il terremoto dell’Irpinia colpisce una vasta porzione della Basilicata e della Campania rompendo in successione tre segmenti di faglia adiacenti e squassando ben 8 province: principalmente quelle di Avellino, Salerno e Potenza, ma anche c’è anche Matera, Benevento, Caserta e, per l’appunto, Napoli dove il terremoto è definito “freddo”. Quando nel 1982 il bradisismo riprende a farsi sentire, molti edifici dell’area dei Campi Flegrei presentano già danni non ancora riparati e devono vedersela con nuova lunga serie di sollecitazioni sempre più intense, in sciami da 229 eventi in poche ore. Imprese e scuole si fermano, abitanti e commercianti protestano. Una donna, colta da malore dopo l’ennesima scossa, muore. Ci sono feriti tra calcinacci caduti e calca. Infine, nell’ottobre ’83, l’avviso dell’allora sindaco di Pozzuoli: circa 3000 famiglie saranno evacuate. Vengono offerte alcune sistemazioni, c’è un contributo di 350mila lire mensili (circa 500 euro attuali) per coloro che si sistemano da soli. Le scosse vanno avanti per tutto il 1984 per poi diminuire e scemare drasticamente fino a cessare del tutto nel 1985.
Campi Flegrei, il corpo millenario
Insomma, a fare due conti, sono passati secoli dall’ultimo fenomeno eruttivo e decenni dall’ultimo momento di problematicità seria. Per molte generazioni, la percezione è stata di relativa calma che ha permesso alle comunità di ricostruirsi e adattarsi. Il fenomeno è radicato nel tempo e nella coscienza, noto non solo a chi vive nella zona. Ve ne sono tracce che consentono di seguirne l’andamento a partire dal IV secolo d.C.; ci sono i richiami e i rimandi negli scritti di Virgilio e nella Divina Commedia di Dante, e le evidenze arrivano ai tempi più recenti. Ad esempio: la trasposizione filmica della commedia di Eduardo De Filippo “Sabato, domenica e lunedì”, realizzata da Lina Wertmüller nel 1990 con Sophia Loren protagonista, si apre con una voce fuori campo che dice: “… Nell’antica città di Pozzuoli, da tempo immemorabile la terra si muove salendo e scendendo lentamente, tanto che la gente che ci vive ci si è abituata”. I Campi Flegrei sono un corpo millenario abitato da sempre: qui, in età arcaica, sorge la prima colonia greca del Mediterraneo Occidentale; qui, in età romana, c’è il più importante porto commerciale dell’Urbe e le residenze di villeggiatura della nobiltà. Appare dunque evidente il richiamo naturalistico, storico, archeologico, paesaggistico, culturale, e una certa innegabile fascinazione. È vero, oggi il tema è un altro – le ultime scosse, la paura, i danni, la percezione di pericolo, il possibile rischio –, ma negli ultimi vent’anni, i Campi Flegrei hanno visto un rinnovato e crescente interesse cinematografico (“Passione” di John Turturro, una puntata dei “Sopranos”) e turistico. Basta cercare, e si trovano centinaia di alberghi, b&b, case vacanza, escursioni tra degustazioni di vini, tour in barca o in vespa. Dunque, delle due l’una: o si è sempre sottovalutato tutto nonostante tutto e la responsabilità non può essere solo dei cittadini, oppure con il bradisismo si è convissuto e si convive, come in tantissimi altri territori italiani succede con altri fenomeni e altri rischi, e ciò che manca non è tanto la consapevolezza dei residenti, semmai la capacità delle istituzioni di averne una propria per rispondere alle domande. Ciò che turba molti, infatti, è l’approccio governativo che sembra trattare la questione ogni volta come fosse la prima che ne sentono parlare.
La paura
E poi c’è la paura. E la paura della paura. Come si fa a restare calmi e coscienti mentre senti la terra tremare sotto i piedi? Cosa succede quando hai a che fare non con un singolo evento catastrofico, ma con una serie di eventi che ti esasperano in un continuo stato di allerta? L’ho chiesto ad Armando Cozzuto, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania che in questa fase sta svolgendo un ruolo di coordinamento e supporto delle attività svolte sul campo dalle associazioni “Psicologi per i popoli” e “Sipem”, iscritte nei registri di Protezione Civile. Ma Cozzuto, 47 anni, è anche cittadino di Pozzuoli: dice dell’apprensione degli ultimi giorni sperimentata in prima persona, ma sottolinea che il popolo flegreo è abituato. Tuttavia, se la scossa di magnitudo 4.2 registrata a settembre 2023 aveva risvegliato timori e preoccupazioni, la successiva stabilizzazione in sciami di intensità più lieve, aveva consentito di metabolizzare l’evento. La speranza era quella di una graduale risoluzione della crisi, come 40 anni fa. Gli eventi del 20 maggio l’hanno mandata in frantumi. Tuttavia, dice Cozzuto, «La paura è una risposta sana e normale. Nel caso del bradisismo ciò che avviene è diverso dall’interfacciarsi con un evento che arriva, devasta e finisce: siamo davanti a una cronicità imprevedibile che crea un clima di tensione costante mentre la vita continua, devi andare a lavoro e via dicendo. Il trauma si ripete o può ripetersi. Per evitare che sfoci in disturbi post-traumatici da stress, abbiamo attivato subito un team per una prima forma di contenimento attraverso specifici protocolli di psicologia dell’emergenza. Va detto che la nostra regione è la prima ad aver attivato, già diversi mesi fa, il servizio di psicologo di base». Sull’esperienza personale, Cozzuto racconta: «Abito vicino all’epicentro, so come e cosa fare, ma anche io mi spavento e con i bambini diventa più difficile. Il consiglio è dire cosa sta accadendo con un linguaggio adatto all’infanzia. Personalmente, noi abbiamo creato una routine: c’è il trasportino per il gatto pronto assieme al trolley e, nell’evenienza di dover lasciare casa, i bambini hanno scelto un giocattolo». Ci sono, ovviamente, anche cittadini che reagiscono con rabbia. Per Cozzuto, rappresenta «l’unica risorsa che hai quando non riesci a trasformare la tua paura in dolore. Il dolore di sapere che potresti dover rinunciare alla tua casa, alla tua città. I social, in questo senso, se da lato permettono di fare rete e scambiarsi informazioni utili, dall’altro diventano sfogo e amplificazione di ansia. Questo non aiuta». Come può risultare controproducente la percezione esterna: «Chi non vive l’area e non approfondisce la questione, non ha il polso, può sottovalutare o arrivare a chiedere: perché vivete lì? La domanda è comprensibile, la risposta è semplice: si vive qui da secoli come in tantissime altre parti d’Italia che devono fare i conti con situazioni di rischio potenziale. Chi accusa o schernisce attiva un meccanismo di difesa per non pensare che potrebbe succedere anche a lui. Oppure no».
I volontari
La probabilità che di solito libera, in questo caso risuona come l’ennesima incognita imprevedibile. Ne è cosciente anche Salvatore Ruocco, coordinatore e delegato regionale della Croce Rossa Italiana alle attività in emergenza al fianco del dipartimento regionale della Protezione Civile. Ruocco è uno dei 56 volontari impegnati nell’assistenza alla popolazione e nel supporto alle persone ospitate all’interno delle tendopoli. «Mi interessa star vicino alla gente perché è spaventatissima» racconta. «A settembre sono scesi in strada, poi sono tornati in casa augurandosi che si trattasse della situazione ciclica e conosciuta, adesso sono di nuovo in strada. La tensione è alta e, per quanto sia brutto, comprendo i momenti di rabbia: devi fare i conti con l’idea di uscire a far la spesa e non poter più rientrare in casa tua o di doverla lasciare improvvisamente. Ci si dimentica, a volte, che le persone possono già vivere situazioni complicate o particolari, esasperate da queste scosse. Per chi è distante può risultare difficile capire cosa significhino nove mesi di scosse continue e prospettiva incerta. Ma noi siamo lì e cerchiamo di fare il possibile». Ruocco mi dà alcuni dati, aggiornati al pomeriggio del 22 maggio e soggetti a controllo ogni due ore: 257 persone assistite dalla Croce Rossa e Protezione Civile nel comune di Pozzuoli, 836 richieste di sopralluogo nelle case, 182 espletate tra Vigili del fuoco e tecnici comunali, 37 ordinanze di sgombero, 46 nuclei familiari spostati. Questi numeri crescono nella giornata del 23 maggio: i controlli arrivano a 388, le richieste di intervento toccano le 1.253, e ci sono episodi di tensione quando alcuni sfollati cercano di rientrare negli appartamenti sgomberati a Pozzuoli.

Andrea Ponticelli, 28 anni, puteolano impegnato nelle attività della Casa del Popolo e attivo anche nel comitato Pozzuoli Sicura, mi spiega meglio: «La percezione umana e morale è varia. Abbiamo visto sgomberi nella parte alta e le persone sfollate non l’hanno presa bene. Non si tratta tanto di stabilirsi altrove, ma di lasciare tutto e andare in tenda senza molte indicazioni. Si va in panico, ci si scoraggia perché, visto che il fenomeno non è nuovo, ci si aspettava un’organizzazione migliore. C’è un decreto, o no? Ti dicono: tu non puoi stare a casa tua, dobbiamo fare controlli. Nel breve termine lo capisci, ma se non ti spiegano, non ti danno tempi o soluzioni alternative le cose cambiano. Non puoi dire: è successo, è stato orribile, ora diamoci da fare, andiamo avanti. Piuttosto, devi continuare a vivere come fosse tutto a posto mentre magari le scosse continuano e dormi in tenda. È legittimo che la gente si chieda: cosa si farà dopo, tra una settimana, tra un mese? Qual è il futuro mio e della mia famiglia? Molti sono già andati via perché nessuno aveva risposte. La gente si sposta a Monterusciello, il quartiere costruito dopo la crisi del 1984, o in altre zone del Napoletano o ancora più lontano. Qui è rimasto chi non sa cosa fare: sono i più stanchi e i più fragili. Chi se la prende con le istituzioni, in fondo, nutre ancora una speranza; altri hanno capito che forse neppure l’istituzione sa fare, che sono soli. Io mi ritengo fortunato: ho dovuto lasciare casa ma sono tornato dai miei, e lo stesso ha dovuto fare anche mia nonna. Sottolineo però che la mia è stata una scelta di buonsenso: nessuno è venuto da me a dirmi che fare, sono stato io a segnalare le crepe che tagliavano i muri in diagonale e andare via». Quale tipo di operazione aiuterebbe davvero, adesso? «Rispondere a tre questioni: cosa si sta facendo, come si procederà, chi è che paga. Mutui e affitti andrebbero sospesi per chi non può stare in casa propria. Il comitato richiede in primo luogo una comunicazione più trasparente, frequente e capillare e non solo nel momento critico. L’ultimo decreto, ad esempio, diceva che ci sarebbero stati momenti informativi: noi, in tanti mesi, abbiamo visto un banchetto e qualche controllo che è parso superficiale. Intanto ci dicono di stare calmi, di farci l’abitudine, ma è una deresponsabilizzazione imbarazzante e vergognosa. Noi siamo già coscienti, ma gli altri?». Gli altri, per l’appunto: «C’è chi colpevolizza gli abitanti, chiediamoci invece di una classe politica che prima ha consentito e speculato sul diritto all’abitare della gente e ora non dà risposte».
“Non li vogliamo i soldi per evacuare”
A Bacoli, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – un sindaco giovane, molto social, abbastanza amato – ha un filo diretto con la cittadinanza via Facebook. Subito dopo le scosse del 20 maggio, ha scritto di come sarebbe stata attivata la macchina comunale, lasciando tutti i recapiti utili e il suo cellulare personale. Nei giorni seguenti, altri aggiornamenti, l’allestimento di un centro di prima accoglienza attivato con la Protezione Civile, un controllo aggiuntivo dei costoni effettuato via mare con la Capitaneria di Porto. Infine, la stoccata a chi dipinge l’area come terra di abusivi e di incoscienti: “Attendiamo che il Governo italiano fornisca risposte concrete. E non li vogliamo i soldi per evacuare. Non accettiamo elemosine per scappare via. Ma vogliamo che si aiuti la gente a mettere in sicurezza, ove necessario, le proprie case. Punto. Nulla più di questo (…) Io sono nato a Bacoli, nei Campi Flegrei. Sono flegreo, da sempre. E sono il sindaco di un popolo straordinario. Non di abusivi, ma di gente perbene. Non di irresponsabili, ma di famiglie laboriose. Non di incoscienti, ma di donne e uomini innamorati della propria terra. Difenderò con ogni forza i diritti della nostra gente. E della comunità di cui ho l‘immenso onore di essere il primo servitore”.
A Quarto vive una coppia di cari amici: Maurizio e Sabrina. Il primo risiede nell’entroterra flegreo dalla nascita come tutta la sua famiglia, la seconda vi si è trasferita da Napoli dopo il matrimonio: «Il 20 maggio ero sotto la doccia dopo una giornata di lavoro, siamo fuggiti alla seconda scossa. Prendere l’ascensore era fuori questione, sulle scale abbiamo aiutato una persona con difficoltà di deambulazione, siamo rimasti con il vicinato in un parcheggio lontano dai palazzi. Le strade cominciavano a imbottigliarsi di traffico». Maurizio le fa eco: «Ma anche se prendi l’auto ti trovi davanti alla domanda: cosa faccio, dove vado, qual è il piano, c’è un piano?». «Alle 23», riprende Sabrina, «pensavamo di rientrare, ma ho sentito ancora la terra che si alzava sotto i piedi. Abbiamo caricato e rifornito la macchina, dormiamo con porte e portoni spalancati, ma la cosa che mi impressiona è che vedo centri commerciali aperti e, attorno a me, sempre nuove costruzioni. Si parla di sgomberi e monitoraggi, ma si continua ad edificare come niente fosse». Le domando perché è andata a vivere a Quarto, anche lei in un palazzo nuovo ai tempi: «Quando sono arrivata qui, la situazione non era certo quella di adesso. La mia è stata anche una scelta economica: a Napoli centro, con il boom turistico, mai mi sarei potuta permettere un appartamento. Nel cercare e scegliere quello in cui vivo, abbiamo fatto molta attenzione a leggi italiane e norme europee. Stando ai documenti, abito in un edificio antisismico che è anche oggetto di adeguamento ecologico. Insomma, sulla carta è tutto a posto, ma il mio stato emotivo è pessimo».
A Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi, di solito molto compassato, ha fatto qualche scongiuro scaramantico, ma poi è tornato al suo solito aplomb da professore di ingegneria. Invito alla calma, alla necessità di informare correttamente i cittadini ed evitare speculazioni e fake news che potrebbero danneggiare la già fragile percezione di sicurezza: «Le istituzioni devono consentire di vivere in normalità». E, guardando alla vita normale, domenica 26 maggio, allo stadio Maradona si giocherà la partita Napoli-Lecce. C’è poi il turismo, vero calmiere di tutte le preoccupazioni immediate: nonostante gli sciami sismici possano farne vibrare una parte, la città è zeppa di visitatori e promette bene anche in vista del ponte del 2 giugno. Napoli la vogliono vedere tutti e, rispetto al 2023, l’assessora comunale al turismo, Teresa Armato, parla di un incremento previsto del 20%. Il contrasto tra il quotidiano dei residenti preoccupati e il flusso continuo di turisti ha forse un solo, vero punto di connessione: sta in quel bagaglio già pronto di cui ho parlato all’inizio. Per chi arriva a Napoli sapendo già che presto la lascerà, è essenziale ma non ha lo stesso valore di chi, residente, ci vede il simbolo di una fuga che spera di non dover mai intraprendere. Il mio borsone sta lì, emblema dell’incertezza in cui vivo, cercando di bilanciare paura, fiducia e consapevolezza, la capacità di adattarmi e la speranza di istituzioni in grado di proteggere questa terra come il resto del Paese.
Credit foto apertura/Alessandro Garofalo/LaPresse
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.