Idee Welfare
L’innovazione nel Terzo settore? Più backoffice che nuovi prodotti e servizi
L'intervento dell'open innovation manager del Consorzio Gino Mattarelli: «Questa preferenza per le questioni gestionali è da ricercare nella transizione del ciclo di vita che molte organizzazioni di Terzo settore stanno attraversando: effetti della riforma normativa, cambiamenti dei mercati, nuove geografie territoriali e, aspetto non secondario, crisi del capitale umano»

Quali traiettorie segue l’innovazione nel Terzo settore e nell’impresa sociale? Stando ai dati (Istat, Techsoup, Italia nonprofit e altri) la propensione all’innovazione sociale tra i soggetti non lucrativi, quindi quella più prossima in via teorica, appare come un fenomeno di nicchia. Quella tecnologica ancora meno, nel senso che è più sporadica e in realtà spesso vocata all’adeguamento rispetto a tendenze ormai mature.
Lo spazio dell’innovazione sembra quindi riservato a target ben definiti – ad esempio le 2.200 cooperative sociali classificate come socialmente innovative dall’Istat o le 640 startup innovative a vocazione sociale – rispetto ai quali l’ecosistema di supporto – caratterizzato, a differenza di altri, da una accentuata componente filantropica – prova a offrire programmi di accompagnamento e risorse economiche dedicate. Per chi vi accede i principali risultati riguardano assessment di natura organizzativa rispetto all’innovazione che ci si può permettere (non solo in termini di elaborazione ma soprattutto di “messa a terra”) e codesign di prodotti, servizi, processi innovativi che assumono una qualche configurazione prototipale o di sperimentazione. Per pochi soggetti l’innovazione “va in goal” attraverso un vero e proprio investimento, magari da parte di un fondi di impact investing, che consente di farla crescere (scalarla come si usa dire).
Questo stato dell’arte, che comunque avrebbe bisogno di conferme empiriche più circostanziate, è probabilmente figlio della sua impostazione focalizzata e selettiva che non a caso si struttura come un funnel (imbuto). Se quindi vogliamo che l’innovazione divenga un bene collettivo, cioè accessibile e condiviso, occorre ripensare gli schemi di accompagnamento e supporto che peraltro sono figli, più o meno legittimi, di quella ideologia digitale che in questa fase storica sta manifestando il peggio di sé. Il problema è che i modelli alternativi – basati ad esempio su portfoli di accompagnamento e investimento che adottano territori e cluster e non solo singole iniziative – sono ancora poco diffusi e complessi da gestire, in particolare se alle spalle manca una concezione d’impatto dell’innovazione di natura sistemica non accontentandosi di misuratori un po’ semplicistici basati sul solo ritorno dell’investimento (anche in termini sociali).
C’è però un’altra questione, più legata a dinamiche interne del settore sociale, che merita di essere approfondita. L’impressione infatti è che la domanda di innovazione in questa fase storica si collochi principalmente a livello gestionale e organizzativo piuttosto che di prodotto e servizio. Probabilmente questa preferenza per le questioni di “backoffice” è da ricercare nella transizione del ciclo di vita che molte organizzazioni di Terzo settore stanno attraversando: effetti della riforma normativa, cambiamenti dei mercati, nuove geografie territoriali e, aspetto non secondario, crisi del capitale umano. Sono dinamiche che, nel loro insieme, innescano percorsi di ristrutturazione organizzativa non solo a livello societario ma anche manageriale, tra passaggi intergenerazionali e introduzione di nuove figure professionali. Il ripensamento della macchina organizzativa riguarda questioni pratiche di ordine gestionale ma anche di logiche più profonde che investono la cultura organizzativa. Ecco quindi che anche un “banale” aggiornamento o cambio del software gestionale o meglio ancora la ricerca di una integrazione tra diversi gestionali stratificati nel tempo e rispondenti a esigenze e aspettative diverse – a volte anche confliggenti – assurge a priorità strategica e operativa che assorbe effort e risorse. Tutto ciò a discapito – banalmente perché le risorse non sono illimitate – di altre soluzioni pensate per attività nuove o per veicolare in modo differente quelle già svolte. La trasformazione digitale del welfare può quindi attendere o, nel caso, essere affidata a veicoli societari specializzati come può essere una startup “verticale”.
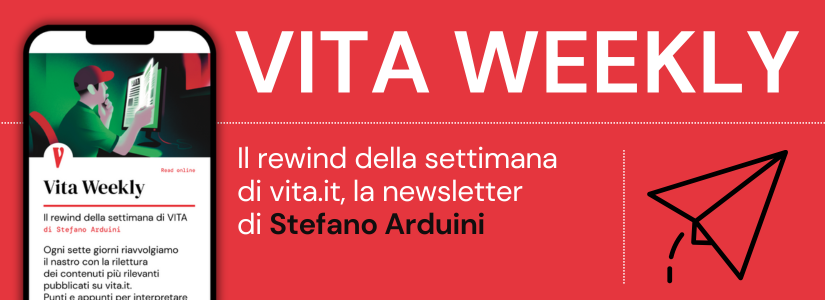
Sarebbe facile concludere che anche l’innovazione è finita nel gorgo della managerialità diventando, in forme e modi diversi, compliant rispetto alla gestione ordinaria. Forse in parte è così ma non è detto. Dipende, ad esempio, dalla consapevolezza rispetto alla rilevanza strategica del processo di adozione dell’innovazione. Basti pensare, in campo tecnologico, all’impatto dell’automazione (ora iniettata da agenti di intelligenza artificiale), nei sistemi di controllo e gestione, spesso a loro volta interfacciati con quelli della rendicontazione sociale e della gestione del capitale umano. Possono rappresentare un efficientamento fine a se stesso (e quindi in realtà un assoggettamento alla tecnica particolarmente doloroso in organizzazione collettive e a scopo sociale) oppure un’azione di change management capace di liberare risorse – di tempo in particolare – da dedicare a innovare servizi e processi (in particolare quelli su base comunitaria) facendo leva sul protagonismo di persone e unità organizzative (le famose equipe) oggi fagocitate dalla burocrazia. Ma questo nuovo supporto potrebbe agire anche sul versante dell’efficacia costruendo sistemi informativi in grado non solo di presidiare ma di ridefinire gli schemi di misurazione e di senso degli impatti generati che oggi appaiono spesso “alieni” rispetto alle prassi. Vedremo quindi se questa innovazione da “dietro le quinte organizzative” intrapresa da soggetti che in questi anni, loro malgrado, sono diventati dei grandi “ruminanti” di adempimenti (certificazioni, accreditamenti, standard vari), riuscirà a togliere il tappo di un’innovazione un po’ più dirompente e rivolta a persone e comunità che oggi pare un po’ assopita.
Foto di Andrea Piacquadio/Pexels
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.


