Idee Disuguaglianze
Netless class, il nuovo precariato dei lavoratori poveri “senza rete”
La frattura più profonda oggi non si manifesta tra categorie professionali o livelli di istruzione, ma tra chi dispone di una rete di protezione patrimoniale, familiare, relazionale e chi invece no. Per queste persone, un solo evento può compromettere l’equilibrio di vita: una separazione, una malattia, una causa legale, anche se vinta

La polarizzazione della ricchezza, l’evidenza dell’aggravarsi delle disuguaglianze, l’impatto sulla crisi climatica e la questione migratoria sono fenomeni che giustificano il rinnovato interesse per la questione di classe negli ultimi dieci anni. Lea Ypi, in Confini di classe (2024), evidenzia come le nuove appartenenze politiche si costruiscano sulla base di marcatori identitari (nazionali, culturali) e non più economici. Questo consente alle élite di frammentare l’elettorato della classe lavoratrice e dissimulare le diseguaglianze reali. Un operaio precario e un freelance sottopagato difficilmente si percepiscono come appartenenti alla stessa condizione, mentre si riconoscono nell’identità etnica o nazionale. Ma di cosa parliamo quando parliamo di “classe lavoratrice”?
La tassonomia delle classi sociali proposta da Mike Savage (Social Class in the 21st Century, 2015, Penguin/UK) rappresenta uno degli sforzi più sistematici per aggiornare l’analisi di classe alla società contemporanea. Savage parte dal presupposto che le tradizionali classificazioni di classe, basate sul lavoro, sulla proprietà dei mezzi di produzione o sul prestigio/status, non siano più sufficienti a descrivere le disuguaglianze attuali e propone di adottare le variabili di capitale economico, sociale e culturale di Bourdieu per identificare classi tra loro omogenee. Ne identifica sette, basandosi su un vasto dataset (161mila risposte online + mille interviste face-to-face per validazione). Le fa emergere da una cluster analysis del livello delle tre forme di capitale.
Un elemento chiave della proposta è l’adozione di una categoria definita solo pochi anni prima da Guy Standing (The Precariat: The New Dangerous Class, Bloomsbury, 2011), tra le innovazioni teoriche più influenti del dibattito recente sulle classi sociali: il precariato. Si tratta della classe degli ultimi: una classe emergente e globale, distinta dalla classe operaia e dal proletariato classico marxista. È caratterizzata da occupazioni temporanee, part-time, a chiamata, lavori di piattaforma, la mancanza di una identità professionale chiara, basso capitale economico, sociale e relazionale e in una condizione che ne compromette l’accesso ai diritti. Nel 2018 Riccardo Staglianò nel suo Lavoretti (Einaudi, 2018), mette in luce molto bene come la proliferazione dei lavori su piattaforma e l’affermarsi della sharing economy emergano con l’impoverimento della classe media successiva al susseguirsi delle crisi economiche degli ultimi vent’anni, ampliando una platea di forza lavoro disponibile anche a mettere a valore i propri asset (tempo, casa, automobile) con attività sottopagate e non tutelate. Non per tutti le crisi hanno significato un precipitare nel precariat, ma per molti hanno reso evidente il rischio potenziale, in assenza di contromosse.
Nei più recenti tentativi di mappare la struttura sociale dell’Italia contemporanea, come nel saggio Le classi sociali in Italia oggi (Il Mulino, 2024) di Pier Giorgio Ardeni, l’impianto teorico resta ancorato a un’analisi tripolare delle disuguaglianze: classe (lavoro), status (prestigio) e potere (reddito e patrimonio). Seguendo la scia di Erik Olin Wright e di Pierre Bourdieu, l’autore costruisce una tassonomia utile per misurare distanze e stratificazioni, in particolare attraverso redditi equivalenti, titoli di studio e tipologie professionali. Uno dei limiti essenziali di questi approcci è di fotografare la divisione di classe nel loro darsi sincronico, senza tenere in considerazione la mobilità tra classi. Mike Savage, ben consapevole del rischio, affronta il tema nel 2021 con il volume The return of inequality, dall’eloquente sottotitolo The weight of the past. Le classificazioni proposte, seppur senz’altro utili per leggere la disuguaglianza comparata – tra Paesi, tra epoche –mostra i suoi limiti nel cogliere le nuove vulnerabilità che hanno impatto principalmente nell’osservazione diacronica dei fenomeni. La frattura più profonda oggi non si manifesta tra categorie professionali o livelli di istruzione, ma tra chi dispone di una rete di protezione patrimoniale, familiare, relazionale e chi invece no. Per queste persone, un solo evento può compromettere l’equilibrio di vita: una separazione, una malattia, una causa legale, anche se vinta. Sono esposti in modo assoluto al rischio e al ricatto. La netta separazione di classe, definita dal possedere patrimonio, è da un lato il precariat e tutte quelle persone a rischio di finire tra gli ultimi nel corso della vita, facendo precipitare tutta la famiglia nell’indigenza e nella privazione di diritti, dall’altro le élite che detengono patrimonio e rendite.
Il Global Wealth Report 2025, Ubs Global Wealth Management pubblicato nel luglio 2025 conferma ciò che gli analisti stanno raccontando da oltre un decennio (per convenzione adottiamo il 2013, anno di pubblicazione de Il Capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty) sulla polarizzazione della ricchezza e il maggiore tasso di rendimento del capitale sulla crescita del reddito. Anche in Italia più si è ricchi, più il patrimonio aumenta. Lo 0,1% più ricco degli italiani ha registrato un incremento di oltre il 70% tra il 1995 e il 2016 (dal 5,5% al 9,4%); beneficiando di un rendimento medio annuo sui patrimoni (5%) quasi doppio rispetto a quello (2-3%) del 90% più povero degli italiani.
Questo squilibrio patrimoniale non si traduce solo in differenze di consumo o risparmio, ma in asimmetrie radicali nella gestione dell’imprevisto e in una diversa attitudine al rischio. Chi ha capitale può assorbire uno shock. Chi non ce l’ha, è razionalmente subordinato, come mostra anche la teoria dei giochi: non può permettersi conflitti o scelte rischiose. Ad esempio deve accettare un qualsiasi lavoro perché non può aspettare, o ha meno scelta rispetto a chi vive il lavoro come gioco. In merito al fare impresa è ben diverso impegnare la propria casa e mettere a rischio tutto, oppure di contro solo una frazione del proprio patrimonio. Analogamente la prospettiva nei confronti del cambiamento climatico cambia, perché i rentier non subiscono quanto la Netless Class l’impatto di catastrofi climatiche, ma hanno per contro una prospettiva diversa sul futuro, perché non sono pressati da esigenze presenti: paradossalmente chi ha meno da perdere è più sensibile alla questione del climate change.
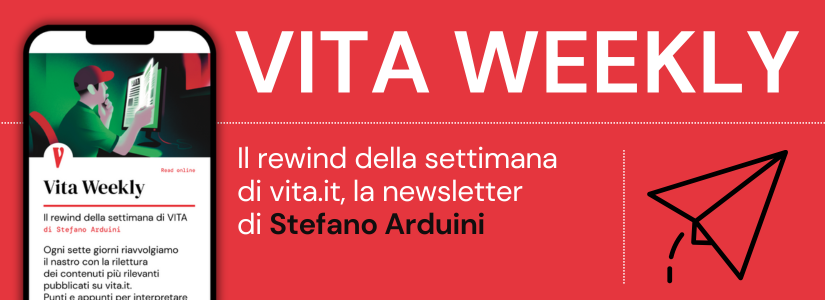
La Netless Class è una classe ampia: include non solo il precariat di Standing e i working poors, non solo la classe operaia e il lavoro dipendente meno qualificato, ma anche quegli ambiti professionali e imprenditoriali di persone che vivono del proprio lavoro e non hanno capitale sufficiente alle spalle, quella massa critica per garantire lo stile di vita per sé e la propria famiglia nel tempo, indifferente agli shock e agli accidenti della vita. La definizione e la consapevolezza di “classe lavoratrice” non sembra sufficiente a definire l’appartenenza, anche perché oggi chi ha patrimonio lavora (anzi ha accesso alle professioni più gratificanti e meglio remunerate). La separazione politica della classe operaia e dei colletti bianchi è evidente già a partire dalla marcia dei quarantamila del 1980, mentre una prospettiva che fa riferimento alla rete di protezione potrebbe di nuovo saldarne gli interessi, così come quelli del piccolo imprenditore, del professionista e del lavoratore autonomo. La Netless Class ha un valore aggiunto ermeneutico perché taglia le categorie professionali e si concentra sull’esposizione all’imprevisto e sulle reali opportunità dovute alla diversa propensione al rischio; è mobilitante: può generare una nuova alleanza tra chi vive solo del proprio lavoro e chi non ha capitale alle spalle, ridisegnando le divisioni degli insiemi elettorali ed è politicamente promettente perché rende esplicito un sentimento di frustrazione e risentimento che oggi si scarica sugli stranieri, che invece condividono la stessa condizione e lo stesso destino. Una polarizzazione tra élite e Netless Class rende evidenti (e urgenti) scelte politiche per una fiscalità più giusta, per una revisione delle tasse di successione, per la lotta alle scappatoie fiscali perpetrate dai grandi patrimoni e delle aziende tecnologiche, per una revisione delle politiche salariali, per una promozione del lavoro, anche imprenditoriale e autonomo, sulle rendite.
Oggi le classi sociali non sono scomparse, ma hanno cambiato natura. Servono nuove lenti per coglierle. L’inadeguatezza delle tipologie classiche non è solo analitica, ma strategica: rende cieche le politiche redistributive e indifferenti i destinatari che avrebbero tutto l’interesse a promuoverle. Un sistema fiscale giusto, un welfare protettivo, un patto sociale nuovo devono partire da qui: da chi ha solo il lavoro: da chi lavora senza rete.
Foto di Kaique Rocha/Pexels
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.


