«La madre mi genera, la mamma mi cresce. La madre mi dona la vita, la mamma mi dona la sua vita. Spesso madre e mamma coincidono, ma a volte no. Ci metterai molto a perdonare la prima, non smetterai un secondo di amare la seconda. È questa la differenza. Io ho amore e rispetto per la donna che mi ha messo al mondo, ma non posso considerarla mia mamma e non può esserci con lei un rapporto così morboso da volerla a tutti i costi ritrovare, magari anche solo per mettere un fiore sulla sua tomba. Non si può vivere di sliding doors, di “come sarebbe se”. Bisogna imparare ad accettare i dati di realtà, arrivare ad una accettazione positiva della propria esperienza di nascita: questo fa sì che noi figli non riconosciuti alla nascita, diventati adulti, scegliamo di essere responsabili nei confronti dei bambini di oggi, tutelando quella strada attraverso cui noi abbiamo avuto la vita». Claudia Roffino commenta così la vicenda di Enea e dell'altra bambina che nel giro di tre giorni sono stati affidati dalle loro madri a due diversi ospedali milanesi. «Non dica abbandonati, non è così. Sono stati messi in sicurezza», precisa. «Usare l’espressione “abbandonato” rende più difficile anche per noi elaborare la cosa: se sono stato abbandonato devo elaborare un abbandono, se invece mi viene detto che mia madre non poteva offrirmi quello che un genitore deve offrire a un figlio e mi ha messo in sicurezza, è diverso. È diverso anche quello che da adulto penserai di quella donna».
Roffino è un’insegnante di greco e latino, ha 56 anni ed è una figlia non riconosciuta alla nascita. Sulla sua vicenda ha appena pubblicato un libro, Una vita in dono, scritto a quattro mani con Barbara Di Clemente che – basandosi sulle interviste e le testimonianze raccolte da Roffino presso assistenti sociali, ginecologi, operatori che per lavoro hanno incontrato più volte donne che non hanno riconosciuto il proprio figlio – ha dato voce alla madre di Claudia.
Claudia, partiamo dalla sua storia.
Nasco nel febbraio 1966 da una donna che ha scelto il parto in anonimato in un ospedale di Torino. Come per tutti i non riconosciuti è venuto l’ufficiale di stato civile a darmi il nome: porto il nome del santo del giorno, Claudiana, ma i miei mi hanno sempre chiamata Claudia. Quindi sono stata trasferita all’Ipim di corso Lanza, l’Istituto Provinciale per l’Infanzia di Torino. In quegli anni eravamo in tanti, pare 300 bambini da 0 a 3 anni, con poche coppie disponibili all'adozione. I miei genitori hanno fatto la scelta dell’adozione sicuramente spinti principalmente dal fatto di non poter aver figli biologici, ed erano già avanti negli anni. Sono stata in istituto solo tre mesi. Uno pensa che tre mesi, da neonato, siano pochi per lasciare traccia, ma non è così. La mia nuca era completamente pelata, perché stavo sempre distesa. Ma soprattutto c’è un episodio che i miei raccontavano sempre…
Quale?
Appena i miei genitori mi hanno portato a casa, ho iniziato a strillare perché avevo fame. Loro hanno fatto “a gara” per prendermi in braccio e darmi il biberon, ma io non ne volevo sapere e continuavo a strillare. Hanno provato di tutto, sono usciti per comprare un altro latte, mia mamma si è persino messa un asciugamano in testa per imitare le suore del centro… Ma io urlavo. Mio padre, che era medico, a un certo punto si è detto: “basta, non devo pensare da padre ma da medico”. È lì che gli è venuta l’intuizione: ma all’Ipim, con tutti quei bambini, come facevano a prenderli in braccio uno per uno per dargli da mangiare? Mi ha adagiato nella culla, mi ha messo il biberon accanto e io mi sono tranquillizzata e ho iniziato a mangiare. Io non sapevo cosa fosse essere presa in braccio, accudita, coccolata. Ovviamente ci ho messo poco a capire che era più bello così e ad abbandonare la mia vecchia abitudine, ma questo è per dire come in tre mesi ci fosse già un habitus, un mondo. Per questo è importante ricordarsi sempre che ogni anno, ogni mese, ogni giorno in più in strutture che oggi sono certamente diverse da quella in cui sono stata io nel 1966 ma che in ogni caso non sono famiglia, non hanno quel calore di mamma e papà… lascia un segno. L’adozione deve iniziare il prima possibile. Perché la mia vita a quel punto è veramente iniziata. Sono stata molto amata dalla mia famiglia, tranne che dalla sorella di mio papà. Io per lei non ero una Roffino. Non è stato facile vivere con un familiare che non ti accetta. Lo dico non per mia zia, ma perché questo tema della cultura del sangue oggi è molto rimarcato e perché la maggior parte delle persone sotto sotto la pensa come mia zia, altrimenti non ci sarebbe sempre questo tema per cui la mamma vera è la mamma biologica, mentre le mamme e i papà adottivi sono genitori "di scorta" o di serie b. Certo che ogni bambino ha bisogno di una mamma e di un papà veri. Di una mamma e un papà veri, punto. Se potranno saranno quelli che lo hanno messo al mondo, se no saranno la mamma e il papà che lo ameranno di un amore infinito pur non avendolo procreato. Siamo noi figli a scegliere chi è nostra mamma e nostro papà, quando riconosciamo chi svolge appieno per noi quel ruolo.
Sono rimasta in istituto solo tre mesi. Quando i mie genitori mi hanno portato a casa e io iniziai a strillare perché avevo fame, loro hanno fatto “a gara” per prendermi in braccio e darmi il biberon, ma io non ne volevo sapere e continuavo a strillare. Hanno provato di tutto, sono usciti per comprare un altro latte, mia mamma si è persino messa un asciugamano in testa per imitare le suore del centro… Ma io urlavo. Mio padre a un certo punto ha l’intuizione: ma all'istituto, con tutti quei bambini, come facevano a prenderli in braccio uno per uno per dargli da mangiare? Mi ha adagiato nella culla, mi ha messo il biberon accanto e io mi sono tranquillizzata e ho iniziato a mangiare. Questo per dire come in tre mesi ci fosse già un'abitudine. Per questo l'adozione deve cominciare il prima possibile
Claudia Roffino
Come è nato il libro “Una vita in dono”?
Era da anni un mio sogno quello di portare queste tematiche alla luce. Né l’editor né la coautrice del libro sapevano della legge sul parto in anonimato: se non si sa nulla di questa opportunità “ai piani alti” come pensiamo che si sappia tra le ragazzine, le donne straniere, le donne con meno strumenti culturali? Quando si parla di adozione, si parla molto di adozione internazionale o di ricerca delle origini, meno di storie come la mia. Io distinguo molto tra le mie origini e le mie radici. La mia origine è quella che non so, ma le mie radici sono la mia famiglia, quella che mi ha cresciuto, con i racconti dei nonni e dei bisnonni. Io una storia di famiglia ce l’ho ed è quella. Ho intervistato operatori, assistenti sociali, ginecologi in Piemonte e in Lombardia che mi hanno raccontato tante storie di donne che hanno scelto di partorire in anonimato: da questi racconti è nata, nel libro, la figura di mia madre, scritta dalla coautrice. Per l’opinione pubblica in generale la scelta che fanno queste donne sembra qualcosa di facile, quasi un “disfarsi” del bambino. Infatti si usa il termine “abbandono”. In realtà è una scelta molto sofferta. Nel mio racconto non è emerso perché nel 1966 l’ecografia non c’era, ma in tantissimi racconti di oggi torna il dolore enorme di queste donne quando sentono il battito cardiaco del bambino, il rendersi conto che questa creatura c’è e che loro non potranno occuparsene è devastante. Mi hanno raccontato di tante lacrime silenziose in quel momento.
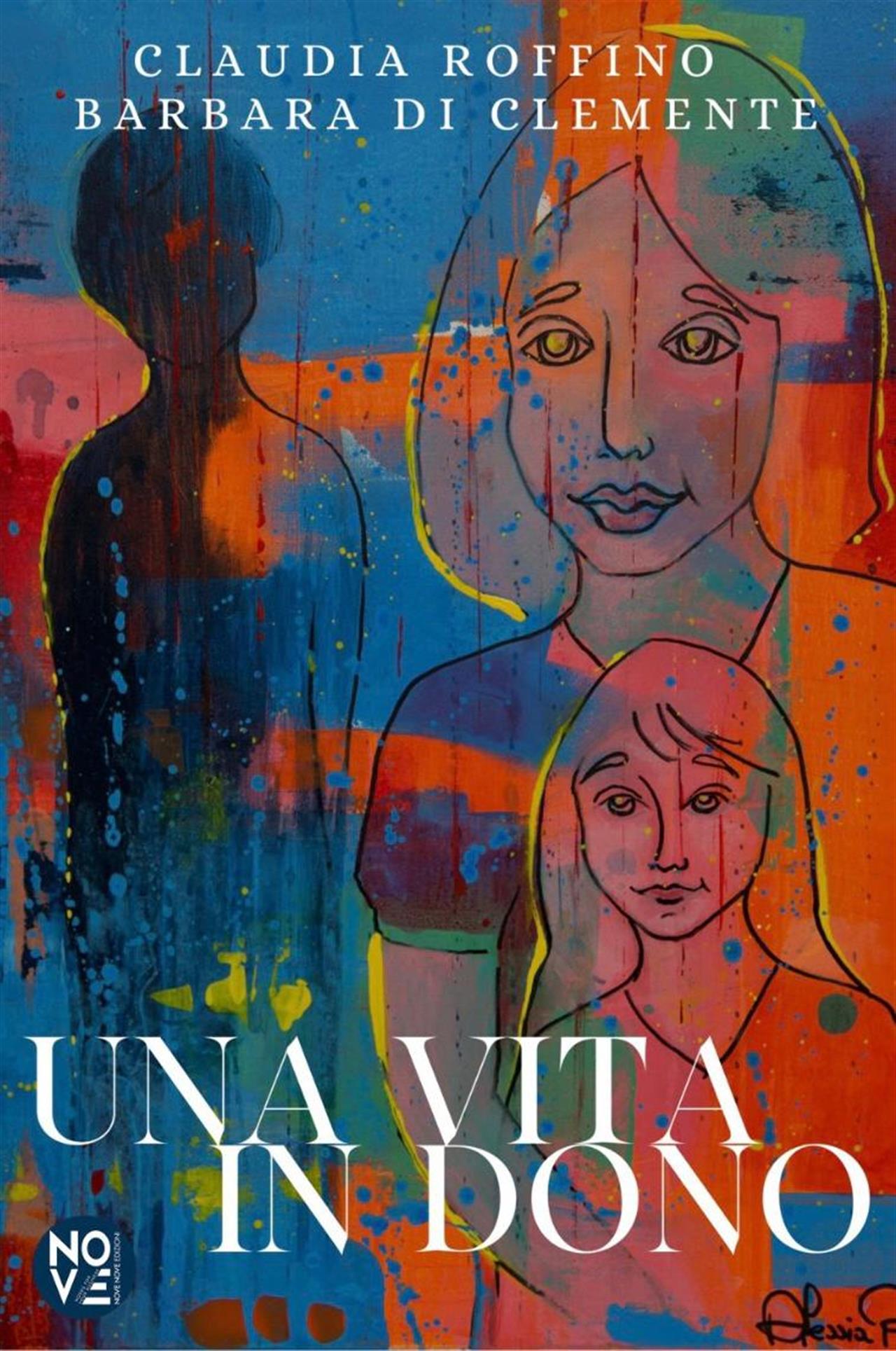
Cosa ha provato quando ha letto la storia di Enea e poi dell’altra bimba abbandonata a Milano?
Non usate la parola abbandonato. Si festeggia giustamente il fatto che i due bambini siano vivi e che stiano bene, ma ci sono da qualche parte due donne devastate da questa vicenda che non ne parleranno con nessuno per il loro desiderio di anonimato. Abbandonata è la donna. Il bambino è affidato in mani sicure e se la madre non ci ripenserà – ed è giusto che abbia un tempo per ripensarci – si avvierà un iter per cui in pochissimi giorni il bambino avrà una famiglia. Saprà di essere stato adottato, ma è in assoluta sicurezza. Inoltre per un figlio non riconosciuto è diverso elaborare un abbandono o elaborare un vissuto per cui la madre non poteva offrirgli quello che un genitore deve offrire a un figlio e lo ha messo in sicurezza. quindi in questi giorni per il bambino ho sentito molto il fastidio per la violazione della privacy, ma la mia preoccupazione è tutta per la donna abbandonata. Anche questi appelli perché ci ripensi… ma se lo tiene e non è nelle condizioni e non ha la convinzione di voler essere la mamma di quel bambino, come lo crescerà? Fra tre anni magari quel bambino andrà lo stesso in adozione e gli abbiamo fatto perdere tre anni con la nostra pretesa che “devi tenerlo perché tu sei la sua mamma”.
Lei ha scritto che «il bambino è salvo, ma grazie a una culla medievale, mentre la legge prevede che le donne vengano assistite prima, durante e dopo il parto, che siano accompagnate nel loro percorso affinchè possano scegliere in libertà». Perché?
Io sono più a favore del parto in sicurezza in ospedale, in anonimato. La culla termica non protegge la donna e il bambino nel momento del parto. La legge sul parto in anonimato invece garantisce la protezione di entrambi: secondo la legge la donna va seguita prima, durante e dopo il parto. Ma la verità è che il “dopo” non è mai seguito. Con la culla termica non sappiamo se la donna partorisce in ospedale o meno, c’è un rischio per la salute di entrambi. Chiaro che se le donne che scelgono il parto in anonimato vengono giudicate e abbandonate, viste come donne che abbandonano il bambino, sempre meno donne sceglieranno questa opzione. Anzi, il ricorso al parto in anonimato è molto calato negli ultimi anni: al contrario di quel che si è letto ancora in questi giorni, su 3mila neonati non riconosciuti alla nascita ogni anno, questi in realtà non superano ultimamente i 200 l’anno (il Centro Studi Nisida del Ministero della Giustizia mette a disposizione i dati storici delle adozioni nazionali di figli di genitori ignoti, si trova qui, ndr). Il trend andrebbe indagato proprio per la sua esiguità: c’è infatti una notevole diminuzione nel numero di neonati non riconosciuti, diminuiti in vent’anni del 49,7%. Sono passati da 362 nel 2000 a 182 nel 2020. Io credo che c’entri anche la paura di essere ricercata tra 25 anni, quando una volta cresciuto il bambino può chiedere al tribunale di verificare se la donna che lo ha messo al mondo è ancora intenzionata a mantenere l’anonimato.
Il parto in anonimato garantisce la sicurezza della donna e del bambino, ma se le donne che lo scelgono vengono giudicate e abbandonate, viste come donne che abbandonano il bambino, sempre meno donne sceglieranno questa opzione. La verità è che il ricorso al parto in anonimato è molto calato negli ultimi anni e io credo che c'entri la paura di essere ricercata tra 25 anni, quando una volta cresciuto il bambino potrà chiedere al tribunale di verificare se la donna che lo ha messo al mondo è ancora intenzionata a mantenere l’anonimato
Claudia Roffino
La legge garantisce l’anonimato per 100 anni, ma dal 2016 alcune sentenze hanno aperto alla possibilità per il figlio di chiedere al Tribunale di rintracciare la donna che lo ha partorito per verificare se è sempre intenzionata a mantenere l’anonimato. Perché lei lo considera un errore?
All’atto della nascita, per il bambino non riconosciuto vengono compilate due cartelle, una del bambino, aperta e una della donna, chiusa. Io ho richiesto la mia cartella: c’era una foto, l’età e la provenienza di mia madre, i miei dati sanitari. Nella cartella della donna ci sono i suoi dati anagrafici, ma questa secondo la legge resta chiusa per 100 anni, salvo questioni sanitarie per cui il Tribunale può accedervi (ma non il figlio). Come diceva sentenze recenti danno la possibilità di rivolgersi al Tribunale, compiuti i 25 anni, per cercare la donna. Intanto più persone a questo punto vengono a conoscenza del nome della donna. E come fa poi il Tribunale a interpellare la volontà della donna? Le telefona? Manda una raccomandata con busta intestata? Manda la polizia locale? E se quella donna ha una famiglia? Come si concilia questa ricerca con la sua intenzione a mantenere ancora l’anonimato? Come può una legge del genere essere retroattiva? Alla donna che mi ha messo al mondo è stato assicurato l'anonimato per 100 anni e invece io adesso potrei andare a cercarla… Se dico ad una donna che non vuole crescere il bambino che ha appena partorito che tra 25 anni quel bambino potrebbe mandare un Tribunale a cercarla, quella donna avrebbe paura: non va a partorire in anonimato, partorisce da sola e poi se va bene porta il bambino in una culla termica.
Eppure questo orientamento nuovo viene proprio dalla richiesta di figli non riconosciuti adulti.
Appunto, si tratta di adulti. È una richiesta adultocentrica, che non pensa che noi non riconosciuti abbiamo una responsabilità verso quelli che oggi sono bambini non riconosciuti. Noi oggi dagli ospedali sappiamo il numero dei neonati non riconosciuti, dalle cronache sappiamo il numero dei neonati che sono ritrovato occasionalmente, vivi o morti, ma c’è una fetta di bambini di cui non abbiamo numeri. Sono i bambini nati e poi venduti, ammazzati, occultati. Questo numero non esiste, formalmente è uno zero ma in realtà è uno zero pieno di bambini di cui siamo tutti responsabili. Anche noi figli adottivi adulti pensiamo a noi, a quello che vogliamo noi, al desiderio di sapere chi è la donna che ci ha partorito, perché ha fatto quel che ha fatto, al desiderio di portare un fiore su una tomba… È una visione adultocentrica, è la mia necessità di adulto di colmare il mio vuoto. Pretendiamo diritti e non pensiamo di avere doveri. Io invece penso che sia mio dovere come figlia non riconosciuta fare sì che dentro quello 0 statistico ci siano davvero sempre meno bambini… Noi adottati adulti dobbiamo riflettere sul fatto che siamo nati grazie a quelle donne e a quella legge. La decisione per me è semplice: o le leggi sono fatte per tutelare i bambini, compresa quella sulle adozioni, o tutto è fatto per gli adulti. Non ci sono tante altre strade.
La richiesta di rintracciare la madre da parte di figli adottivi adulti è una richiesta adultocentrica, è la mia necessità di adulto di colmare il mio vuoto. Pretendiamo diritti e non pensiamo di avere doveri. Io invece penso che sia mio dovere riflettere sul fatto che siamo nati grazie a quelle donne e a quella legge e far sì che altri bambini abbiano la nostra stessa possibilità di ricevere una vita in dono
Claudia Roffino
Lei non ha mai pensato di rintracciare sua madre?
Ho sempre avuto una certa curiosità, soprattutto da ragazza, in particolare quando da adolescente sei arrabbiata e dopo aver passato il senso di colpa, quello per cui se tua madre non ti ha voluta è colpa tua, vorresti trovarla per dirle in faccia che è stata una stronza. Inoltre per noi figli adottivi in generale la famiglia biologica è la carta da giocare davanti ai no dei genitori, quando rispondi “allora vado a cercare gli altri”. Ma poi cresci e capisci che la vita non ti da sempre quello che vuoi, che di sliding doors non possiamo vivere, non è possibile per tutta la vita chiedersi come sarebbe stato se… Bisogna imparare ad accettare dei dati di realtà. L’accettazione positiva della propria esperienza di nascita fa sì che cresciamo e diventiamo adulti responsabili, capaci di tutelare quella strada attraverso cui noi abbiamo avuto la vita. Noi ci siamo grazie, noi possiamo dire grazie a questa donna che ha avuto il coraggio di portare avanti la gravidanza. C’è una differenza tra ciò che è mamma e ciò che è madre. La madre mi genera, la mamma mi cresce. La madre mi dona la vita, la mamma mi dona la sua vita. Spesso madre e mamma coincidono, ma a volte no. Ci metterai molto a perdonare la prima, non smetterai un secondo di amare la seconda. È questa la differenza. Per essere mamma non basta esser madre, ci vuole ben altro. Ci sono donne che hanno capito che erano in grado di essere madri ma non di essere mamme e che quindi ci hanno fatto un dono, il dono della vita.
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.

