Idee Lavoro sociale
Adolescenza, il problema siamo noi: non siamo più “spacciatori di opportunità”
La politica vede gli adolescenti? È la domanda che abbiamo rivolto ad Andrea Morniroli, amministratore della cooperativa sociale Dedalus, nel corso della presentazione del nuovo numero di VITA a Napoli. Ecco il suo intervento, che provoca la politica ma anche il Terzo settore

Ma la politica questi adolescenti li vede davvero? È una domanda larga, che abbiamo posto ad Andrea Morniroli nel corso della presentazione a Napoli del numero di VITA dedicato agli adolescenti, lo scorso 19 giugno. Morniroli è socio e amministratore della cooperativa sociale Dedalus di Napoli, coordina il Forum Disuguaglianze e Diversità insieme a Fabrizio Barca ed Elena Granaglia, è presidente della Fondazione di Comunità “La porta di Napoli”. C’è il tema forte delle disuguaglianze. Di una scuola che non è più capace di ridurre le disuguaglianze in entrata. C’è la rabbia degli adolescenti, che è molto legata proprio all’accorgersi delle diseguaglianze sociali. C’è una città come Napoli, bellissima e complicata. Ecco il suo intervento, alla vigilia del nuovo appuntamento milanese per la presentazione del magazine, Adolescenti, quello che non vediamo: vi aspettiamo questa sera alle 19 al Nuovo Armenia, in via Livigno 9 a Milano.
Vorrei prima di tutto dire una cosa sul numero, che in parte è anche legata alla domanda “ma la politica vede davvero gli adolescenti?”. La risposta è no, in generale, poi è chiaro che ci sono le eccezioni. Poi cercherò di spiegare. Però nel numero di VITA si trovano alcuni elementi importanti, che, secondo me, la politica farebbero bene a tener presente per poter guardare davvero gli adolescenti.
Intanto nel numero si riconosce la complessità di cosa è l’adolescenza. Oggi uno dei virus che contamina di più il dibattito pubblico sono le semplificazioni della rappresentazione. Spesso non non si ha né la voglia, né il coraggio, né le competenze per entrare dentro la complessità. E questo poi produce letture sbagliate, anche quando si legge una città complessa e attraversata dal paradigma dell’ambiguità come Napoli.
Due: nel numero si provano ad utilizzare sguardi e alfabeti differenti. Si prova a mettere insieme punti di vista formali e informali, perché un altro limite è questo, quello di guardare le cose sempre con le stesse persone e sempre nello stesso modo.
Terza questione: la voglia di guardare non soltanto alle mancanze, ma anche i talenti e le aspirazioni, perché questo ti ribalta la prospettiva. Quante volte la politica, ma anche quelli come me che fanno gli operatori sociali, arrivano in un contesto e portano una pre-narrazione tutta in negativa di quel contesto. E quindi non riescono più a vedere i talenti, l’aspirazione, non riescono a più essere “spacciatori di opportunità”, come secondo me dovrebbe essere un buon operatore.
La politica ma anche gli operatori sociali spesso arrivano in un contesto e portano una pre-narrazione tutta in negativa di quel contesto. Di conseguenza non riescono più a vedere i talenti, l’aspirazione, non riescono a più essere “spacciatori di opportunità”, come dovrebbe essere un buon operatore
Andrea Morniroli
Quarta questione, fondamentale, è dare voce al protagonismo dei ragazzi e delle ragazze. Perché è vero, questo non è soltanto uno dei Paesi più vecchi al mondo, ma siamo anche uno dei Paesi più egoisti al mondo. Se guardate le politiche nazionali in questo momento, ma forse perché i giovani sono pochi e quindi contano meno, non vanno nella direzione di cui stiamo parlando. Faccio alcuni esempi secchi, poi arrivo a Napoli.
La politica? Va da un’altra parte
Sono ormai quattro o cinque anni che nella legge di stabilità vengono tolti più o meno 2 miliardi all’anno sulla scuola e sull’educazione, perché c’è il calo demografico. Quindi l’algoritmo dice meno alunni, meno docenti: peccato che in Francia, in Belgio, in Germania, che pure hanno un calo demografico, i soldi li reinvestono nella scuola, in particolare nelle periferie, per aumentare la qualità del sistema formativo, per aumentare le co-presenze, eccetera. Due, abbiamo un ministro che parla esplicitamente di “addestrare” anziché di “educare”, con buona pace di don Milani, tant’è vero che per lui i tecnici e i professionali si possono fare in quattro anni, perché tanto lì dentro non si formano cittadini, si formano lavoratori. E quindi no, la politica non li vede gli adolescenti, perché va da un’altra parte. Non si riescono neanche a produrre politiche – qui vengo a Napoli – in grado poi di impattare sul territorio.
In questa città sono arrivati quanti milioni di euro del Pnrr per la povertà educativa? Ma sono arrivati con la modalità del ministero dell’Istruzione che continua a far calare sui territori risorse collegate a moduli prefissati, uguali in tutta Italia, che dovrebbero andar bene per qualsiasi alunno e quasi tutti da agire nell’extra curricolare, nel pomeriggio. Ma mi spiegate perché mai un ragazzino che magari si annoia la mattina a fare matematica a scuola e poi scopre che il pomeriggio invece si può fare una bella matematica perché la fa con qualche cooperativa o associazione che matematica la fa in maniera innovativa e divertente, che cosa gli stiamo dicendo a quel ragazzino? Gli confermiamo che a scuola ci si annoia. Allora, non sarebbe meglio fare programmi di accompagnamento sui patti educativi e sulle comunità educanti, in cui il curriculare si intreccia con l’extra curricolare e quella bella matematica viene fatta al mattino dall’educatore con il docente in classe. Così poi non c’è neanche bisogno della cooperativa, perché alla fine del progetto è la scuola che è cambiata e quindi c’è pure la sostenibilità progettuale. Invece no, si investe in una direzione contraria.
Tutto il percorso dei Patti di Comunità e delle comunità educanti, che pure Napoli aveva anticipato, ormai è stato smantellato, perché l’istituzione pubblica ha preferito la tranquillità dei protocolli ai percorsi dal basso di integrazione vera con i soggetti del privato sociale e con le scuole
E devo dire che anche in questa città, che pure ha anticipato tutta la riflessione sui patti educativi d’Italia, perché quando il ministro Patrizio Bianchi ha inserito nella relazione ministeriale i Patti Educativi di Comunità, l’ha fatto anche perché in questa città si erano sperimentati. Tutto quel percorso lì è stato smantellato, perché ancora una volta l’istituzione pubblica ha preferito la tranquillità dei protocolli alla messa in repertorio dei percorsi dal basso di integrazione vera con i soggetti del privato sociale e con le scuole, oppure ancora da chi gestisce le risorse che arrivano sui territori, non in termini di restituzione di servizi collettivi, ma in una dinamica di confusione tra diritti e favori, usando le risorse pubbliche per costruire consenso. Questo sta avvenendo, ancora adesso, in questa città. Quell’esperienza lì è stata smantellata.
Napoli, verso l’infinito e oltre
Io vivo in questa città da 30 anni, credo che questa città avesse in sede gli antidoti straordinari per far sì che potesse governare da solo le sue contraddizioni. Ma oggi, invece, nella narrazione pubblica, in parte vera, della città lanciata “verso l’infinito e oltre”, quando qualche ragazzo o ragazza di qualche margine s’accorge che sulle navicelle che ti portano oltre l’infinito ci sono posti soltanto in prima classe, si arrabbia. Perché si sente ancora per una volta non riconosciuto dalle politiche. Perché questa è una città in cui i margini sono sempre i margini, in cui non è vero che – non oggi, almeno – lo sviluppo importante e turistico culturale della città sgocciola sugli ultimi. Perché il lavoro che fanno i ragazzi e le ragazze in questa città è un lavoro spesso a 300, 400 euro almeno al mese, è un lavoro che serve per sopravvivere, ma che non ti dà la prospettiva di andare davvero verso un futuro differente.
Napoli oggi nella narrazione pubblica è una città lanciata verso l’infinito e oltre. Ma su quelle navicelle che ti portano oltre l’infinito, ci sono posti soltanto in prima classe. E quando un ragazzo di qualche margine se ne accorge, si arrabbia
E allora attenzione, perché se in questo meccanismo non troviamo degli antidoti per ridurre le diseguaglianze che possono prodursi anche in un momento positivo per la città – perché è vero che in questo momento c’è un racconto positivo su questa città – rischiamo che per la prima volta si rompano i legami che oggi consentono all’ultimo, al primo e al medio di abitare lo stesso palazzo e in qualche modo di riconoscersi. Perché le politiche vanno nella direzione della separazione. Che cosa sono le “zone rosse” se non il tentativo di eliminare dai centri i margini, perché oggi i centri non li devono neanche più incontrare i margini. La distanza e l’indifferenza oggi sono diventati strumenti di potere, di mantenimento di potere da parte dei primi.
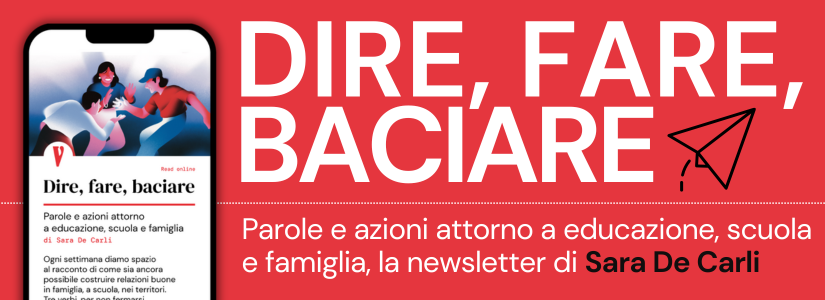
Di isole e arcipelaghi
Io penso che una città come Napoli merita invece di essere al centro anche dal punto di vista della capacità di gestire questi processi positivi in maniera meno disuguale. Allora da questo punto di vista, per rispondere alla domanda, io penso che oggi ci sono tutte le carte, perché poi questa è una città che è fatta di tante magnifiche isole: oggi noi siamo a Foqus, ma qui vicino ci sono i Quartieri Spagnoli, c’è Maestri di Strada, ci sono alcuni istituti scolastici che fanno un lavoro straordinario nelle periferie, c’è Officine Gomitoli… c’è un sacco di gente che fa cose straordinarie, ma il problema è che queste isole non riescono neanche a fare arcipelago. Al massimo fanno rete per vincere qualche progetto. Ma quelle non sono alleanze. Le alleanze sono un’altra cosa. Le alleanze sono dei luoghi dove io condivido una prospettiva, una finalità, e su quella costruisco la co-costruzione di processi. E qui di nuovo servirebbe un pubblico forte, che governi questi processi, perché senza il pubblico noi siamo condannati allo straordinario, la dico così: io mi sono stufato di essere straordinario. Io voglio che le cose che faccio diventino politiche, ordinarie pubbliche, perché solo così diventano sistema e solo così possono ridurre le diseguaglianze.
Foto dei Quartieri Spagnoli, di Anna Spena
17 centesimi al giorno sono troppi?
Poco più di un euro a settimana, un caffè al bar o forse meno. 60 euro l’anno per tutti i contenuti di VITA, gli articoli online senza pubblicità, i magazine, le newsletter, i podcast, le infografiche e i libri digitali. Ma soprattutto per aiutarci a raccontare il sociale con sempre maggiore forza e incisività.


