Scuola
Mille docenti per gli studenti stranieri nelle scuole. Una vera svolta?
Il decreto Scuola e Sport lo ha previsto e il decreto Organici lo ha messo in pratica: da settembre nelle scuole arriveranno 937 docenti specializzati nell'insegnamento dell’italiano per gli studenti stranieri. Luci e ombre di una possibile svolta. Alan Pona, ex insegnante di italiano L2: «Non si commettano gli errori fatti col sostegno: non diventino gli insegnanti degli stranieri»

Quasi mille insegnanti arriveranno nelle scuole italiane, a partire da settembre, per affiancare gli alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, nell’apprendimento dell’Italiano. È quanto previsto già dal cosiddetto “Decreto Scuola e Sport (Decreto legge 71/2024), che dedica l’articolo 11 alle “Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri”. Misure che ora diventano operative, con il decreto sugli organici, che nei giorni scorsi ha definito e dettagliato la ripartizione di questi docenti specializzati in “Lingua italiana per discenti di lingua straniera” (classe di concorso A-23): 937 in tutto, di cui 751 destinati al primo ciclo e 186 al secondo ciclo. Come previsto dal decreto, destinatarie dell’assegnazione saranno le classi in cui gli alunni stranieri con competenze linguistiche inferiori al livello A2 rappresentano almeno il 20% del totale. La distribuzione è determinata dall’incidenza stessa degli alunni con cittadinanza non italiana: in testa la Lombardia (oltre il 25% del totale nazionale), seguita da Emilia-Romagna (12,5%), Veneto (10.5%) e Lazio (9,1%). Il maggior numero di insegnanti di italiano per stranieri sarà destinato alla Lombardia (182), al Lazio (99), alla Toscana (82), all’Emilia-Romagna (70) e al Veneto (65).
Cosa c’è di nuovo?
È la prima volta che docenti di italiano specializzati per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri vengono inseriti, in modo strutturato, all’interno delle scuole statali. I numeri sono ancora bassi, com’è evidente, ma di “svolta” si può in effetti parlare. Fino a questo momento, infatti, questi insegnanti si trovavano soprattutto nei Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti (Cpia), peraltro in misura insufficiente rispetto alla domanda: circa due docenti per ciascuno di questi centri, frequentati per lo più da giovani e adulti stranieri. Erano anche presenti nei centri di accoglienza, o nei servizi privati e convenzionati destinati a supportare e accompagnare gli stranieri – tra cui molti minori stranieri non accompagnati – nei percorsi di inclusione sociale, a partire appunto dall’apprendimento della lingua italiana. Ora, per la prima volta, quasi 1.000 insegnanti saranno presenti all’interno delle scuole statali del primo e del secondo ciclo. La novità, insomma, è innegabile.
«Questa è integrazione». Ma è proprio sicuro?
Il ministro Valditara ha infatti annunciato con soddisfazione e orgoglio l’inserimento di questi docenti nelle scuole, a partire da settembre, rivendicando il proprio impegno fattivo per l’inclusione. Anche commentando gli ultimi dati Invalsi, ha fatto notare che, se da un lato la dispersione scolastica a livello nazionale è scesa sotto il 10%, la percentuale triplica tra gli studenti stranieri (oltre il 30%): «Un terzo di questi ragazzi rischia di non avere futuro», ha detto. E riferendosi al decreto e alle novità introdotte, ha osservato che «così si fa vera integrazione, non con le chiacchiere demagogiche».
Ma è proprio così? O non c’è il rischio che l’integrazione sia solo uno slogan, per nascondere una realtà diversa, simile a quella che spesso tocca agli insegnanti di sostegno e ai “loro” studenti? Lo abbiamo chiesto ad Alan Pona, ex insegnante di italiano L2, prima come collaboratore diretto del comune di Prato poi con il terzo settore, successivamente tutor del servizio del comune e da pochi giorni consulente esterno del comune proprio per l’insegnamento dell’italiano agli studenti stranieri. Una lunga esperienza, la sua, vissuta in uno dei territori italiani che, in questo campo, rappresentano un’eccellenza, per le risposte messe in campo di fronte alla sfida posta dalla forte incidenza di popolazione straniera.
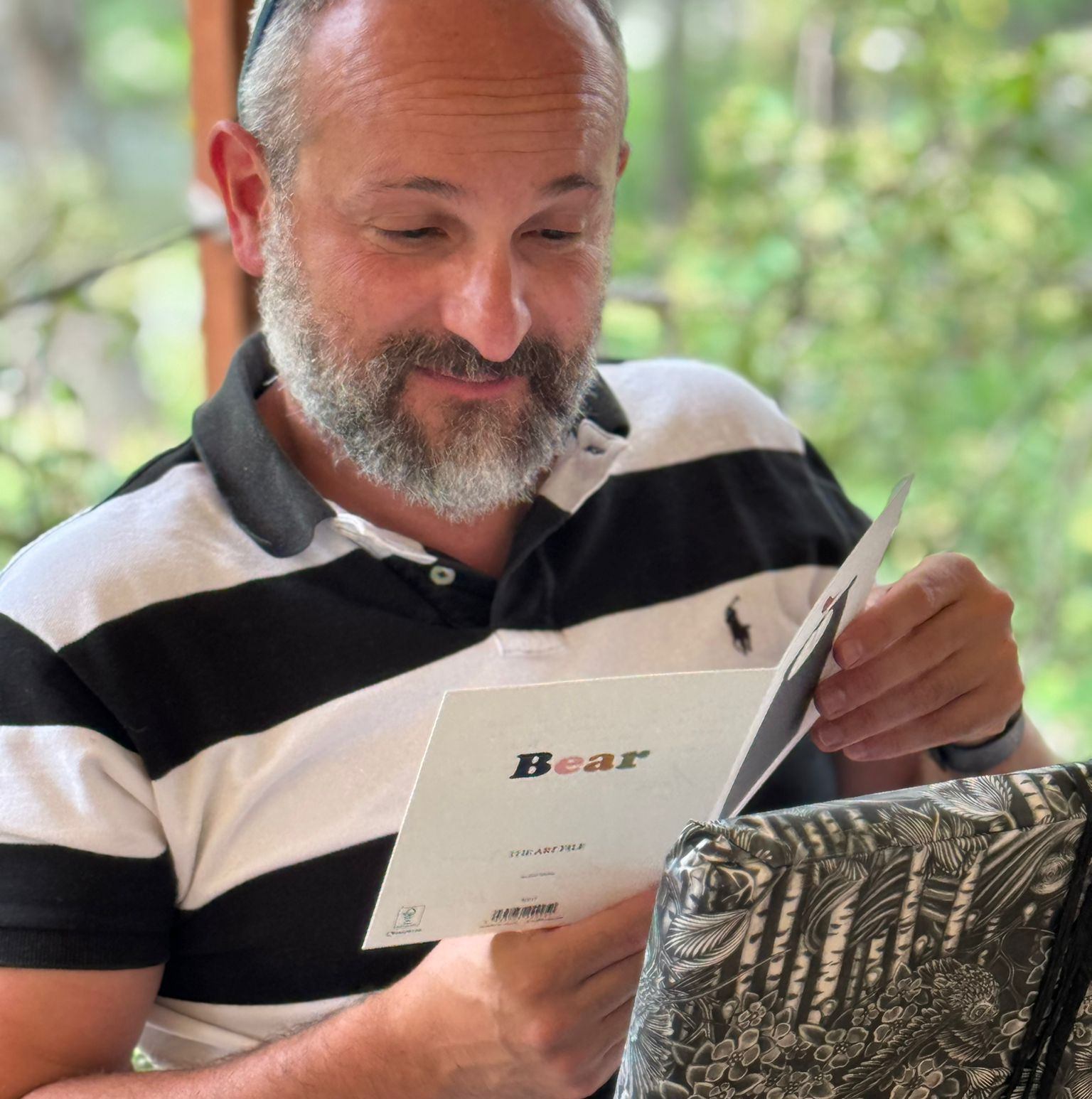
Pona ha seguito passo passo il decreto che ha portato a questa novità e ha interloquito direttamente con il ministero, portando il suo contributo per migliorarlo. Il suo punto di vista è quello di un insegnante che lavora in «una scuola meravigliosamente plurale ed eterogenea» e che sa quanto siano «fondamentali docenti specializzati». Ma sa anche quanto sia facile sbagliare e perdere così l’occasione di avere una buona legge e indirizzare efficacemente energie e risorse. Per questo, mentre il decreto era ancora in attesa di essere convertito in legge, ha trasmesso un documento a Camera e Senato, avanzando alcune richieste di modifica, che in parte sono state accolte. Ma in parte no. Una modifica fondamentale è proprio frutto anche di quel documento e riguarda i numeri: «Sulla base della prima stesura, gli insegnanti A 23 dovevano essere riservati alle classi che avessero oltre il 20% degli alunni stranieri neo-arrivati. Questo avrebbe ridotto moltissimo il numero nelle scuole, per cui abbiamo chiesto (anche tramite Anci) e ottenuto che il decreto fosse corretto, includendo anche chi, pur presente in Italia da più tempo, abbia competenze linguistiche in italiano ancora molto basse, cioè inferiori al livello A2. – spiega – Restano però tante e significative criticità».
Le sei criticità
Pona ne indica sei, in particolare.bLa prima riguarda proprio l’organico: «Valditara aveva promesso personale aggiuntivo, ma in realtà, soprattutto in alcune scuole secondarie di secondo grado, i docenti A-23 andrebbero a sostituire altro organico di potenziamento, costringendo i presidi a compiere scelte spesso complicate».
Il secondo problema è quello della misurazione delle competenze: «In italia abbiamo quattro enti certificatori riconosciuti dallo Stato: le Università per stranieri di Siena e Perugia, Roma Tre e la società Dante Alighieri, che hanno formato un consorzio e si occupano di testing ad alti livelli. Nel documento, chiedevamo che questi enti fossero incaricati di produrre un test di rilevamento delle competenze, per individuare i bisogni delle scuole e capire il livello linguistico degli studenti con retroterra migratorio. La richiesta non è stata ascoltata: questo significa che le scuole dichiarano livelli linguistici che in effetti non possono misurare, in assenza di uno strumento standardizzato e centralizzato».
La terza criticità riguarda la scuola primaria, dove «questa figura professionale di fatto non è prevista dal decreto, che la riserva a scuole medie e superiori». Il quarto punto critico è che «non c’è una riflessione sul valore del plurilinguismo e della convivenza delle differenze nelle scuole, ma solo sulle criticità che gli studenti stranieri portano nella scuola». La quinta criticità è che «non c’è alcun tentativo di potenziare i Cpia, a cui si chiede tanto, senza però dare alcun tipo di rinforzo».
L’ultima criticità, che però è quella più significativa e preoccupante, riguarda il compito dell’insegnate A-23 e le modalità in cui dovrà svolgerlo. È in questa ambiguità che si innesta il dubbio e il timore che possa diventare «il docente degli stranieri – osserva Pona – sulla falsariga della pessima esperienza degli insegnanti di sostegno, troppo spesso trasformati in “docenti degli studenti con disabilità”. Gli uni come gli altri, invece devono lavorare dentro la classe e con la classe, sia per un motivo ideologico (non ci piace l’idea di “portare fuori”), sia per ragioni di efficacia: portare soltanto fuori dall’aula serve a poco e non arricchisce né l’alunno che viene portato fuori, né tantomeno la classe, privata dell’opportunità offerta dall’incontro con l’altro». Ciò non esclude che «possa esserci anche una funzione didattica fuori dalle classi, per esempio per assicurare ai neo-arrivati un primo “bagno linguistico”, ma l’importante è che l’attività successiva si svolga principalmente in classe e in compresenza con i colleghi del consiglio di classe, spesso purtroppo ancora non preparati a lavorare né sull’italiano della comunicazione di base né sull’italiano come lingua dello studio. Non dobbiamo commettere gli errori che sono stati commessi con il sostegno – raccomanda Pona – Il bello di questa legge è che l’insegnamento dell’italiano agli studenti stranieri diventa responsabilità della scuola e non solo del terzo settore, come è stato finora. Il terzo settore, a sua volta, continuerà a fare e dare tanto nella scuola, a partire dalla mediazione con le famiglie. Ma l’insegnamento dell’italiano spetta ai docenti della scuola: a tutti, non solo ai docenti specializzati, che devono essere invece professionisti di supporto alla classe e ai colleghi».
Le testimonianze
Valentina di Cesare lavora all’istituto comprensivo “Sorelle Agazzi” di Milano: una scuola che definisce «normalmente multietnica, in cui la metà degli studenti sono nati in Italia ma sono di origine straniera. Sarebbero italiani, se avessimo una legge diversa. Ma ci sono anche tanti ragazzi che arrivano dall’estero, i nuovi arrivati: Nai, così si chiamano. Ed è con loro che lavoro, per insegnare la lingua italiana». Un lavoro cercato e scelto, perché l’incontro con il diverso era nel suo sangue abruzzese: «Mio nonno era un conciatore di pelli grezze, un lavoro che nella mia famiglia si ripete da generazioni, e non v’era giorno che nella sua casa o nel suo magazzino non entrasse un operaio serbo o bosniaco, un commerciante turco, un venditore greco – racconta – Il più delle volte, dopo il lavoro, mio nonno li invitava a pranzo e mia nonna cucinava per loro. Alcuni si trovavano da noi solo di passaggio, altri restavano per mesi o anni e facevano in modo che le loro famiglie venissero a vivere in Italia. Le mie prime amiche di giochi erano bimbe balcaniche con capelli biondi e pelle lattescente, non parlavamo la stessa lingua ma giocare ci riusciva a meraviglia».

Così, quando molti anni dopo Valentina si iscrisse alla Facoltà di Lettere, «decisi di avventurarmi tra discipline che colmavano il desiderio sempre più grande di incontrare la diversità dal mio mondo: Mediazione culturale, Antropologia, Storia dell’Islam, Storia dei paesi balcanici». Dopo la laurea, il master in Didattica dell’Italiano L2 all’Università per Stranieri di Siena. «La mia classe era una Babele, i miei compagni provenivano da decine di luoghi del mondo: dall’Iran all’Armenia, dall’Argentina a Cipro. Dopo quell’anno a Siena e un periodo di stage in una scuola statale, ho iniziato subito a lavorare come facilitatrice linguistica e insegnante per conto di cooperative sociali, che lavoravano per lo più nelle scuole abruzzesi». Oggi, mentre parliamo al telefono, Valentina è in Abruzzo per le vacanze ma vive a Milano, è diventata mamma e continua a fare il lavoro che sente suo: nel frattempo, ha conseguito la certificazione CEDILS dell’Università di Venezia, la certificazione di esaminatore CILS dell’Università per Stranieri di Siena e ha lavorato come insegnante di italiano L2 sia in Italia che all’estero, fino all’arrivo a Milano, dove si occupa del laboratorio di Italiano L2 nella grande, popolatissima scuola Sorelle Agazzi. «Amo questo lavoro perché mi mette a contatto ogni volta con persone nuove, con le loro storie e i loro desideri. Lo amo perché posso ogni volta cambiare, crescere, apprendere nuove strade, assorbire nuovi spunti, variare punti di vista. Insegnando italiano a studenti stranieri di ogni età e provenienza, ho imparato a confrontarmi sempre di più con le diversità in termini di esigenze, bisogni, desideri, aspettative. Ho appreso anche però, e ne ho conferma ogni giorno, che sono molto più numerosi i sentimenti e le istanze che accomunano tutti noi umani, e ciò mi rende ancora più felice di fare questo mestiere».
Oggi accoglie con soddisfazione e sollievo la notizia dei docenti A-23 in arrivo nelle scuole: «Anche se sono davvero pochi – osserva – Nella mia scuola ne arriverà solo uno ed è una scuola con cinque plessi. Però è un bene che l’insegnamento dell’italiano agli studenti stranieri finalmente non sia solo appannaggio di bandi e progetti, come è stato finora. Io stessa lavoro all’interno di progetti: ho sempre un incarico, grazie anche all’impegno del preside in questo campo, ma è giusto che ora ci siano dei posti per noi insegnanti specializzati. Io all’epoca non feci il concorso, perché c’erano cinque posti in tutta la Lombardia. Ora, alla prossima occasione, lo farò, ma nel frattempo continuerò a lavorare con i ragazzi che arrivano da ogni parte del mondo di ogni momento dell’anno. Tenerli sempre in classe? Impossibile, ve lo dico da addetta ai lavori. Ho vissuto in Francia e ho visto che il loro modello funziona, penso che dovremmo fare lo stesso: un primo periodo tutti insieme, i ragazzi che non parlano l’italiano e poi, dopo aver acquisito le competenze minime, allora sì che possono inserirsi nelle classi. Altrimenti, catapultati in una classe in cui non capiscono una parola, non solo si demotivano e si scoraggiano, ma sviluppano un odio verso la scuola che spesso li porta all’abbandono. Intanto, questo decreto è una goccia nel mare, ma almeno qualcosa si muove».
Chiara Cervoni lavora da oltre 20 anni come insegnante di italiano per stranieri (L2) presso il Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri di Roma. Ama questo lavoro e da qualche tempo amministra un gruppo Facebook dedicato proprio a questa professione – Insegnanti di italiano L2/LS – che conta quasi 20 mila iscritti. Ha conseguito diverse certificazioni, ma alla luce della sua lunga esperienza sa con certezza «la certificazione non basta, a mio avviso, se non ci si aggiorna costantemente e non si sta al passo coi tempi. Ci sono molte complessità in questo lavoro, di cui si parla poco: i docenti si trovano ad affrontare un ambiente multiculturale con studenti che, spesso, non conoscono nulla della cultura e della lingua italiana. Naturalmente questa è una complessità, ma al tempo stesso è anche l’aspetto più affascinante di questo mestiere. Per questo, a coloro che, dal prossimo mese, si troveranno inseriti nelle scuole con questo incarico, raccomando tanta pazienza, ma soprattutto curiosità e desiderio di apprendere: non siamo solo insegnanti, ma anche noi dobbiamo essere a nostra volta studenti e predisporci ogni giorno a imparare cose nuove».
Foto in apertura da Unplash (Kenny Eliason). Foto interne fornite dagli intervistati
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
