Sustainability Portraits
Quelle sliding doors che portano al caffè sostenibile
Nella nuova puntata della rubrica di VITA, Veronica Rossi di Lavazza ripercorre le «gioie e le fatiche» di essere una sustainability (senior) manager. Dai primi stage professionali in giro per l’Europa ai 33 progetti della fondazione aziendale che oggi supportano 190mila coltivatori nel mondo. Con lo sguardo rivolto alle responsabilità delle grandi imprese nella transizione ecologica
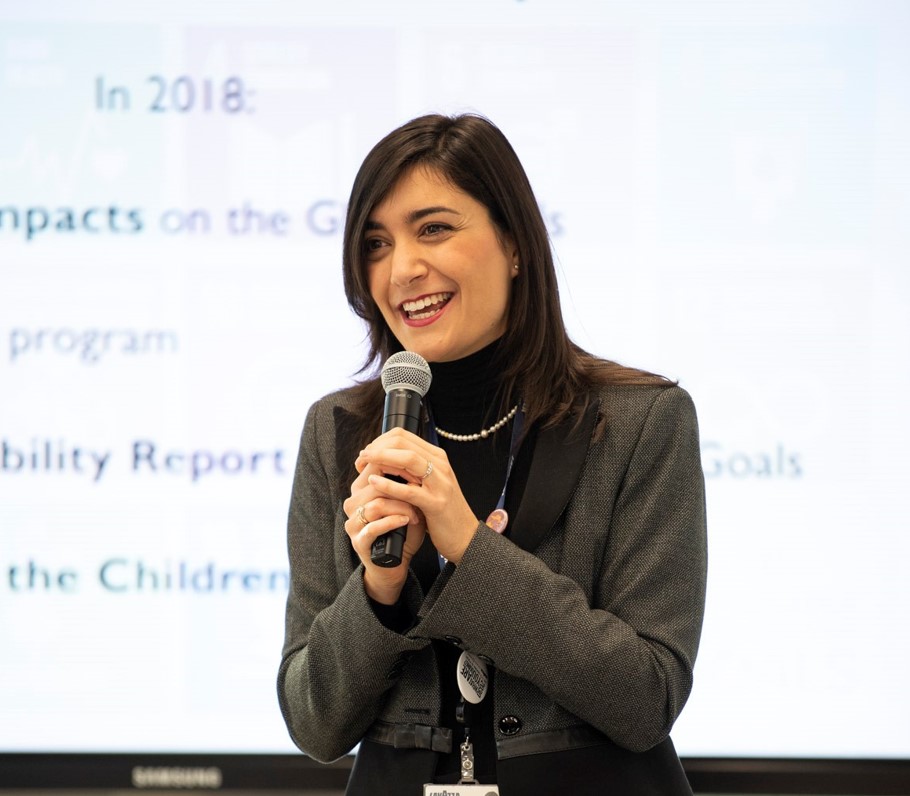
È quasi d’obbligo cominciare la nuova puntata di questa rubrica citando l’attore Nino Manfredi che, in uno spot diventato icona, ricordava: «Il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?». Ma non tanto perché si parlerà dell’azienda che l’ha lanciato negli anni Ottanta. Bensì perché Veronica Rossi, sustainability senior manager di Lavazza, con responsabilità anche nella Lavazza foundation, raccontando le aspirazioni professionali e le scelte di vita che l’hanno portata a incrociare il mondo della tazzina, esprime con passione e leggerezza le «gioie e le fatiche» dell’essere una manager che si occupa di sostenibilità. Senza dimenticare che di fronte ci sono sfide epocali, quali i cambiamenti climatici.
Come è partito il suo percorso?
Coltivavo il sogno di diventare ambasciatrice o di lavorare in un’organizzazione internazionale. Così, dopo la laurea specialistica in scienze politiche alla Sapienza di Roma, sono andata a Ginevra, per uno stage in una ong che si occupava di diritti dei minori presso l’Onu e poi a Bruges, in Belgio, per un master al Collegio d’Europa in politica e amministrazione dell’Unione europea.
E dopo?
Hanno cominciato ad aprirsi le sliding doors che mi hanno condotta ad oggi.
Quali?
Tornata a Roma, da brava millennial ho collezionato un altro stage, allo European counsel of foreing relation, think tank di politica internazionale. Poi, ecco la porta girevole, sono tornata inaspettatamente a Bruxelles, per un Blue book presso la Commissione europea.
Com’è andata?
Mi ero candidata, senza successo, per una posizione nell’unità di corporate social responsibility presso la Direzione generale ex industria – Grow, poi sono stata “ripescata”. Durante il master a Bruges, infatti, avevo frequentato un corso opzionale proprio sulla Csr e questo riferimento, presente nel curriculum, si è matchato con la ricerca dei selezionatori.
Quali altre porte si sono aperte dopo?
Lavoravamo al primo Multistakeholder forum della Commissione europea sulla Csr, in programma a febbraio del 2015. Unica italiana del team, dovevo invitare le grandi imprese di casa nostra e Lavazza aderì all’invito. Da qui è nata l’opportunità di tornare in Italia, a Torino, dove l’azienda intendeva strutturare un ufficio di sostenibilità.
Una relazione cresciuta negli anni.
Siamo partiti con la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità, nel giugno del 2015, durante Expo, per i 120 anni dell’azienda. Poi abbiamo creato il dipartimento di sostenibilità vero e proprio, che venne affidato a Mario Cerutti, tuttora Chief sustanibalilty officier di Lavazza ma che, per 30 anni, era stato a capo degli acquisti della materia prima e dunque vantava una conoscenza eccezionale della filiera. Oggi siamo in 13 e ci occupiamo di relazioni istituzionali e sostenibilità.
Lei era già in sintonia con questi temi?
È un lavoro che mi si è cucito addosso. Le tematiche dell’inclusione sociale, della parità e dell’attenzione alle fragilità hanno sempre fatto parte della mia vita, fin da quando insegnavo danza come volontaria nell’oratorio dei salesiani. Mi ritengo fortunata a svolgere un lavoro che ha caratterizzato la mia vita e il mio approccio agli altri. E l’antica passione per il mondo della diplomazia mi ha dato gli strumenti per svolgere il lavoro di oggi.

In una battuta, qual è l’approccio alla sostenibilità per il Gruppo Lavazza?
Una vocazione di famiglia. A volte non ci si pensa, ma Lavazza è prima di tutto un cognome che, da sempre, ma in particolare negli ultimi 20 anni, si occupa di sviluppo sociale e ambientale delle comunità produttrici di caffè. Fare sostenibilità in Lavazza significa perciò portare avanti la legacy della famiglia.
Quando c’è l’endorsement della proprietà è più facile fare sostenibilità?
Le esperienze di network fatte in questi anni, in particolare nel consiglio direttivo dei Sustainability Makers, l’associazione che riunisce i manager della sostenibilità in Italia, mi hanno fatto rendere conto che per noi la strada è più spianata. Si tratta di portare avanti la visione del nostro motto A goal in every cup che deve permeare tutte le aree del business.
Che cosa significa in concreto?
Che quella tazzina di caffè deve contenere un caffè coltivato, trattato, offerto ai clienti e raccontato in un certo modo.
Può fare un esempio nel campo della sostenibilità sociale?
In questo, sono molto rilevanti i progetti della Fondazione, tra i quali vorrei citare A cup of learning, grazie al quale dal 2017 i nostri formatori vanno in giro per il mondo a insegnare il mestiere di assaggiatore, barista o tecnico della qualità a ragazzi fragili che vivono in contesti di scarso sviluppo, da Calcutta all’Uganda al Guatemala.
Quali sono le altre attività della Fondazione Lavazza?
Per una visione complessiva, vorrei ricordare i 33 progetti in 20 Paesi produttori di caffè attivi oggi, che coinvolgono più di 190mila contadini nel mondo, sempre grazie a partnership locali, un tratto distintivo per il nostro modo di fare sostenibilità.
Come si svolgono?
Anzitutto, si aiuta la comunità a coltivare un caffè buono, cioè in grado di generare opportunità economiche, attraverso un training specifico sulle tecniche agricole. Poi si cerca di produrre un caffè inclusivo, ossia che tenga conto del grande ruolo delle donne e dei giovani nella filiera.
Perché questa sottolineatura?
Il mondo del caffè, dall’Etiopia alla Colombia, è una coltura essenzialmente familiare, che presenta due grossi gap: le donne raccolgono più del 70% dei chicchi, ma sono proprietarie solo del 30% dei terreni, il che tende a escluderle, anche per ragioni socioculturali, dai training agricoli. Noi invece cerchiamo di farle partecipare, coinvolgendole nella condivisione delle responsabilità.
L’altro gap?
Sono i giovani: c’è un grande spopolamento delle campagne, con un progressivo invecchiamento della popolazione dei coltivatori di caffè. I progetti che abbracciamo mirano a introdurre la tecnologia nella coltivazione anche per farli rimanere.
Dopo la coltivazione e l’inclusione, qual è il terzo aspetto distintivo dei vostri progetti?
Produrre un caffè compatibile con l’ambiente. Anche in questo caso realizziamo una serie di training con tecniche di agricoltura forestale.
Quanto durano i vostri progetti?
Almeno due o tre cicli di vita della pianta, quindi fino a nove anni: non è per legare a noi stessi le comunità, anzi, i progetti nascono per renderle più indipendenti, ma il tempo è indispensabile per poter seguire la crescita della piantagione, il suo mantenimento e, infine, l’accesso al mercato.
Mancano le competenze interne?
In questo tipo di agricoltura familiare, la capacity building è un tema decisivo. Ci sono abitudini difficili da superare, un esempio classico è il rifiuto della potatura della pianta che, invece, la rende più produttiva. Quando il contadino vede che il vicino migliora grazie all’aiuto esterno ricevuto da un agronomo, si convince più facilmente a provare.
Le comunità che aiutate sono inserite nella vostra catena di fornitura?
Ogni progetto della Fondazione si basa sulle necessità della comunità locale. Noi lavoriamo in luoghi con potenzialità da valorizzare, dove il caffè non c’è ancora, oppure va ripristinato o reso più produttivo. Riavviata la piantagione, si valutano due opzioni: sviluppare il mercato locale, che è sempre la scelta consigliata, oppure, in qualche caso, quando le comunità sono più strutturate e capaci di produrre un caffè di alta qualità, verificare l’opportunità di entrare nella filiera di fornitura Lavazza. Ma non è lo scopo primario.
Lavazza occupa un posto anche nella storia della pubblicità. Come i temi della sostenibilità si sono inseriti in questa storia?
Oggi tutti parlano di sostenibilità. Questo è anche un rischio. Lavazza cerca di farlo nella maniera più delicata possibile, con il giusto tono di voce. Evitando qualsiasi tipo di banalizzazione del tema. Noi preferiamo raccontare le attività già svolte, senza fare annunci, utilizzando anche linguaggi molto curati. Ne sono esempi il calendario che, da più di dieci anni, parla di sostenibilità attraverso gli scatti di fotografi andati nelle comunità supportate dalla Fondazione, o la campagna L’Italia che vorrei sulla Qualità rossa, realizzata con Save the children.
Qual è la sfida più aperta nel campo della sostenibilità ambientale per le aziende internazionalizzate come la vostra?
In generale, oggi, il problema di ogni azienda è affrontare il cambiamento climatico che sta mettendo in crisi molte filiere, alcune delle quali sono prossime ad affrontare la sfida della loro stessa esistenza. Nel nostro caso, il tema è l’impegno comune a prendersi cura delle varietà della pianta di caffè che si stanno riducendo ma che sono fondamentali tanto per la biodiversità quanto per l’industria.
Come la affrontate?
Cercando di instaurare relazioni forti e stabili con i nostri fornitori anche dal punto di vista degli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico. Lavazza non possiede piantagioni di proprietà, si affida a chi le coltiva.
Concludiamo con una provocazione che lanciamo spesso in questa rubrica: la sostenibilità quale tema sovra competitivo per eccellenza, lei cosa ne pensa?
Nel nostro campo è fondamentale lavorare insieme, senza che questo significhi raccontarsi dei segreti industriali. Confrontarsi con gli altri, scambiarsi esperienze aiuta moltissimo. Ambiti associativi come i Sustainability makers sono una palestra di idee, relazioni e stimoli anche pratici per strutturare il proprio dipartimento o per elaborare modelli di governance della sostenibilità. Eventi quali il Salone della Csr contribuiscono ad avvicinare i giovani a questo ambito professionale. Sono iniziative che personalmente mi hanno aiutato moltissimo sia nell’arricchimento formativo sia condivisione delle gioie e delle fatiche dell’essere una sustainability manager.
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.
