Idee Welfare
«Non possiamo permettercelo»: il mantra della politica che rincorre gli algoritmi al posto dei bisogni
Se è vero che le risorse non sono infinite, allora è proprio la politica che deve decidere dove e per cosa destinarle. È la politica che deve disegnare un nuovo orizzonte, un’architettura di welfare capace di guardare oltre l’emergenza, capace di porsi domande generative: che società vogliamo?

«Non possiamo permettercelo. Non possiamo accogliere tutti. Non ci sono i soldi per sostenere questo sistema di welfare.» Frasi che negli ultimi mesi si ripetono con frequenza disarmante. Frasi che non solo pongono un freno, ma tracciano una visione limitata e miope del nostro presente.
Ci si ferma al “non si può fare”, senza interrogarsi su cosa vogliamo costruire davvero, quale società, quale futuro, quale idea di convivenza. È il linguaggio di una politica che ha smarrito la capacità di visione, che rincorre gli algoritmi dei social anziché i bisogni delle persone. Una politica che, invece di affrontare le contraddizioni del presente, si rifugia nel racconto rassicurante dell’impossibilità: non ci sono risorse, non ci sono alternative. Eppure, la politica è proprio il luogo delle scelte. Se è vero che le risorse non sono infinite, allora è proprio la politica che deve decidere dove e per cosa destinarle. È la politica che deve disegnare un nuovo orizzonte, un’architettura di welfare capace di guardare oltre l’emergenza, capace di porsi domande generative: che società vogliamo? Quali diritti intendiamo tutelare? Che cultura di convivenza vogliamo trasmettere alle generazioni future?
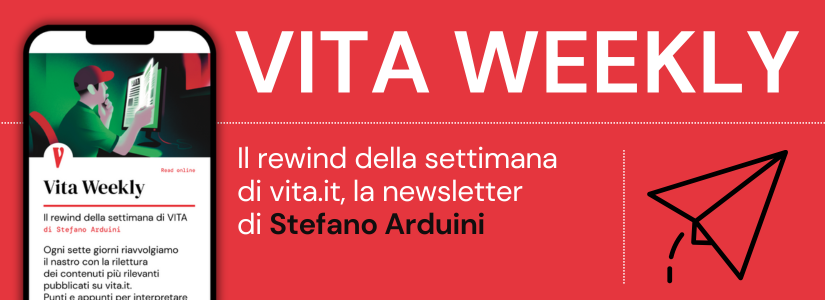
Una politica incapace di generare sogni, che rinuncia alla progettazione, è una politica già sconfitta. Ridotta a pura gestione dell’esistente, perde la sua vocazione più alta: immaginare il domani. Lo ricordava Victor Hugo: «Ciò che oggi è utopia, domani sarà carne e ossa.» Una frase che richiama la responsabilità collettiva a non smettere di sognare, anche quando il presente sembra segnato dalla frantumazione e dalla paura. In questa tensione tra utopia e concretezza, tra crisi e speranza, può nascere una politica rigenerativa. Una politica che riscopre il valore delle comunità relazionali, antidoto alle spinte espulsive, e delle identità solidali, come radici storiche e culturali da cui ripartire. La chiusura identitaria, che oggi si presenta come rassicurante, produce in realtà distanza, sospetto e odio. Solo un’idea aperta e inclusiva di comunità può restituire il senso della prossimità, della cura reciproca, della fiducia sociale.
Questi due assi – la relazione e la solidarietà – sono la base di un progetto politico che non ceda alla tentazione populista della semplificazione, ma che sappia tracciare scelte di campo tra chi costruisce ponti e chi innalza barriere; tra chi guarda al bene comune e chi difende esclusivamente interessi particolari.
Oggi abbiamo bisogno di una politica che faccia resistenza. Resistenza alla retorica della paura, all’individualismo sistemico, al disincanto. Una politica che riscopra la “cosa pubblica” non come un’entità distante, ma come qualcosa che ci riguarda profondamente. Perché il disinteresse alla politica, il qualunquismo spicciolo, lasciano spazio a logiche di mercificazione dei diritti e a derive autoritarie travestite da efficienza. Abbiamo bisogno di una politica lenta, che pensi prima di agire, che si fermi ad ascoltare, che non si pieghi alla velocità dei social e al cinismo delle breaking news. Una politica che si faccia spazio di sogno condiviso e di progettazione collettiva. Che sappia guardare alle fragilità non come zavorre, ma come luoghi generativi, da cui partire per ricostruire legami, visioni, possibilità. Perché ogni giorno, la linea tra chi “ce la fa” e chi resta indietro si fa più sottile, e il rischio di finire nel silenzio delle statistiche è concreto per moltissime persone, anche per noi. Un’Europa che si limita a difendere i propri confini tradisce la sua vocazione originaria. Abbiamo bisogno di un’Europa che torni a essere spazio di pace, di diritti, di cultura sociale condivisa, che si pensi come federazione.
Il sistema di welfare europeo, nato dalle macerie della guerra, ha garantito decenni di stabilità e di progresso. Ma oggi è sotto attacco, travolto da una retorica della “sostenibilità economica” che rischia di svuotare l’idea stessa di bene comune. Il welfare non è un lusso. È un patrimonio collettivo. È una scelta di civiltà. Il populismo, al contrario, vive di paura, divide il mondo in “noi” e “loro”, alimenta una guerra permanente, fatta di parole, sospetti, confini. Ma siamo già interconnessi, le nostre economie, le nostre storie, le nostre fragilità, continuare a raccontare l’altro come un nemico è una pericolosa illusione. Serve una politica che torni ad abitare i luoghi della cultura, del confronto, della cura. Che non veda i cittadini come target o numeri, ma come persone da ascoltare. Una politica che rivaluti le fragilità come risorse, e che le assuma come bussola per ripensare i modelli di sviluppo. In questo tempo fragile, continuo a credere che l’umanità ci salvi. Che le relazioni ci tengano vivi. Che il sogno politico sia ancora possibile. Che la brace della speranza, sotto la cenere della crisi, possa riaccendere un futuro condiviso. Sì, forse siamo Don Chisciotte. Ma non perché inseguiamo illusioni. Siamo Don Chisciotte perché non ci accontentiamo della realtà così com’è. Perché sappiamo che la verità non è solo ciò che appare, ma ciò che si cela dietro: le persone, le storie, le possibilità. Perché abbiamo il coraggio di guardare oltre lo sguardo, di scavare, di accompagnare le anime nel loro cammino. In questo cammino, fare politica diventa un atto d’amore. Un atto di resistenza poetica, per dirla con Pasolini. Un atto che tiene insieme sogno e concretezza. Perché il cambiamento, in fondo, è sempre politico e poetico insieme.
L’autore di questo articolo è direttore generale della Comunità di Capodarco dell’Umbria
Credit foto: Unplash
Vuoi accedere all'archivio di VITA?
Con un abbonamento annuale potrai sfogliare più di 50 numeri del nostro magazine, da gennaio 2020 ad oggi: ogni numero una storia sempre attuale. Oltre a tutti i contenuti extra come le newsletter tematiche, i podcast, le infografiche e gli approfondimenti.


