Idee Relazioni
L’ordine perduto: quando il diritto sostituisce la fiducia
Senza fiducia, ogni relazione dovrebbe essere mediata da controlli, verifiche e sanzioni. Ed è esattamente questo che sta accadendo nelle società contemporanee. Di fronte alla complessità crescente delle relazioni sociali e alla moltiplicazione delle lealtà potenzialmente conflittuali, la risposta è stata quella di affidare all'ordinamento giuridico il compito di regolare ogni aspetto dell'esistenza

Simone Weil, nel suo ultimo e più importante lavoro La prima radice (ed italiana SE, 1990; Le Lettere, 20021), sviluppa una concezione dell’ordine sociale che merita di essere riletta alla luce delle trasformazioni contemporanee. Per la filosofa francese, l’ordine rappresenta uno dei bisogni fondamentali dell’anima umana. L’ordine, nella visione weiliana, è “un tessuto di relazioni sociali tale che nessuno sia costretto a violare obblighi rigorosi per adempierne altri”. È una definizione densa, che merita di essere scomposta e analizzata, perché in essa si cela una critica radicale al modo in cui le società moderne hanno progressivamente sostituito le relazioni fiduciarie con apparati giuridici sempre più pervasivi.
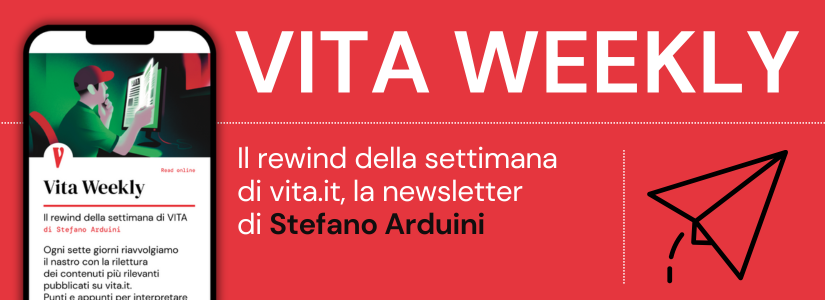
Il punto di partenza di Weil è antropologico: l’altro con cui siamo in relazione, se incontrato nella dimensione dell’attenzione (oggi diremmo della cura, o della premura), esprime dei bisogni a cui per ognuno diventa un obbligo rispondere. Oggi gli esseri umani vivono all’interno di molteplici relazioni, che diventano cerchi di appartenenza e di lealtà. Siamo contemporaneamente figli, genitori, lavoratori, cittadini, amici, membri di comunità. Ciascuna di queste appartenenze genera doveri e aspettative, spesso in tensione tra loro. Il datore di lavoro che richiede straordinari nel fine settimana entra in conflitto con i doveri verso la famiglia; l’amico che chiede un favore può scontrarsi con gli obblighi professionali; la comunità locale che domanda partecipazione può confliggere con le esigenze di carriera. In una società ordinata, secondo Weil, queste tensioni trovano una composizione attraverso un tessuto di istituzioni che rende possibile l’armonizzazione dei diversi doveri. Ora, ciò che Weil descrive come ordine presuppone necessariamente la fiducia. Costruiamo le relazioni fiduciosi che l’altro rispetti quell’ordine, nei termini della Weil. Potremmo dire oggi quell’insieme di norme, istituzioni e valori che regolano la vita sociale. La fiducia è sempre un’istanza asimmetrica: chi si fida si espone al rischio del tradimento (G.Simmel, Filosofia del denaro, 1907). Ci fidiamo quando non abbiamo certezze complete, ma possediamo ragioni sufficienti per credere che l’altro non ci deluderà. Ci affidiamo convinti che il principio di reciprocità possa esserne una garanzia sufficiente per evitare il tradimento. La fiducia è quindi sempre un salto, un atto che va oltre le garanzie razionali, e proprio per questo è costitutiva del legame sociale. Senza fiducia, ogni relazione dovrebbe essere mediata da controlli, verifiche e sanzioni.
Il contratto diventa lo strumento principe per gestire le relazioni, dalla sfera lavorativa a quella affettiva, dai rapporti commerciali a quelli educativi. Ma questo spostamento dall’ordine fondato sulla fiducia all’ordine fondato sul diritto non è neutrale: esso presuppone e al tempo stesso rafforza una specifica antropologia, quella dell’individuo calcolatore che massimizza il proprio interesse personale
Ed è esattamente questo che sta accadendo nelle società contemporanee. Di fronte alla complessità crescente delle relazioni sociali e alla moltiplicazione delle lealtà potenzialmente conflittuali, la risposta è stata quella di affidare all’ordinamento giuridico il compito di regolare ogni aspetto dell’esistenza. Il contratto diventa lo strumento principe per gestire le relazioni, dalla sfera lavorativa a quella affettiva, dai rapporti commerciali a quelli educativi. Ma questo spostamento dall’ordine fondato sulla fiducia all’ordine fondato sul diritto non è neutrale: esso presuppone e al tempo stesso rafforza una specifica antropologia, quella dell’individuo calcolatore che massimizza il proprio interesse personale. Quando l’interesse personale diventa il principio guida riconosciuto e legittimato, la fiducia diventa impossibile. Come posso fidarmi di qualcuno se so che, nel momento in cui dovrà scegliere tra la lealtà nei miei confronti e il proprio vantaggio, sceglierà inevitabilmente il secondo?
Il problema non è semplicemente teorico. L’affidare al mondo giuridico il peso dell’ordine sociale comporta conseguenze concrete e spesso perverse. In primo luogo, la giustizia non è uguale per tutti: l’accesso agli strumenti giuridici dipende dalla disponibilità di risorse economiche e sociali. Per chi può permettersi avvocati migliori, per chi conosce meglio i meccanismi del sistema, per chi ha tempo e denaro per sostenere lunghi contenziosi e pagare spese legali, la giustizia può diventare uno strumento di potere e prevaricazione: il sistema giuridico può essere utilizzato strategicamente per scopi che nulla hanno a che vedere con la giustizia. Le cause per diffamazione intentate non per ottenere riparazione di un danno reale, ma per intimidire e silenziare voci critiche; le denunce strumentali mosse non per far valere un diritto, ma per danneggiare un avversario; i procedimenti avviati con la consapevolezza di essere destinati alla sconfitta, ma con l’obiettivo di logorare economicamente e psicologicamente la controparte. Anche quando questi tentativi falliscono sul piano legale, possono avere effetti devastanti sulla vita delle persone: anni di ansia, costi legali insostenibili, reputazioni compromesse.
L’espansione del diritto a scapito della fiducia ha inoltre un effetto corrosivo sulle relazioni sociali gratuite e solidali. Se ogni prestazione deve essere regolata da un contratto, se ogni cura e premura deve essere codificata e retribuita, cosa ne è degli spazi di gratuità che costituiscono il tessuto connettivo della società? L’aiuto reciproco tra vicini, il sostegno informale tra colleghi, la cura non retribuita all’interno delle famiglie e delle comunità: tutto questo rischia di essere progressivamente compromesso dalla logica contrattuale e dello scambio. E quando anche questi ambiti vengono mercificati e giuridicizzati, si spezza quella rete di relazioni informali che rappresenta, per molti, l’unica forma di protezione sociale realmente accessibile.
Questa trasformazione colpisce in modo particolarmente duro quella che abbiamo chiamato la “netless class”: coloro che, privi di reti sociali solide, di capitale economico e culturale, dipendono strutturalmente dagli altri per la propria sopravvivenza e il proprio benessere. Sono tutti coloro che non possono contare su risorse proprie sufficienti e che quindi hanno bisogno della solidarietà altrui. Per costoro, la sostituzione delle reti fiduciarie con meccanismi contrattuali rappresenta una condanna. Non possono permettersi di far valere i propri diritti attraverso il sistema giudiziario; non hanno potere contrattuale sufficiente per negoziare condizioni eque; dipendono dalla benevolenza di datori di lavoro, proprietari di casa, funzionari pubblici. In assenza di reti sociali di sostegno, in un contesto dove la fiducia è stata sostituita dal contratto e dove il contratto favorisce chi ha più potere, la netless class si trova in una condizione di vulnerabilità estrema. La paura diventa il sentimento dominante: paura di perdere il lavoro, paura di non riuscire a pagare l’affitto, paura di ammalarsi, paura di invecchiare. E la paura rende manipolabili, costringe alla subordinazione, all’accettazione di condizioni inique, alla rinuncia anche ai propri diritti formali per non rischiare rappresaglie informali. Il datore di lavoro che sa di poter pretendere oltre quanto previsto dal contratto senza troppe difficoltà; il proprietario di casa può richiedere altre prestazioni oltre all’affitto a migranti irregolari; il notabile può zittire il giornalista troppo curioso: tutti costoro esercitano un potere che va ben oltre quello apparentemente riconosciuto dalla legge. E lo esercitano proprio perché sanno che la controparte, priva di reti di protezione, non ha alternative reali. La subordinazione diventa così non una scelta, ma una necessità; l’obbedienza non deriva dal riconoscimento di un’autorità legittima, ma dalla consapevolezza della propria impotenza.
Weil aveva intuito tutto questo quando scriveva che l’ordine vero non è quello imposto dall’alto attraverso la forza o la legge, ma quello che emerge da un tessuto di relazioni in cui ciascuno può adempiere ai propri molteplici doveri senza essere costretto a tradirne alcuni per onorarne altri. Un tale ordine presuppone la fiducia reciproca, la consapevolezza di appartenere a una comunità di destino, la presenza di meccanismi di reciprocità che non si esauriscono nello scambio contrattuale. La rappresaglia per chi tradisce la fiducia per il proprio interesse personale è il disprezzo e l’allontanamento dal gruppo. La ricostruzione di un ordine fondato sulla fiducia non è nostalgia per comunità premoderne, tribù o villaggi. Le società contemporanee sono troppo complesse, troppo differenziate, troppo mobili per poter semplicemente tornare a forme di solidarietà tradizionale. Ma questo non significa che dobbiamo rassegnarci a un mondo in cui ogni relazione è mediata dal diritto e dallo scambio. Significa piuttosto che dobbiamo immaginare e costruire nuove forme di fiducia adeguate alla complessità del presente. Significa soprattutto investire nella costruzione e nel mantenimento di quelle reti che permettono alle persone di non dipendere esclusivamente dal mercato e dallo Stato per la propria sopravvivenza. Questo significa valorizzare e sostenere le forme di mutualità e solidarietà che ancora esistono, e crearne di nuove là dove sono venute meno. Significa riconoscere il ruolo essenziale del lavoro di cura, il valore della premura come fondamento etico (l’attenzione di cui parla Weil, che è insieme empatia e risposta concreta). Significa costruire istituzioni che favoriscano la cooperazione piuttosto che la competizione. Una società in cui la fiducia è impossibile è, in ultima analisi, una società che tradisce il bisogno fondamentale di ordine di cui parlava Weil: quell’ordine che permette a ciascuno di vivere una vita piena, adempiendo ai propri molteplici doveri senza essere costretto a tradire se stesso e gli altri. Non è un’utopia: è l’unica alternativa realistica a un mondo in cui la mercificazione e la contrattualizzazione di ogni aspetto dell’esistenza ci condanna all’isolamento e alla paura.
Foto di Blake Weyland su Unsplash
Nessuno ti regala niente, noi sì
Hai letto questo articolo liberamente, senza essere bloccato dopo le prime righe. Ti è piaciuto? L’hai trovato interessante e utile? Gli articoli online di VITA sono in larga parte accessibili gratuitamente. Ci teniamo sia così per sempre, perché l’informazione è un diritto di tutti. E possiamo farlo grazie al supporto di chi si abbona.


